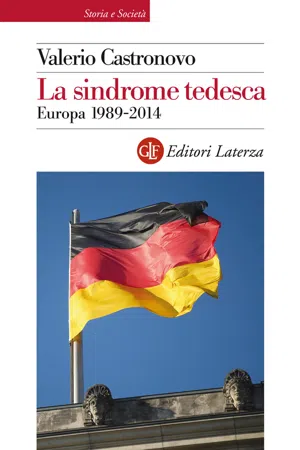I. Da un’Europa all’altra
L’«onesto baratto» della riunificazione tedesca
I colpi di piccone che nel novembre del 1989 sbriciolarono nel giro di pochi giorni il Muro di Berlino non misero fine soltanto alla divisione in due tronconi della Germania, quale era stata sancita all’indomani della disfatta del regime nazista nel secondo conflitto mondiale. Segnarono anche il preludio del crollo dell’impero sovietico. E posero perciò ai paesi euro-occidentali un insieme di problemi altrettanto rilevanti che di impatto immediato a cui erano assolutamente impreparati. Sia perché era dominante il convincimento che tanto la contrapposizione fra Est e Ovest, ereditata dai tempi della Guerra fredda, quanto le ragioni della Realpolitik avrebbero continuato a congelare lo status quo e quindi a esorcizzare anche una questione scabrosa come quella tedesca. Sia perché la crisi di gran parte dei regimi comunisti dell’Est, sfociata nell’avvento di coalizioni pluripartitiche di governo, stava incrinando le fondamenta del Patto di Varsavia e faceva temere, qualora Mosca avesse reagito, che si aprisse una sorta di «vaso di Pandora» dagli sviluppi imprevedibili.
Gorbačëv, sebbene non avesse sbarrato la strada alla svolta politica in corso nei paesi dell’Europa orientale, intendeva mantenere in vita quell’alleanza, simmetrica al Patto Atlantico, che per il Cremlino aveva garantito sino ad allora la propria sicurezza: a meno di rinunciarvi in cambio di determinate condizioni da parte degli Stati Uniti. Esse avrebbero dovuto consistere, in sostanza, nel riconoscimento all’Urss di un ruolo eminente in quella che, dopo la seconda guerra mondiale, era divenuta la sua area precipua di controllo e d’influenza.
Quanto alla prospettiva che la Repubblica federale tedesca (Rft) incorporasse la Repubblica democratica (Rdt), non era un mistero che essa avesse destato forti apprensioni negli altri paesi della Comunità europea. Il ritorno in vita di una grande Germania, con più di ottanta milioni di abitanti e una posizione strategica al centro del Vecchio Continente, avrebbe modificato infatti gli equilibri esistenti all’interno della Cee. Che la Francia non vedesse di buon occhio la riunificazione tedesca, l’aveva confermato il clamoroso viaggio-lampo compiuto in dicembre dal presidente Mitterrand a Berlino Est: quasi a voler dare in extremis un soccorso, confermandone la legittimità, a un regime che pur stava ormai affondando. Tanto assillanti erano i timori diffusi a Parigi di fronte alla ricomparsa, al di là del Reno, di uno Stato tedesco pienamente indipendente ed economicamente vigoroso, che evocava nei francesi gli spettri nefasti del 1914 e del 1939.
Da parte sua, il governo inglese era tutt’altro che entusiasta, come andava dicendo Margaret Thatcher, che la Germania, sconfitta due volte dalla Gran Bretagna, tornasse a costituire, al di là della Manica, un mega-Stato in grado di divenire più robusto e più ricco. Né era frutto solo di un disincantato pragmatismo l’atteggiamento del governo italiano, che sino a quel momento aveva puntato a intensificare i rapporti bilaterali con Bonn per cercare di alleggerire il peso del «condominio franco-tedesco», ma seguitando a ritenere più conveniente lo status quo. «Amo talmente la Germania che ne preferisco due», affermava l’allora presidente del Consiglio Giulio Andreotti.
Tuttavia suscitava, al tempo stesso, non poche apprensioni il rischio che gli ex paesi satelliti dell’Urss sprofondassero nell’anarchia, in un marasma di vaste proporzioni, come c’erano già vari sintomi che stesse per accadere nella penisola balcanica in seguito all’incipiente disgregazione del mosaico nazional-etnico jugoslavo. D’altra parte, non andava escluso il pericolo che i regimi comunisti venissero rimessi sul piedistallo da un intervento militare in extremis dell’Unione Sovietica, dato che Gorbačëv rischiava di essere sbalzato di sella dalla vecchia nomenclatura del partito e dai vertici dell’Armata Rossa, recisamente avversi tanto al suo indirizzo riformista quanto al definitivo sganciamento da Mosca di paesi soggetti interamente al Cremlino sino a pochi mesi prima.
In una situazione ancora incerta e densa di incognite la ricomposizione delle due Germanie avrebbe potuto perciò costituire un importante tassello per la stabilizzazione dell’Europa centro-orientale in concomitanza con le «rivoluzioni di velluto» in corso nei paesi dell’Est verso un nuovo sistema politico-istituzionale. Era questo il punto di vista dell’amministrazione americana e del suo presidente, il repubblicano George Bush.
Ma, secondo Washington, sarebbe spettato alla Comunità europea agire di conseguenza, e non già agli Stati Uniti, per evitare che al Cremlino prendessero il sopravvento sugli innovatori le fazioni più ortodosse e intransigenti, che mordevano il freno di fronte alle aperture politiche di Gorbačëv. D’altronde, non ci si poteva aspettare che bastasse «togliere il coperchio al comunismo per realizzare la democrazia», come aveva ammonito Ralf Dahrendorf nell’agosto 1989, quando avevano cominciato a manifestarsi all’Est i primi segnali di uno sgretolamento dei vecchi regimi al potere.
Senonché, per tutto il corso del 1990, Francia e Gran Bretagna rimasero alla finestra di fronte alla questione tedesca, malgrado fossero titolari, in quanto potenze covincitrici dell’ultimo conflitto, dei cosiddetti «diritti di riserva», ancora vigenti, sulla sorte della Germania nella sua configurazione complessiva, oltre che dell’alto controllo interalleato di Berlino. Allo stesso modo si comportarono nei riguardi dell’esigenza, pur conclamata a parole, di aiutare l’Europa dell’Est a uscire senza scosse dirompenti dal collasso del «socialismo reale», perché ciò avrebbe richiesto innanzitutto un piano impegnativo di assistenza economica, in seguito allo sfaldamento del Comecon.
Fu così il cancelliere tedesco Helmut Kohl a gestire direttamente i negoziati con Gorbačëv che posero le premesse per la riunificazione tedesca. Leader dei cristiano-democratici tornati al potere nel 1982, non aveva mai perso la speranza (come d’altronde i suoi predecessori, che l’avevano alimentata attraverso la «Ostpolitik») di riedificare prima o poi uno Stato unitario della nazione tedesca. E pur di realizzarla adesso d’un balzo, mentre provvide a sostenere da Bonn la campagna elettorale, nella Germania orientale, di un’eterogenea coalizione di centro che nell’aprile 1990 vinse la prima e ultima consultazione democratica della Rdt, intavolò trattative con Mosca, in stretta collaborazione con Bush e tenendo pressoché all’oscuro del loro andamento, sin quasi all’ultimo, gli altri governi della Cee. E ciò ben sapendo come essi ritenessero inconcepibile che il destino della Germania venisse deciso senza il loro coinvolgimento, in quanto si trattava in fin dei conti di una questione d’importanza cruciale anche per il futuro della Comunità europea. Uno degli obiettivi politici fondamentali che avevano presieduto alla nascita della Cee era stato infatti quello di reintegrare la Germania federale, risorta alla democrazia dalle rovine del nazismo, entro uno spazio geopolitico definito dalle istituzioni comunitarie e da un insieme di compatibilità multilaterali.
A ogni modo, Kohl andò dritto per la sua strada nella ricerca di un accordo con i sovietici, nonostante fossero venuti crescendo, in alcuni ambienti politici sia a Parigi che a Londra, i sospetti che il cancelliere tedesco fosse disposto, pur di raggiungere i suoi scopi, a staccare la Germania dalla Nato (come Gorbačëv aveva ventilato, sulle prime, in cambio del ricongiungimento fra la Rdt e la Rft). Un’ipotesi, questa, che Kohl in realtà non aveva mai preso in considerazione, a differenza del leader del Partito socialdemocratico Oskar Lafontaine, inizialmente contrario o scettico (a differenza di Willy Brandt) nei riguardi dei progetti di riunificazione.
In pratica Kohl, in un incontro a quattr’occhi avvenuto il 16 luglio nel paese natale del leader sovietico, riconfermato poco tempo prima alla guida del Pcus, ottenne il consenso di Gorbačëv alla riunificazione della Germania, in cambio di dodici miliardi di marchi per il mantenimento temporaneo dei soldati sovietici di stanza nell’ex Rdt e la loro sistemazione in patria, più un prestito senza interessi, e dopo una solenne dichiarazione dei due Parlamenti tedeschi sull’inviolabilità delle frontiere con i paesi contigui stabilite all’indomani dell’ultima guerra. D’altronde, la Thatcher aveva finito nel frattempo per allinearsi sulle stesse posizioni del governo americano, rinunciando ai suoi iniziali propositi ostruzionistici. E Mitterrand si era dovuto rassegnare, dopo il successo riportato dai partiti alleati all’Unione cristiano-democratica (Cdu) di Kohl nelle prime elezioni libere tenutesi nella Germania orientale.
Il «colpo maestro» compiuto da Kohl dal punto di vista diplomatico aprì la strada a un trattato fra Bonn e Mosca, firmato il 12 settembre col placet di Washington. Tre settimane dopo, il 3 ottobre 1990, si giunse così alla riunificazione della Germania con l’incorporazione della Rdt nella Repubblica federale tedesca.
Il fatto che la Germania avesse riacquistato in pieno la propria sovranità valse a rafforzare le analoghe aspettative di libertà e indipendenza dei paesi dell’Est, quando non era ancora del tutto escluso il rischio di una loro ricaduta all’indietro, di un ritorno nell’orbita del Cremlino, tanto più dopo le dichiarazioni «revanchiste», o comunque ambigue, di alcuni esponenti politici di Bonn sui confini con la Polonia. Sia Bush che Gorbačëv dovettero perciò ammonire il governo tedesco affinché mettesse le briglie a certe sortite inammissibili quanto controproducenti e si affrettasse a siglare un apposito trattato con Varsavia basato sul riconoscimento delle frontiere fra i due paesi stabilite dopo il 1945. Ciò che avvenne il 14 novembre 1990.
Mentre la Repubblica federale tedesca cominciò a procedere nell’annessione della Rdt, senza promulgare una nuova Costituzione ma estendendo semplicemente le proprie leggi, gli altri Stati della Comunità europea si trovarono a dover districare una matassa di problemi estremamente aggrovigliata, in cima ai quali stavano innanzitutto quelli di ordine economico. Occorreva infatti aiutare concretamente i paesi dell’Europa orientale affinché non si propagasse fra i loro nuovi dirigenti, a capo di partiti e movimenti di differenti matrici e d’incerta ispirazione, un’ondata di sconforto e risentimento nei confronti dell’Occidente, tale da far rimpiangere i passati regimi.
Ma non si poteva più confidare, come era avvenuto nel 1948, nel varo da parte degli Stati Uniti di un consistente programma di soccorsi, analogo a quello del Piano Marshall. E per quanto riguardava la Cee c’erano poche risorse su cui contare. Se il governo francese si diceva pronto a fare la sua brava parte, l’Italia e i paesi del Benelux erano assai più cauti; per non parlare della Gran Bretagna. Quanto al governo tedesco, era già impegnato sino al collo a soccorrere i Länder orientali da cui stava riversandosi in quelli occidentali un fiume di gente in cerca di un’occupazione. Non è che la struttura economica della Rdt fosse decrepita, come si era seguitato a dipingerla al di qua del Muro. Senonché, dopo il collasso dei paesi comunisti dell’Est, erano venuti a mancare all’industria tedesco-orientale importanti mercati di sbocco per le sue produzioni. Inoltre, l’adozione di un cambio alla pari fra il marco occidentale e quello orientale (nonostante la loro forte differenza di valore), voluta fin dal febbraio 1990 da Kohl per ragioni politiche, assicurando un maggior potere d’acquisto alla popolazione dell’ex Rdt stava favorendo la penetrazione delle imprese tedesco-occidentali con l’offerta di un’ampia gamma di beni di consumo. Per giunta, il sistema di sicurezza sociale vigente sino ad allora nella Germania orientale, basato su prestazioni gratuite e generalizzate, non poteva essere recepito tale e quale da quello della Rft ancorché fosse più avanzato rispetto al welfare in atto nei suoi partner occidentali.
Pertanto non c’era in ballo solo il problema di assistere i paesi dell’Est, al fine di concorrere alla loro rinascita democratica: ciò che portò la Cee a promettere loro determinati «accordi regionali», analoghi a quelli sottoscritti tra gli anni Sessanta e Settanta con le ex colonie e alcuni paesi in via di sviluppo. C’era anche il problema di agevolare senza scosse la riunificazione della Germania. Contrariamente alle iniziali previsioni eccessivamente ottimistiche dei dirigenti tedesco-occidentali, risultava assolutamente improbabile che si potessero integrare, in tempi ravvicinati e con sicure prospettive di benessere, diciassette milioni di tedeschi dell’Est.
Era comunque evidente che la ricostituzione di una grande Germania ponesse soprattutto una questione cruciale d’ordine politico. Perciò, secondo Mitterrand, era indispensabile legare più strettamente il nuovo Stato tedesco alle istituzioni comunitarie europee. E lo si sarebbe potuto fare mediante un’unione economica e monetaria. D’altronde, essa era già prevista nel piano concepito dal presidente della Commissione europea Jacques Delors e di cui s’era cominc...