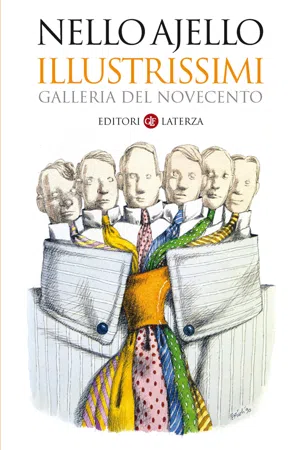
- 352 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile sull'app)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Tra sapienza e ironia, le istantanee degli uomini e delle donne di cultura che ci hanno insegnato a vivere e di quelli che ci hanno addestrati a sorridere.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
Al momento è possibile scaricare tramite l'app tutti i nostri libri ePub mobile-friendly. Anche la maggior parte dei nostri PDF è scaricabile e stiamo lavorando per rendere disponibile quanto prima il download di tutti gli altri file. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Base e Completo
- Base è ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un’ampia varietà di argomenti. Accedi alla Biblioteca Base con oltre 800.000 titoli affidabili e best-seller in business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce Read Aloud standard.
- Completo: Perfetto per studenti avanzati e ricercatori che necessitano di accesso completo e senza restrizioni. Sblocca oltre 1,4 milioni di libri in centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specializzati. Il piano Completo include anche funzionalità avanzate come Premium Read Aloud e Research Assistant.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi usare l’app Perlego sia su dispositivi iOS che Android per leggere in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo — anche offline. Perfetta per i tragitti o quando sei in movimento.
Nota che non possiamo supportare dispositivi con iOS 13 o Android 7 o versioni precedenti. Scopri di più sull’utilizzo dell’app.
Nota che non possiamo supportare dispositivi con iOS 13 o Android 7 o versioni precedenti. Scopri di più sull’utilizzo dell’app.
Sì, puoi accedere a Illustrissimi di Nello Ajello in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Scienze sociali e Cultura popolare. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
Scienze socialiCategoria
Cultura popolareM
Mino Maccari. L’ultimo individuo
«In errore fu chi disse – che di Grosz sono fanatico. – Preferisco Henri Matisse, – Renoir mi è più simpatico». Mino Maccari non amava parlare della propria formazione artistica se non scherzando. Da bambini, diceva, tutti usano i pastelli: io ho continuato. E invece – in contrasto con questo amabile understatement – il pittore di Colle Val d’Elsa era un acutissimo giudice d’arte. È stato Carlo Ludovico Ragghianti, in un libro intitolato «Il Selvaggio» di Mino Maccari, ad attribuirgli la scoperta precoce di alcuni fra i pittori italiani più celebrati del Novecento italiano, da Carrà a Rosai a De Pisis. «Non si può dimenticare», aggiungeva, «che per anni la conoscenza nostra di Morandi è stata affidata al ‘Selvaggio’», cioè alla rivista inventata, scritta, titolata, istoriata da Mino Maccari fra gli anni Venti e Quaranta. Non stupisce, perciò, trovare nel catalogo di una mostra di Maccari una serie di lettere indirizzate a Giorgio Morandi. Lettere «da pittore a pittore». Piene di consigli, notizie, appunti di lavoro.
Scherzando scherzando, infatti, Maccari lavorava. Senza accorgersene, si direbbe. «Il lungo dialogo di Maccari con il suo tempo» (così s’intitola la mostra cui accennato) è un riassunto sedimentato di questo suo attivismo. Duecentottantasette opere, che vanno dal 1921 al 1989 – anno in cui il pittore morì novantunenne –, percorrono una delle esistenze più singolari e istruttive del Novecento italiano. E, insieme, consentono di assistere a una narrazione attenta e pungente dei «casi nazionali». È possibile, ci si domanda assistendo allo spettacolo, testimoniare settant’anni di cultura d’un paese, raccontarne le mode, ispezionarne i regimi, senza ripetersi mai? Ed ecco la risposta, frantumata in centinaia di personaggi ilari e stravolti, figurine ammiccanti, sagome parodistiche: sì, Maccari ci è riuscito.
Non è stato soltanto un osservatore longevo. È stato soprattutto un diagnostico precoce. Aveva diciannove anni quando partecipò alla Grande Guerra come ufficiale d’artiglieria di campagna (un «campagnino», diceva lui). Ne aveva ventiquattro alla marcia su Roma, un’avventura da boy-scout cui si mescolò al grido di «Roma o Orte» per sottolinearne la fatuità casereccia e l’oltranzismo incosciente. Aveva compiuto ventisei anni allorché diede inizio all’avventura del «Selvaggio», che del fascismo fu insieme amante deluso e persecutore tenace. Il tutto con una disposizione d’animo irresistibilmente bizzarra. «Coltivavamo», raccontava il pittore, «un dannunzianesimo di provincia con goccioline mussoliniane. Facevamo una specie di fleboclisi all’Italia con l’illusione di riformarla». Osservando alcuni dipinti della serie Dux il visitatore si troverà immerso a capofitto nel fascismo «secondo Maccari». Per lui, quel regime è una specie di soufflé imbottito di facce di gerarchi. Li trafigge da ogni lato. Li disegna marziali e morbidi, più pomposi di quei borghesi dell’Italietta che hanno voluto annientare a sorsate di olio di ricino. In una parola, li trova impresentabili. Poveri di stile. «Solo al mare, al lago, o al fiume», proclama uno dei suoi stornelli, «il gerarca ha del costume».
Dalle pareti della mostra di Grosseto ci viene incontro un testimone attento. Un diarista repentino. Un cronista metafisico. Un faceto storico del presente. Passando, nel dopoguerra, da un regime di stendardi e pennacchi a una democrazia in tonaca, il sorriso non lo abbandonò. E neppure la perfidia. Vederlo lavorare era un diletto prezioso. In un angolo della redazione del «Mondo», o nello studio di via del Leoncino, nella casa romana di via di Villa Emiliani o in quella di campagna al Cinquale, il pictor minimus sembrava agitato da un moto umoristico continuo. Sotto le sue mani l’universo diventava una caricatura, a volte nascostamente amara. Il suo tema (o bersaglio) era adesso la Roma sventata e vernacola di un interminabile dopoguerra, piena di commendatori panciuti, dame multicolori e patetiche passeggiatrici. Una capitale che si espande (così la trafiggeva il pittore-epigrammista) «a macchia d’olio santo», mentre in Campidoglio «la storia si riprete».
Con il passare dei decenni, restava fedele al proprio autoritratto: arguto, graffiante e bonario come tante sue tavole a colori. Il visitatore va in cerca del profilo di Maccari, che occhieggia auto-dipinto fra due ritratti di «ammiratrici»; o s’intravede in un’incisione, con sotto l’avvertenza: «Bell’uomo, ma rimbambito»; oppure lo si scorge mentre una ragazza nuda gli regge la tela a mo’ di cavalletto. Proverbialmente piccolo di statura, accoglieva nelle sue litografie personaggi statuari: da Eric von Stroheim in divisa teutonica all’interminabile De Gaulle con il kepì.
Negli ultimi mesi di vita, da esile la sua sagoma era davvero diventata minima, come se il tempo fosse ancora riuscito a limarne il superfluo. Lo notai in una primavera dei tardi anni Ottanta, andando a visitarlo nella palazzina dei Parioli dove abitava, in un pomeriggio malinconico. Maccari era stanco. Aveva disegnato per qualche ora. Quando gli domandai, per provocarne l’ingegno surreale, quali fossero stati i suoi maestri, rispose pronto: «Gargantua e Pantagruel». Tanti anni prima questo ingegno rabelesiano aveva composto una curiosa epigrafe in versi: «Sia celebrato un triduo – per la morte dell’ultimo individuo».
Che alludesse a se stesso? Contemplando ancora una volta che cosa Mino Maccari abbia dipinto, e come, il dubbio mi torna.
Curzio Malaparte. Fra Benito e Palmiro
A Capri, nella villa che fu dello scrittore, va in scena uno spettacolo intitolato Malaparte, casa come me, firmato da Massimo Luconi e liberamente ispirato a vari libri malapartiani, dalla Pelle a Mamma marcia: sei repliche, promosse dal Comune di Capri e dal teatro Metastasio di Prato. La quale Prato si prepara a commemorare lo scrittore suo concittadino con una sequela di manifestazioni celebrative.
Al di là delle intenzioni, andrà verificato se l’effetto di tante iniziative consisterà nel riportare provvisoriamente in auge il personaggio e la sua leggenda, o – il che sarebbe preferibile – nel sottoporre a un vero esame critico un letterato fra i più vivaci del nostro secolo. Operazione che rivela già in partenza le sue difficoltà.
Dopo che Geno Pampaloni nel 1989, sull’«Espresso», dedicò a Curzio Suckert Malaparte un articolo molto meditato ed equanime, non risulta infatti che sullo scrittore pratese siano apparsi contributi di pari livello. Nel fare un censimento dei giudizi espressi su di lui lungo i decenni, il critico poté registrare, sul positivo, quasi soltanto un’affermazione di Piero Gobetti, che nel 1925, definiva Malaparte «la più forte penna del fascismo». Più distaccato, come il passaggio del tempo lo aiutava ad essere, Pampaloni individuava nell’autore di Kaputt quella «compenetrazione esistenziale di arte e vita» che fu il grande tema del decadentismo europeo: gli accreditava lo sforzo di affermarsi come un «letterato di massa» e rintracciava nella sua scrittura «la memoria della buona prosa dei classici». Tutto ciò ne faceva, in sostanza, uno «scrittore più complesso dell’immagine estroversa di cui si compiacciono i suoi detrattori e di cui si compiaceva egli stesso».
Ammissioni non da poco, cui dovrà necessariamente rifarsi chi vorrà rivalutare Malaparte al di là dei tanti giudizi sferzanti che lo hanno colpito in vita, e ancora rischiano di liquidarne la memoria. «Malaparte è un fabbricante di bolle di sapone terroristiche», sbottò Emilio Cecchi dopo aver letto La pelle. In un articolo scritto in occasione della morte, Eugenio Montale se ne sbarazzò con la qualifica di «rimescolatore di idee». E a chi volesse sincerarsi sulla natura di quelle idee viene in aiuto Alberto Asor Rosa che nel suo Scrittori e popolo osservò che, col Malaparte degli esordi – quello della Cantata dei cenciaioli pratesi e delle Avventure d’un cavaliere di sventura –, «si combatte l’Italia falsamente europea con i miti dell’Italia veramente provinciale. E il risultato è ancora una volta incredibilmente arretrato». Lo stesso Gobetti, a suo tempo, aveva decisamente mitigato la sua ammirazione per il talento malapartiano mediante un’obiezione morale: lo aveva chiamato «eroe di corte» (e la corte era quella di Mussolini).
Durante il regime, e anche dopo, per «denigrare» Malaparte bastava d’altronde registrare le sue stesse pose, nelle quali un eccesso di narcisismo assumeva tinte inconsciamente autolesionistiche. Senza poter prevedere le giravolte demagogiche che egli avrebbe compiuto dopo il tramonto del Duce, già Gramsci nei Quaderni del carcere scriveva: «Il carattere permanente del Suckert è uno sfrenato attivismo, una smisurata vanità e uno snobismo camaleontico: per avere successo è capace di ogni scelleraggine». Politicamente lo scrittore rientrava, a suo parere, in quella pattuglia di fascisti «romantici», alla Farinacci, i cui connotati gli sembravano essere «una fantasia squilibrata, un brivido di eroici furori, un’irrequietezza psicologica» da romanzo d’appendice.
Romanzeschi furono gli ultimi tredici anni di vita di Malaparte, fra il ’44 e il ’57, anno della morte. Romanzeschi, ma non più dei precedenti. Vitalista, becero, specialista in operazioni autopubblicitarie, si poteva supporre che avvicinandosi ai cinquant’anni lo scrittore ritenesse d’aver corso avventure in numero sufficiente da placarlo: supposizione fallace. Aveva partecipato giovanissimo alla Grande Guerra riportandone una tubercolosi dalla quale non sarebbe mai del tutto guarito. Era stato un fascista sui generis, vicino a Farinacci, appunto, amico di Galeazzo Ciano e animato da avversione per Italo Balbo. Aveva glorificato Mussolini in versicoli di così incontinente entusiasmo da sfiorare il dileggio («Spunta il sole, canta il gallo – O Mussolini monta a cavallo») ed era stato spedito al confino, nel 1933, un po’ per gioco («Roba da ridere», definì il provvedimento sua sorella Mimmina Suckert, anni fa, in un’intervista a Daniela Pasti).
Diventato direttore della «Stampa» nel ’29, s’era trovato accanto col ruolo di redattore capo il suo coetaneo ed amico Mino Maccari, componendo «l’accoppiata più clamorosa del giornalismo italiano di quegli anni», come ha scritto Arturo Tofanelli. Aveva avuto, com’era inevitabile, numerosi duelli: gli specialisti ne contano sedici, e ricordano quello che nel ’26 lo oppose a Pietro Nenni, due volte ferito ma risoluto nel non riconciliarsi. Aveva diretto una rivista importante, «Prospettive», che dal ’37 al ’43 fece conoscere in Italia testi qualificati della letteratura europea. Giornalista d’indubbia efficacia, s’era distinto nei reportages di guerra, specie sul «Corriere della Sera», in varie riprese, fra il ’32 e il ’43. Nonostante la sua tubercolosi («alle donne ci si poteva accostare poco: il medico glelo aveva persino proibito», testimonia la sorella), aveva collezionato amanti: con Virginia Agnelli, la madre di Gianni, ebbe una relazione durata nove anni e troncata dalla morte precoce di lei.
Poteva bastare? Certo che no. Qualcosa dei tempi nuovi lo affascinava. Tra fascisti e comunisti aveva sempre avvertito un’analogia profonda: nella Technique du coup d’Etat non aveva definito i primi «catilinari di destra» e i secondi «catilinari di sinistra»? Come Mussolini, tra ammirazione e tradimenti, era stato l’astro della sua gioventù, Togliatti lo fu della sua maturità. Giordano Bruno Guerri – autore nel 1980 di una documentata biografia di Malaparte, L’Arcitaliano – ha messo le mani sulla tessera del Pci numero 1583701, rilasciata a Roma il 12 aprile 1957, intestata a Curzio Malaparte e firmata da Togliatti in persona. Insieme alla tessera, la sorella dello scrittore, Maria Suckert, ha consegnato a Guerri una lettera «d’accompagno» in cui Togliatti esprimeva giudizi assai benevoli verso il destinatario e la sua «tormentata vita di combattente». Il ritrovamento della tessera fa nascere un enigma. Padre Virginio Rotondi, il gesuita cui si attribuisce la conversione religiosa dello scrittore, morto il 19 luglio 1957, ha sostenuto di recente sul «Corriere della Sera» che Malaparte negli ultimi giorni di vita strappò in sua presenza la tessera del Pci. Quella trovata da Guerri è dunque un duplicato? Oppure padre Rotondi ricorda male?
È un mistero di portata modesta se paragonato a quello, più generale, costituito dai rapporti fra due persone così diverse: il capo del maggior partito comunista dell’Occidente e uno degli scrittori politicamente più malfamati d’Europa. I due s’incontrarono a Capri il 10 aprile 1944. Togliatti era appena rientrato dalla Russia. Cominciarono a chiacchierare. Parlando, il capo comunista fissava attento il suo interlocutore. «Le sue pupille erano chiare e grigie», racconterà Malaparte. «Il bianco era come la base invisibile di quello sguardo grigio. Ora, io penso che gli uomini che sanno nascondere un occhio bianco sotto uno sguardo blu, grigio o nero, sappiano osservare più che guardare». Fu amore a prima vista.
Togliatti tenta d’inserire Malaparte nei ranghi della stampa comunista. Nel colmo dell’estate 1944 Velio Spano, direttore dell’«Unità», invita lo scrittore a Firenze perché racconti dal vivo l’epopea partigiana che libererà la città dai tedeschi. Unica cautela, l’adozione di uno pseudonimo: Gianni Strozzi. Prudenza insufficiente: riconosciuto in quegli articoli lo stile di Malaparte, i letterati del partito – Mario Alicata in testa – protestano con Togliatti in maniera veemente. Lo scrittore viene messo in quarantena.
La quarantena dura a lungo. Sono gli anni del romanzo La pelle – ambientato, con frequenti tocchi macabri e granguignoleschi, nella Napoli dell’immediato dopoguerra – e della rubrica Battibecco che lo scrittore redige per «Tempo Illustrato», e nella quale trova sfogo quel «sovversivismo reversibile» che Mario Isnenghi denunzierà come tipico del suo modo di essere. Nascono nuovi couplets malapartiani come quelli che componeva negli anni Venti. In qualcuno di essi, si può leggere perfino un vaticinio di vittoria per il Pci: «Impara Alcide che la storia – non si fa più col solito incenso. – La libertà non è fatta di gloria – com’ebbe a dir Camillo Benso... – Se ancora un po’ te ne stai a vedere – Palmiro vien che ti ruba il mestiere». Su tutto prevale il solito disprezzo dell’Arcitaliano per gli italiani ordinari: «Eh, gli italiani sono donne oneste – ma di far la puttana han tutti il vizio».
Togliatti non gradisce. Recensendo su «Rinascita» il volume Battibecco, che raccoglie epigrammi e rime satiriche, scrive che Malaparte potrebbe intitolarlo, anziché Battibecco, Batticulo. Il calembour non è dei più raffinati.
Ristabilire i rapporti sembrerebbe difficile. Malaparte ci riesce ancora una volta, attraverso un tramite giornalistico. Nei primi mesi del ’57 «Vie Nuove» e «L’Unità» lo mandano in Cina, inviato speciale. Scrive articoli coloriti, encomiastici.
Al ritorno, viene ricoverato nella clinica romana Sanatrix. Cancro. Sui giornali, le fotografie mostrano accanto al suo letto Togliatti, Secchia, Lajolo, Fanfani, Tambroni. Il domenicano Felix Morlion e il gesuita Virginio Rotondi lo assistono negli ultimi giorni. Rotondi, stabilitosi in una stanzetta accanto a quella dello scrittore, lo battezza e lo cresima dopo averne ottenuta la facoltà da Pio XII, non essendo vescovo. In ultimo lo confessa e gli somministra l’eucaristia.
E i comunisti? Una delle ultime battute di Malaparte fu raccolta da un suo amico francese, in clinica: «Prêtres e marxistes, ils sont toujours là. Ils guettent mon âme» (spiano la mia anima). Una morte, in fondo, da compromesso storico.
Filippo Tommaso Marinetti. La guerra le donne il Duce
Marinetti e la guerra, Marinetti e le donne, Marinetti e la politica. Sono questi i principali temi trattati nelle seicentotrentotto pagine dei Taccuini 1915-1921 del fondatore del futurismo, che la casa editrice Il Mulino pubblica a cura di Alberto Bertoni e con le prefazioni di Renzo De Felice ed Ezio Raimondi.
Quando comincia a scrivere i suoi Taccuini, Filippo Tommaso Marinetti – nato ad Alessandria d’Egitto nel 1876 – ha trentanove anni. È un tempo nevralgico per la storia d’Italia e d’Europa: basti pensare che le esperienze annotate nel journal marinettiano comprendono la Grande Guerra e l’agitato triennio successivo. Le reazioni del diarista di fronte a questo complesso di eventi permettono di saggiare il reale valore di tante parole d’ordine futuriste sulla politica, l’arte, la storia. Nel descrivere la guerra – la quale rappresenta certamente il pezzo forte del volume – Marinetti ha poco dell’Artista con la a maiuscola. Il suo tono è confidenziale, antiretorico, attento ai particolari più minuti e curiosi. La scrittura è veloce, martellante, spesso «nominale» (fatta cioè di frasi senza verbo). L’intenzione letteraria non si sovrappone ai fatti, piuttosto vi si adegua. Non si tratta d’altronde di un’opera letteraria compiuta e limata, ma di un testo che Raimondi definisce «ipotetico», «provvisorio», come un materiale cinematografico ammucchiato prima di un vero montaggio.
È in un certo senso un libro corale, ma di una coralità non religiosa. Negli uomini che vivono al fronte non c’è traccia di sacralità, di misticismo, di esaltazione in senso dannunziano. E la guerra marinettiana non somiglia neppure a quella grande «esperienza interiore» di cui parlava Ernst Jünger. Negli stati d’animo che lo scrittore registra si trova più spavalderia che eroismo, più sfrontatezza che coraggio, più grottesco moderno che tragedia classica. È presente il rischio, ma senza la sua mitologia.
Già nell’introduzione a un libro di Marinetti, L’alcova d’acciaio (che è del ’21, e racconta anch’esso la Grande Guerra), Alfredo Giuliani aveva parlato di una certa fatalità guerriera, di uno spirito quasi musulmano. Ezio Raimondi a proposito dei Taccuini riprende il suggerimento ma precisa che si tratta di un islamismo senza Allah. Come dire che Marinetti diarista è completamento laico, secolarizzato, «scristianizzato». I suoi soldati gridano e cantano oscenità, dicono parolacce. Muoiono anche: e allora il dolore e la crudeltà fanno parte del quadro, ma senza nessun rilievo monumentale.
Le donne che popolano il diario appartengono a tutti i ceti. Attrici come Enif Robert Angelini, amica della Duse, o aristocratic...
Indice dei contenuti
- Prefazione
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- I
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- R
- S
- T
- V
- Z
- Avvertenza