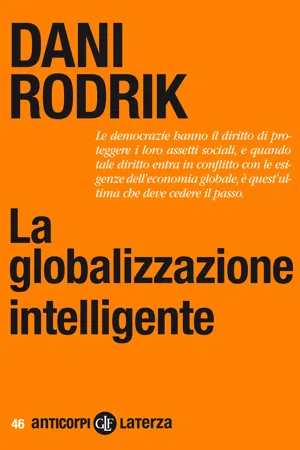XII. Una globalizzazione sensata
Come funzionerebbero nella pratica i principi illustrati nel capitolo precedente? Si possono escogitare regole ragionevoli che rispettino questi principi senza che si scivoli nell’anarchia economica internazionale? E come queste regole affronterebbero il tipo di sfide che l’economia mondiale ha attualmente davanti?
Quest’ultimo capitolo fornisce alcune risposte focalizzando l’attenzione su quattro aree chiave in cui le sfide sono concentrate. Comincio con l’applicare i miei principi al regime commerciale mondiale e mostro come essi richiedano regole notevolmente diverse da quelle perseguite negli anni recenti. Poi mi volgo alla finanza globale e propongo un approccio che permette la coesistenza fianco a fianco di normative nazionali differenti senza che si danneggino a vicenda. La terza area è la migrazione della manodopera, un fenomeno di cui non abbiamo parlato molto in questo libro, ma che può produrre benefici significativi se gestito in maniera appropriata. Infine, riprendo una questione che potrà creare nei prossimi anni il più serio grattacapo per l’economia mondiale: come far adattare la Cina all’economia globale.
Riformare il regime del commercio internazionale
La nostra strategia commerciale attuale, centrata su accordi commerciali per aprire i mercati, spreca un notevole capitale politico e negoziale con la prospettiva di ottenere magri guadagni economici. Peggio ancora, trascura il principale difetto del sistema, che è la mancanza di un diffuso sostegno fra la gente comune.
La sfida di oggi non è più di liberalizzare il regime commerciale; quella battaglia fu combattuta negli anni Sessanta e Settanta ed è stata vinta definitivamente. Lo scellerato Smoot-Hawley Tariff Act varato negli anni Trenta è diventato un simbolo di tutto quello che può andar male quando le nazioni voltano le spalle all’economia mondiale. «Protezionismo» è diventato una parola oscena. I dazi di importazione e altre restrizioni che i governi impongono al commercio internazionale sono stati ridotti ai livelli più bassi che il mondo abbia mai conosciuto. Anche se restrizioni e sussidi continuano a essere importanti in alcune aree, soprattutto per certi prodotti agricoli (come riso, zucchero e prodotti caseari), il commercio mondiale è notevolmente libero. Di conseguenza, i vantaggi che ci aspettiamo di cogliere dalla rimozione delle ultime tracce del protezionismo sono poca cosa, molto più piccoli di quanto gli esperti e la stampa finanziaria pretenderebbero. Uno studio recente stima quei vantaggi a non più di un terzo dell’1 per cento del Pil mondiale (e questo alla fine di un intero decennio). La maggior parte delle altre stime attendibili si aggirano intorno alla stessa cifra.
I sostenitori del libero scambio, inclusi alcuni economisti, spesso offuscano questo punto sparando le «centinaia di miliardi di dollari» di commercio che sarebbero creati da questo o quell’accordo commerciale. Ma quello che genera più alti redditi, migliori posti di lavoro e progresso economico non è il piccolo incremento del commercio in quanto tale. Spedire una maglietta o un PC oltre confine non è ciò che ci fa più ricchi. Quello che ci fa più ricchi è la capacità di consumare quei beni a un costo minore e di vendere i nostri prodotti a prezzi migliori all’estero. È per questo che vogliamo ridurre le barriere artificiali al commercio. Attualmente tali guadagni sono modesti perché le barriere sono così basse.
Oggi la nostra sfida è di rendere l’apertura che già esiste sostenibile e compatibile con obiettivi sociali più ampi. Questo richiede un deciso spostamento del punto focale dei negoziati multilaterali. Quando i ministri del Commercio si riuniscono, dovrebbero discutere di allargare lo spazio di manovra per le singole nazioni, piuttosto che di restringerlo ulteriormente attraverso tagli delle tariffe doganali e sussidi. Dovrebbero creare in ciascun paese i margini necessari per proteggere i programmi e le normative sociali, rinnovare i contratti sociali interni e attuare politiche di crescita adattate alle esigenze locali. Dovrebbero contrattare lo spazio d’azione per la politica piuttosto che l’accesso ai mercati. Un simile ri-orientamento porterebbe beneficio per tutte le nazioni, ricche e povere. Ampliare lo spazio della politica per realizzare obiettivi nazionali non rinnega un regime commerciale aperto, multilaterale; anzi ne costituisce una condizione preliminare.
Le regole commerciali vigenti a livello mondiale già consentono alle nazioni di far ricorso a «tutele» nella forma di dazi di entrata più elevati quando un’improvvisa ondata di importazioni mette in difficoltà le aziende nazionali. Mi piacerebbe vedere l’Accordo sulle misure di salvaguardia dell’Omc (un residuo del Gatt) riscritto per allargare la possibilità d’azione della politica a un numero maggiore di situazioni. Un’interpretazione più larga delle misure di salvaguardia comporterebbe il riconoscimento che i paesi possano desiderare di restringere il commercio o sospendere gli obblighi imposti dall’Omc, esercitando il diritto di «recesso», per ragioni diverse dalla minaccia competitiva nei confronti delle loro industrie. Preoccupazioni per la distribuzione, conflitti con norme e assetti sociali nazionali, prevenzione dell’erosione dei regolamenti nazionali, o le priorità nello sviluppo, potrebbero essere fra le ragioni legittime di questo comportamento.
Specificamente, i paesi sarebbero autorizzati a «violare» le regole dell’Omc quando quelle regole minacciassero di incidere negativamente sulla situazione del lavoro all’interno e sulle norme per l’ambiente o quando impedissero il perseguimento di sane politiche di sviluppo. In realtà, il trattato dovrebbe essere riformulato in un più ampio Accordo su Tutele di sviluppo e sociali. Un paese che applica tali misure di salvaguardia dovrebbe soddisfare un importante requisito procedurale: dovrebbe dimostrare che nello stabilire che quelle misure di salvaguardia sono di pubblico interesse ha seguito procedure democratiche. Fra i criteri specifici potrebbero esserci la trasparenza, l’accountability, l’inclusività e la necessità che la deliberazione sia basata su prove. Questo ostacolo sostituirebbe l’attuale test di «danno grave», che si concentra in ampia misura sulla redditività finanziaria delle aziende nazionali.
Le commissioni dell’Omc continuerebbero a esercitare la loro giurisdizione, ma sulle procedure più che sulle questioni concrete. Il loro compito sarebbe di verificare che siano rispettati i requisiti democratici. Sono state sufficientemente rappresentate le opinioni di tutte le parti in causa rilevanti, tra cui gruppi di consumatori e di interesse pubblico, importatori ed esportatori, organizzazioni della società civile? Per la decisione finale, sono state prese in considerazione tutte le prove di rilievo, scientifiche ed economiche? C’è stato un consenso interno abbastanza ampio a favore dell’esercizio del diritto di recesso o di salvaguardia in questione? Le commissioni potrebbero pronunciarsi contro un paese che abbia assunto decisioni escludendo una parte interessata o prove scientifiche rilevanti. Ma non avrebbero il potere di giudicare sul merito della richiesta – ossia se davvero la misura di salvaguardia sia utile all’interesse pubblico nazionale favorendo un obiettivo sociale interno o promuovendo lo sviluppo economico nazionale. Questo richiama alla mente il rilievo procedurale presente nell’esistente Accordo sulle misure di salvaguardia, del quale però accresce di molto la portata d’applicazione.
La causa dell’apertura dell’economia va combattuta e vinta in patria. Un regime commerciale sostenibile poggia in ultima analisi non su restrizioni esterne ma sul sostegno politico interno. La procedura proposta imporrebbe un dibattito pubblico più approfondito e più rappresentativo sulla legittimità delle regole commerciali e sulle situazioni in cui potrebbe essere giusto sospenderle. La garanzia più affidabile contro l’abuso dei recessi è la deliberazione informata a livello nazionale. Il requisito che vuole che i gruppi i cui redditi sarebbero negativamente toccati dal recesso – importatori ed esportatori – debbano partecipare alle deliberazioni, e quello che vuole che il processo nazionale debba bilanciare gli interessi concorrenti in modo trasparente, minimizzeranno il rischio di misure protezionistiche che avvantaggino un piccolo segmento dell’industria a scapito della società nel suo insieme. Una valvola di sicurezza che permette alle obiezioni di principio al libero commercio di prevalere, rende più facile comprimere il vapore del protezionismo.
Anche se è presumibile che nella deliberazione finale a vincere siano gli interessi nazionali, le conseguenze per i paesi esteri non sarebbero del tutto trascurate. Nel caso in cui, per esempio, le misure di salvaguardia sociale rappresentassero una seria minaccia per i paesi poveri, le organizzazioni non governative e altri gruppi potrebbero mobilitarsi contro la proposta di recesso, e le loro ragioni potrebbero alla fine avere maggior peso rispetto ai costi dei disagi interni. Un sindacato può ottenere protezione quando i suoi iscritti sono costretti a competere con lavoratori all’estero che lavorano in flagranti condizioni di sfruttamento. È assai meno probabile che abbia la meglio contro contrapposti interessi interni quando le condizioni di lavoro all’estero rispecchino una scarsa produttività e non la repressione di diritti. Come osserva il giurista Robert Howse, aumentare la fiducia nella capacità delle deliberazioni nazionali di distinguere tra normative interne legittime e «truffe» protezionistiche dovrebbe attenuare la preoccupazione che le misure interne siano puramente protezionistiche. «Chiedere che le normative possano essere difese in un razionale processo deliberativo pubblico di giustificazione può sicuramente accrescere tale fiducia e nello stesso tempo essere utile alla democrazia, anziché frustrarla».
Un’estensione delle salvaguardie per coprire le norme sull’ambiente, il lavoro e la sicurezza dei consumatori o le priorità dello sviluppo in patria – con appropriate restrizioni procedurali contro gli abusi – aumenterebbe la legittimità e la resilienza del sistema commerciale mondiale e lo renderebbe più attento allo sviluppo. Soffierebbe vita nel principio secondo cui i paesi hanno il diritto di mantenere le norme nazionali quando il commercio mina pratiche interne largamente popolari, rifiutando l’accesso al mercato o, se necessario, sospendendo gli obblighi imposti dall’Omc. I paesi avanzati potrebbero cercare temporanea protezione contro importazioni provenienti da paesi in cui i diritti del lavoro sono poco rispettati quando queste importazioni peggiorano le condizioni di lavoro in patria. Alle nazioni povere potrebbe essere concessa la possibilità di sovvenzionare le attività industriali (e indirettamente le loro esportazioni) quando tali sussidi contribuiscano a una strategia di sviluppo largamente condivisa mirante a incentivare le capacità tecnologiche.
Le procedure attuali di salvaguardia richiedono il trattamento della nazione più favorita per le esportazioni, permettono misure solo temporanee, e impongono un risarcimento al paese che applica la salvaguardia. Queste procedure devono essere ripensate nel quadro della più ampia intesa che io propongo. Il trattamento di nazione più favorita spesso non avrà significato. Se la salvaguardia è una reazione ad abusi sul lavoro in un determinato paese, è giusto applicare la misura unicamente contro le importazioni provenienti da quel paese. Similmente, un abuso protratto richiederà un uso protratto della salvaguardia. Anziché imporre un soccorso temporaneo, sarebbe meglio richiedere una revisione periodica o una clausola a termine che potrebbe essere revocata nel caso il problema persista. In questo modo, le restrizioni o i regolamenti commerciali che nuocciono agli interessi di altri paesi hanno minori possibilità di sclerotizzarsi.
Il problema del risarcimento è più spinoso. Quando un paese adotta una misura di salvaguardia, ne consegue logicamente che esso revochi una «concessione commerciale» che in precedenza aveva accordato ad altri paesi con un accordo internazionalmente vincolante. Quegli altri paesi, per parte loro, hanno titolo a ricevere concessioni equivalenti o a revocare qualcuna delle proprie concessioni. In un mondo dinamico in quasi continuo cambiamento non si può prevedere perfettamente la natura delle concessioni che un paese accorda ad altri. Questa incertezza trasforma gli accordi commerciali internazionali in «contratti incompleti». Quando sviluppi imprevisti cambiano il valore o il costo dei flussi commerciali – a causa di nuove tecnologie nell’ingegneria genetica, poniamo, o di nuovi valori nell’ambiente, o di nuove concezioni nella strategia di sviluppo desiderabile – chi controlla i diritti su quei flussi? Il requisito del risarcimento innesta automaticamente quei diritti nel regime commerciale internazionale; l’esportatore può continuare a chiedere accesso al mercato nel rispetto delle condizioni originarie. Ma potremmo anche legittimamente sostenere che il valore delle concessioni originarie dipende dalle circo...