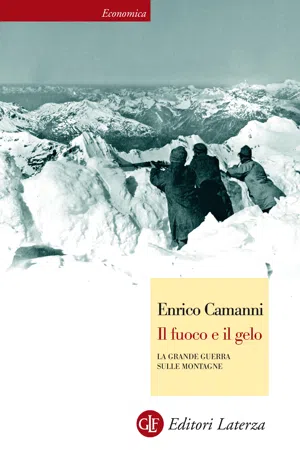Alpinismo scuola di guerra
Dalle Alpi Giudicarie il fronte scendeva sulla bassa del Garda, attraversava la Vallagarina, scalava gli altipiani e incontrava l’architettura rocciosa più assurda e fantastica: le Dolomiti. Montagne uniche al mondo, campanili e merlature di pietra, scogliere nate dal mare e scolpite dalla pioggia e dal vento.
La scoperta delle Dolomiti porta la data della Rivoluzione francese. Nell’agosto del 1789 il viaggiatore e scienziato Déodat Guy Silvain Tancrède Gratet de Dolomieu intuisce che i leggendari monti del Rosengarten (le guglie del Catinaccio) non sono fatti di semplice calcare e invia campioni di roccia di carbonato e magnesio al geologo ginevrino Théodore-Nicolas de Saussure per un’analisi accurata. Il figlio del salitore del Monte Bianco conferma la scoperta di Dolomieu e battezza la roccia «dolomia», in suo onore. L’esplorazione alpinistica arriva molto più tardi, nella seconda metà dell’Ottocento, su iniziativa del pioniere viennese Paul Grohmann. La sua opera Wanderungen in den Dolomiten («Escursioni nelle Dolomiti»), riferita all’estate del 1862, contiene il primo corredo di notizie geografiche e alpinistiche della regione, senza concessioni romantiche:
alla sella di Dobbiaco, 1204 metri, si incontra la strada d’Ampezzo. Vi si arriva da Bressanone, che si trova ad occidente, a 558 metri sul mare, oppure da Lienz che è ad oriente a 667 metri. In ambedue i casi bisogna superare un dislivello considerevole, tuttavia, eccettuato qualche tratto da Brunico a Perca, e da Abfaltersbach a Strassen, la pendenza è in complesso così lieve che non ci si accorge neanche di arrivare.
Venticinque anni più tardi, nel 1887, tocca a un giovane alpinista tedesco, Theodor Wundt, colorare con passione e buon gusto il racconto del viaggio. Il clima è cambiato e gran parte delle Dolomiti è ormai terra esplorata e frequentata:
a Dobbiaco siamo giunti chi dal Brennero chi dalla valle della Drava. Una frotta di turisti si accalca all’uscita del treno sovraffollato, lieta di lasciare il fumante cavallo a vapore per respirare a pieni polmoni la fresca aria di montagna. Fuori però, davanti alla stazione, ci attende la combattiva schiera dei portieri, dei facchini e dei vetturini. Si precipitano avidi sulle loro prede: Hotel Ampezzo! Hotel Toblach! Hotel Ploner! Desidera una vettura? Le offerte risuonano furiosamente l’una sull’altra... In violento contrasto, sopra i boschi, si ergono cupi i selvaggi dirupi di Cima Nove.
Insieme al turismo arriva l’arrampicata, e non c’è sfida più esaltante, per i rocciatori, delle guglie di dolomia lanciate nel cielo del Tirolo. Le crode attirano i migliori scalatori tedeschi, austriaci e italiani; si registrano imprese epiche come la scalata solitaria della Torre meridionale del Vaiolet, firmata dal diciassettenne Georg Winkler nel 1887. A cavallo del secolo si salgono le grandi pareti – Marmolada e Tofana di Rozes – e nel luglio del 1911 il ragazzo della Stiria Paul Preuss scala da solo la parete est del Campanile Basso di Brenta, sigillando il massimo grado di audacia e perfezione. L’ideologia dell’arrampicata libera, che all’epoca comportava una bella dose di rischio e coraggio, si trasforma in incubatore bellico ed esasperata accademia di guerra, soprattutto per chi – come i club alpini – intuisce che le montagne saranno presto teatro di battaglia. Il 24 maggio 1915 il presidente Lorenzo Camerano sprona le sezioni italiane del Club Alpino: «Alpinisti italiani! La Patria chiama tutti i suoi figli al fiero cimento. Accorriamo con cuore acceso di sacro amore...». L’appello alle compagini studentesche del Club Alpino è ancora più diretto: «Stanno le Dolomiti di Trento diritte come il desiderio nostro, fervide nei tramonti come il dolore vostro, fratelli in attesa...».
Nel 1917 il matrimonio tra alpinismo e guerra è così collaudato da giustificare asserzioni definitive sul notiziario ufficiale del Deutscher und Österreichischer Alpenverein:
i tempi in cui noi alpinisti venivamo chiamati fanatici dello sport, rocciatori matti o roba del genere... non torneranno mai più. La guerra l’ha fatta finita con questo giudizio... L’alpinismo è stata una scuola dura e seria in preparazione della guerra. La piccozza e lo scarpone sul campo di battaglia sono diventati altrettanto importanti del fucile e della baionetta.
La Guerra Bianca ha portato a un’identificazione quasi perfetta tra la figura del combattente e quella del rocciatore. Per ragioni belliche sono state scalate pareti di quarto grado, vicine al limite massimo delle difficoltà alpinistiche del tempo, e sono stati impegnati scalatori e guide di fama e talento come Sepp Innerkofler e il giovane Luis Trenker. La guerra delle Dolomiti ha raggiunto, dominandoli, i luoghi sacri dell’alpinismo romantico, spingendosi negli scenari delle cartoline turistiche e sui palcoscenici della vertigine: Marmolada, Lagazuoi, Tofane, Cinque Torri, Monte Cristallo, Tre Cime di Lavaredo, Dolomiti di Sesto. Lo storico ampezzano Ernesto Majoni ha calcolato che tra il 19 giugno 1915 e il 28 settembre 1917 «gli itinerari aperti sulle Dolomiti che circondano Ampezzo, Sesto e il Comelico di cui si ha notizia certa, furono circa una sessantina». Naturalmente, non si scalava per il piacere dell’arrampicata ma per esplorare o presidiare pareti e cime d’interesse strategico; però l’attrazione verticale poteva anche scacciare i cattivi pensieri ed era un ottimo antidoto all’incubo della guerra di posizione. La corda univa gli animi e scalando ci si sentiva vivi.
Ricorda il grande alpinista goriziano Julius Kugy:
Fin dall’8 settembre 1915 avevo proposto di conquistare il Montasio, che come punto di osservazione di artiglieria verso Sella Nevea e la Val Dogna sarebbe stato preziosissimo. Il comando della mia Brigata di allora, la 184ª, ritenne la proposta troppo fantastica e la bocciò. Io non riuscivo a distogliere la mente dall’idea, e quando tornai nel Natale del 1915 scoprii con gioia che il seme aveva messo radici presso il Comandante d’Armata...
Fu così che cominciammo i preparativi, consapevoli dell’obiettivo. Ci servivano soprattutto uomini addestrati sotto il profilo alpinistico... È per questo scopo che nella gola della Val Bartolo presso Camporosso fu fondata la scuola di roccia. Non esagero se dico che in quella palestra si formarono gli uomini con il migliore addestramento per l’alta montagna che l’Esercito austro-ungarico avesse mai avuto.
Anche sul fronte italiano militarono alpinisti accademici e guide alpine, che insegnavano l’arte dell’arrampicata o la praticavano in prima persona, come fecero il nobile rocciatore fiorentino Ugo Ottolenghi di Vallepiana e la fortissima guida del Cervino Joseph Gaspard sul repulsivo camino della Tofana di Rozes: diciassette giorni di scalata difficile ed estrema, allietata dai confetti dei tiratori austriaci.
Scalata e guerra sono la sommatoria di due assurdi, eppure, quando ho indossato i panni di Gaspard per raccontare in un romanzo la scalata della Tofana di Rozes, ho capito che per loro aveva un senso. Assurdo ma l’aveva. Gaspard, Vallepiana e gli altri disgraziati che combatterono sulle Dolomiti tra il 1915 e il 1917, scalandole, difendevano la frontiera della patria e credevano che ogni roccia «vinta» fosse un dono per l’Italia. Piccolo ma necessario. Sono stati gli unici alpinisti a pensare di scalare una cosa utile. Per questo, nel gergo militaresco che si porta addosso da quel sacrificio, la scalata è stata spesso definita una «conquista», e qualche nostalgico lo dice ancora.
Racconti a cielo aperto
Sulle Dolomiti s’incontrano musei ovunque: nei forti, nelle gallerie, sulle cenge, in parete, in ogni luogo. Oggi i Monti Pallidi sono un immenso museo diffuso della Grande Guerra con millecinquecento chilometri di sentieri, trincee, camminamenti, vie ferrate, segnavia, pannelli, vetrine e ricostruzioni sceniche. Un’inesauribile offerta culturale e ricreativa. Questo turismo della memoria risponde alla legge del 7 marzo 2001 sulla tutela del patrimonio storico di guerra, che ha sperimentato la ricostruzione bellica a scopo museale sulle vertiginose cenge e nei corridoi sotterranei del Lagazuoi, sopra il Passo di Falzarego.
Ci vado una sera di fine luglio con l’ultima funivia. Salutando il sole e calandomi nelle gallerie assicurato dai cavi, mi accorgo che è cambiato molto nel Duemila; confronto i rustici sentieri di vent’anni fa, che richiedevano un po’ di quell’abilità che fu degli alpini nel costruirli e soprattutto nel viverci estate e inverno, con gli agevoli scivoli gradinati del nuovo museo; prima era un percorso severo, oggi bastano una torcia e scarpe buone per scendere nella pancia della montagna senza rischiare di perdersi o cadere. Mi seguono due corridori portoghesi poco vestiti, un lui e una lei sui quarant’anni, pantaloncini corti e scarpe da running; il loro stupore è pari alla distanza che li (ci) separa dall’austerità del luogo e della sua memoria. Quando sbuchiamo sulla cengia Martini e vedo le loro gambe magre e abbronzate, penso agli alpini abbottonati e coperti, sempre impeccabili nei loro stracci: a come sembravano già vecchi a vent’anni.
Lungo l’itinerario delle gallerie incontriamo finestre che affacciano sugli scenari di guerra, armi puntate verso nemici invisibili e baracche ricostruite come presepi, con i letti, i tavoli di legno e le suppellettili. Le baracche sono un po’ finte ma danno l’idea di come si sopravviveva in questo paradiso, con i cuori pesanti e la pancia vuota. Di vero restano il buio, il freddo e l’odore di marcio esalato dal ghiaccio fetido che non scioglie mai nei cunicoli di dolomia; il resto è gioco di sensi ed esercizio della memoria.
I tunnel del Lagazuoi sono tra i luoghi più amati dagli escursionisti delle Dolomiti; c’è chi scende in pellegrinaggio e chi li confonde con l’ottovolante, dipende dalla sensibilità. Stiamo forse speculando sui morti?, mi chiedo pattinando sui sassi levigati da un milione di scarponi. Si può guadagnare l’attenzione dei giovani senza usare il sacrificio dei vecchi? È possibile tradurre il dolore e la ferocia di cent’anni fa in un linguaggio moderno che contenga la parola «pace»? Non ho risposte, il turismo non ne ha. Qui l’unica parola universale è la montagna.
Comunque camminare fa bene e la fatica allarga la mente. Senza la presunzione di confrontare il sudore degli alpini con quello degli escursionisti, o dei pellegrini di guerra, sui sentieri delle Dolomiti orientali si percepisce quasi ovunque la presenza di un dramma sospeso, come se cent’anni non fossero bastati a cancellare. Ci si sente ancora coinvolti, che si parli tedesco e italiano come allora, oppure un’altra delle mille lingue del turismo contemporaneo. Nessuno può attraversare questi reliquiari con un cuore neutrale perché la guerra riguarda tutti, e tutti hanno un nonno che non è tornato, o è stato ferito, o è tornato segnato e vuoto. Alla vecchia Europa manca da cent’anni una generazione di soldati bambini, sono ancora lì che ci giudicano dalle trincee.
Tra tutti i reperti che sono emersi – ha osservato Giovanni Cenacchi – il più importante da restaurare e visitare, in fondo, siamo proprio noi con il nostro passato tormentato di europei; e insieme a questo, quella strana miscela di colpevolezza e cultura, di grandiosità e decadenza di cui è fatta al cospetto del mondo la nostra identità.
Le Dolomiti sono la materializzazione di queste contraddizioni, esasperate dai contrasti di una natura idilliaca ed estrema allo stesso tempo. Non c’è sasso che non abbia una storia e non c’è storia senza la sua cima. Secondo il cantore dei Monti Pallidi, Karl Felix Wolff, il nome Falzarego ricorderebbe il fautso rego, falso re, della leggenda dei Fanes: quando il sovrano straniero tentò di impossessarsi del regno sotterraneo d’Aurona abbandonando per sempre il suo popolo, fu punito con la pietrificazione nelle rocce del Piccolo Lagazuoi. A detta di Serge Bertino il ghiacciaio della Marmolada copre quella che fu, in tempi molto lontani, «una distesa di verdissimi pascoli». Essi scomparvero quando una vecchia strega, malgrado le rimostranze dei montanari, si ostinò a far fieno nel giorno consacrato alla Madonna delle nevi, il 5 di agosto. La notte dopo il sacrilegio la neve cominciò a cadere e «tanta ne venne che seppellì la vecchia, ed essa è ancora là, sotto il ghiacciaio, con il suo inutile mucchio di fieno». Chissà se gli unici uomini che mai abitarono quel gelo incontrarono la strega contadina? Chissà se sapevano?
Tra il 1916 e il 1917 i soldati del kaiser scavano otto chilometri di gallerie nel ghiaccio del versante nord della Marmolada, costruendo una città sommersa e resistendo per mesi al fuoco delle artiglierie italiane. Scrive Gunther Langes:
spesso la vita che conducevamo lassù ci ricordava le esperienze degli esploratori artici e l’esistenza degli eschimesi. Diventammo conoscitori perfetti dei segreti del ghiacciaio, dei suoi crepacci, dei suoi movimenti invernali, quando il ghiaccio è compatto, ed estivi quando è plastico...
In tre punti del ghiacciaio costruimmo ricoveri in crepacci semicoperti, cominciando a spingere le nostre gallerie verso l’alto e verso il basso. Dopo ogni esplosione il ghiaccio frantumato veniva allontanato con badili e picconi, e portato fino al crepaccio successivo per mezzo di piccole slitte che scivolavano su lamiere curvate a guisa di grondaia...
La corrente elettrica ci veniva fornita dalla centrale a vapore di Roa presso Canazei. Per breve tempo le nostre gallerie furono illuminate da lampadine elettriche, distanti cinquanta metri l’una dall’altra... I sentieri nel ghiaccio e le piste venivano segnati con lunghi pali, ai quali erano infisse frecce indicatrici di legno giallo fosforescente.
La Città di Ghiaccio cresce a ritmo serrato con tanto di vie e cartelli segnaletici, mentre fuori imperversano le bufere. Venerdì 13 dicembre 1916, il «venerdì bianco» di guerra, muoiono sul fronte alpino diecimila soldati. Sulla Marmolada una valanga travolge cinquecento uomini e trecento soffocano sotto la neve. La Strada delle Dolomiti viene interrotta da un’enorme valanga e per riaprirla gli alpini devono scavare una trincea alta più di quindici metri.
Dopo tre giorni il maltempo concede una tregua, ma poi sulle Dolomiti ricomincia a soffiare la tormenta. La neve va avanti per altre due settimane, cinque-sei metri, una delle nevicate più straordinarie del secolo. I soldati dei due fronti rimangono inchiodati nelle baracche, cercando di rinforzare le assi dei...