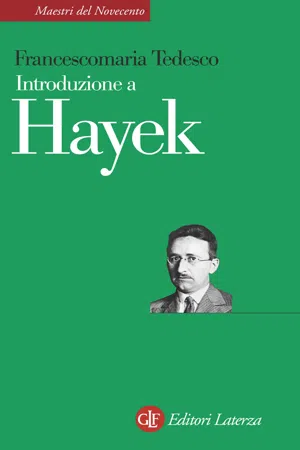
- 186 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Introduzione a Hayek
Informazioni su questo libro
Il percorso teorico di uno dei più influenti e discussi pensatori liberali del Novecento, Premio Nobel per l'economia nel 1974. Dai primi saggi economici degli anni Venti e Trenta sino agli sviluppi degli anni Quaranta e agli esiti successivi, quando la riflessione di Hayek si è concentrata sui temi del diritto e della libertà, dello Stato e dell'ordine sociale.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Introduzione a Hayek di Francescomaria Tedesco in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Economía e Historia económica. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
EconomíaCategoria
Historia económicaII. L’‘operosa vecchiaia’: l’individualismo metodologico e l’illusione sinottica
1. Dopo la ‘svolta’
La ‘svolta’ che si verificò tra la fine degli anni Trenta e la prima metà dei Quaranta nel pensiero hayekiano non può essere definita come un’abiura: l’interesse per il concetto di ordine (e per le scienze sociali in genere) può essere considerato uno sviluppo interno del suo pensiero economico. Sul problema del rapporto tra economia politica e teoria sociale tout court in Hayek occorre soffermarsi nuovamente: l’opus hayekiano può essere pensato come unico e ‘sistematico’ poiché in esso non esiste soluzione di continuità tra la riflessione su ciclo, capitale e moneta e quella sull’ordine spontaneo. Ciò che si vuole dire è che, nonostante la ‘svolta’ dall’equilibrio all’ordine, i temi elaborati negli anni Trenta sono la base metodologica della successiva riflessione hayekiana, e in essa si trovano (talvolta in forma embrionale) i concetti fondamentali che Hayek svilupperà in lavori come The Road to Serfdom (1944), The Constitution of Liberty (1960), Law, Legislation and Liberty (1973-1979) e molti altri. Dunque, se proprio si vuole utilizzare, parlando di Hayek, un qualche schema classificatorio cronologicamente orientato, si può parlare di un ‘primo Hayek’ (quello di Monetary Theory e di Prices and Production) e di un ‘secondo Hayek’, quello dei saggi scritti dalla seconda metà degli anni Trenta (partendo convenzionalmente da Economics and Knowledge) in poi. Ma si tratta di una classificazione che, se intesa in senso eccessivamente rigoroso, risulta fuorviante poiché negli scritti dell’economista e filosofo viennese i temi economici e filosofico-politici sono, praticamente sin quasi dai primissimi lavori, intrecciati indissolubilmente1 e sono tenuti da Hayek in costante relazione tra loro.
Certo, Hayek era profondamente insoddisfatto dell’analisi formale del fenomeno economico che la teoria dell’equilibrio generale forniva, ma è da quei presupposti teorici che egli pervenne alla formulazione del problema dell’ordine spontaneo. E fu studiando la filosofia politica, il diritto, le teorie della conoscenza, l’epistemologia, le teorie della condotta umana nella determinazione dei fini individuali e il rapporto di questi ultimi con eventuali fini collettivi, nonché la psicologia teorica, che Hayek tentò di cogliere il nucleo delle questioni che la teoria economica lambiva soltanto. Ma abbiamo già trattato delle ragioni della ‘svolta’. Qualcuno ha affiancato alla spiegazione che rintraccia nella fortuna del keynesismo l’origine dell’allontanamento di Hayek dai temi del ciclo e del capitale, l’idea che le ragioni contingenti del suo atteggiamento fossero da ricercare nel tramonto, in Europa, della concezione liberale della società, messa in crisi dal diffondersi delle ideologie totalitarie2.
Ma quello che lo indusse a cambiare prospettiva, racconta Hayek nella sua autobiografia, fu in realtà qualcosa che egli aveva appreso studiando l’economia:
le conseguenze dell’intero modello di analisi di utilità marginale forse fu il punto di svolta che è stato alla base non solo delle mie visioni economiche ma anche di quelle politiche. Mi spiego: intendo riferirmi al mercato come a un sistema per l’utilizzazione della conoscenza, che nessuno può possedere per intero, che solo attraverso la situazione del mercato porta le persone a mirare ai bisogni di persone non conosciute e a utilizzare dei servizi per i quali non si dispone di informazioni dirette.3
Secondo Hayek, quindi, la conoscenza è estremamente frazionata, e questo impedisce che un singolo individuo (o un’istituzione) possa avere una visione d’insieme dei fenomeni sociali: ciascun individuo conosce solo i propri fini, che si intersecano con i fini degli altri dando luogo a un ordine spontaneo, non costruito. È questa la tesi fondamentale alla quale Hayek lavorerà dalla fine degli anni Trenta in poi.
Nel 1938 Hayek era diventato cittadino britannico. Fu grazie al suo nuovo passaporto che riuscì a tornare, prima della guerra, a Vienna. Ma la città che Hayek aveva lasciato partendo per Londra non esisteva più. Dopo l’Anschluss, essa aveva perso, ai suoi occhi, il fascino della città cosmopolita, percorsa da molteplici fermenti intellettuali, in cui il giovane Hayek aveva mosso i primi passi.
Nel 1940 la London School of Economics si trasferì a Cambridge a causa dei bombardamenti su Londra: Hayek continuò a insegnarvi fino al 1949. In quegli anni (era l’aprile del 1947) fondò la Mont Pelerin Society. Si tratta di un’associazione, il cui nome deriva dalla località della Svizzera in cui avvenne la prima riunione4, inizialmente composta da un nucleo di 39 persone; successivamente, ne hanno fatto parte eminenti personalità della cultura, economisti, giornalisti, politici, storici e filosofi. Figurano tra i membri della Mont Pelerin Society, fra gli altri, Karl R. Popper, Mises e Fritz Machlup, Milton Friedman e Walter Lippmann, Luigi Einaudi, Bruno Leoni, Antonio Martino e Bresciani-Turroni, Michael Polanyi. Bertrand De Jouvenel e Raymond Aron, pur avendo inizialmente aderito, in seguito si dimisero5. La Mont Pelerin Society si proponeva di discutere i temi della società libera e dei pericoli che ne minacciavano la sopravvivenza. Lo Statement of Aims dell’associazione6 afferma che «i principali valori della civiltà sono in pericolo»7, costantemente minacciati dallo sviluppo di quelle teorie (socialismo e fascismo8) che revocano in dubbio la desiderabilità del rule of law; e che tali teorie favoriscono il declino della fede nella proprietà privata e nel libero mercato, mettendo così a rischio «il bene più prezioso dell’Uomo Occidentale»9: la libertà di pensiero e di espressione. Hayek ricoprì la carica di presidente della Mont Pelerin Society per più di dodici anni. Quando, nel 1960, si dimise dalla carica, fu nominato presidente onorario.
2. «La via della schiavitù»
Nel suo soggiorno a Cambridge, Hayek scrisse The Road to Serfdom10. Si tratta di un libro che ha forti accenti polemici contro i socialisti (cui è dedicato) e contro la pianificazione. L’intento del libro – a detta del suo autore11 – non era quello di attaccare i socialisti, quanto di convincerli della erroneità delle loro tesi.
In Inghilterra, il volume venne pubblicato «in un momento in cui le persone erano già diventate consapevoli dei pericoli del socialismo»12, e dunque il successo che esso ebbe fu di certo inferiore rispetto a quello che invece gli fu tributato negli Stati Uniti. Non che il pamphlet politico di Hayek non avesse suscitato anche in Inghilterra polemiche accesissime: tutt’altro13.
The Road to Serfdom si articola attorno a due tesi fondamentali14 – una ‘contingente’, l’altra ‘teorica’ – che si intrecciano fra loro: da quest’ultimo punto di vista teorico, il nucleo dell’argomentazione hayekiana è che «la nascita del fascismo e del nazismo non fu una reazione contro le tendenze socialiste del periodo precedente, quanto piuttosto un esito necessario di quelle tendenze»15; ma le vicende storiche portano Hayek ad affermare che quell’esito rischiava – il libro è del 1944 – di manifestarsi anche in quei paesi tradizionalmente liberali e fondati su un’antropologia individualista quali la Gran Bretagna e gli Stati Uniti.
Dunque, i paesi anglosassoni rischiano di imboccare la via della schiavitù, quella che porta dal socialismo, coi corollari della pianificazione e della giustizia sociale, verso i più terribili totalitarismi del Novecento. Il rischio deriva dalla pericolosa adesione dell’intellighenzia anglosassone a quegli ideali socialisti il cui sviluppo in Germania aveva dato la stura al totalitarismo: «Sebbene fossimo stati ammoniti da alcuni dei più grandi pensatori politici del diciannovesimo secolo, da Tocqueville a Lord Acton, che il socialismo significa schiavitù, noi ci siamo costantemente mossi nella direzione del socialismo»16.
Secondo Hayek è lo sviluppo delle idee socialiste che ha portato la Germania al nazionalsocialismo, poiché c’è una profonda convergenza tra i fascismi e il socialismo collettivista e pianificatore: entrambi postulano la direzione centralizzata della società e dell’economia, ed entrambi riconoscono che ciò è possibile solo attraverso la conculcazione delle libertà individuali e l’annientamento della cultura liberale e individualista, ostacoli a ogni forma di accentramento del potere. L’esperienza tedesca lo dimostra: i prodromi dell’ascesa del nazismo risiedono nel fatto che «i Tedeschi erano praticamente diventati tutti socialisti»17 e «il liberalismo [...] era stato spazzato via dal socialismo»18; questa comune radice teorica è tanto evidente che il conflitto sociale che si sviluppò tra nazi-fascisti e socialisti deve dunque essere letto, nell’ottica hayekiana, come tra fazioni socialiste rivali.
Ricorrono, nelle pagine analitiche del libro di Hayek, alcune dicotomie che si sovrappongono. La dicotomia centrale, attorno alla quale Hayek svolge le sue tesi, è quella tra individualismo e collettivismo. A questa si aggiunge quella tra governo della legge e governo degli uomini, nonché tra liberalismo e socialismo. I tratti salienti dell’individualismo sono «il rispetto dell’uomo singolo in quanto uomo, cioè il riconoscimento che i suoi gusti sono supremi nella sua propria sfera»19 e l’idea che sia «desiderabile che gli uomini sviluppino i loro talenti e le loro inclinazioni»20. Tutto ciò si lega indissolubilmente al capitalismo mercantile, che Hayek ritiene essere l’humus nel quale l’individualismo può svilupparsi. Il collettivismo, al contrario, nega i presupposti dell’antropologia individualista e liberale nel momento stesso in cui postula il controllo sociale, la direzione centralizzata, la pianificazione e l’abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione. L’individualismo si enuclea nell’idea della collocazione dell’individuo entro un framework di norme
stabilite e annunciate in anticipo: norme che rendono possibile prevedere con ragionevole certezza in che modo l’autorità userà i suoi poteri coercitivi in determinate circostanze, e che rendono possibile agli individui programmare i propri affari sulla base di tale conoscenza.21
Si tratta del concetto di rule of law22, usato in radicale opposizione alla nozione di potere (arbitrario) dei collettivisti. Mentre quest’ultimo si fonda su regole sostanziali, il rule of law è organizzato attorno a regole formali (strumentali), che fissano le condizioni entro le quali l’individuo è libero di determinare i propri fini.
In altri termini, il rule of law si fonda sull’antropologia individualistico-liberale; postula il governo della legge (formale) accompagnata a una naturale diffidenza nei confronti del potere («ai grandi filosofi sociali di matrice individualista del diciannovesimo secolo [...] il potere in se stesso era sempre apparso come il diavolo»23); è descritta dalla massima di Henry Sumner Maine ‘dallo status al contratto’; rifiuta l’impostazione formalista che ritiene che la legittimità coincida con la legalità; non persegue fini collettivi e non è ‘morale’ poiché non impone agli individui particolari visioni del mondo o insiemi di scopi; sostiene l’autonomia della sfera economica dal potere politico; infine, il rule of law considera la democrazia un mezzo e non un fine, un mero strumento e in quanto tale corruttibile.
Al contra...
Indice dei contenuti
- Ringraziamenti
- I. Dall’equilibrio all’ordine
- II. L’‘operosa vecchiaia’: l’individualismo metodologico e l’illusione sinottica
- III. Libertà, diritto, stato
- IV. Critica del «welfare state» e proposta costituzionale
- V. Il liberalismo di Hayek
- Cronologia della vita e delle opere
- Storia della critica
- Bibliografia
- L’autore