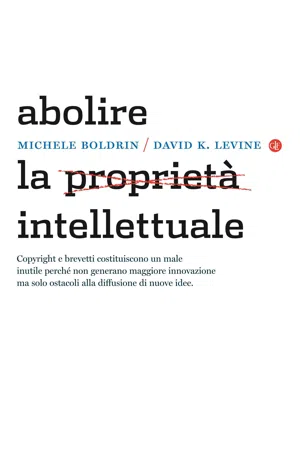1. La creatività della concorrenza
La conclusione principale a cui è giunta la nostra ricerca è che difendere il monopolio intellettuale dal punto di vista legale – tramite brevetti, copyright e altre restrizioni all’utilizzo di un’invenzione – non favorisce necessariamente l’innovazione e la creatività. Affinché possiate rendervi conto che le nostre idee sono basate su fatti storici ed esperienze concrete, in questo e nel prossimo capitolo vi accompagneremo attraverso una piccola parte dei settori dell’esperienza pratica in cui le innovazioni sono cresciute – e tuttora crescono – nella completa assenza di qualsiasi monopolio intellettuale.
Software
Osservate con attenzione il computer sulla vostra scrivania: vedrete un mouse, una tastiera e, sul vostro schermo, numerose finestre sovrapposte, contenenti l’una un elaboratore di testi, l’altra un foglio di calcolo elettronico, altre ancora un instant messenger o un navigatore attraverso il quale accedere alla sempre più consistente mole di informazioni disponibili in rete. Alla fine della seconda guerra mondiale – all’incirca settant’anni fa – non esistevano i computer digitali, e neppure i software che oggi li fanno funzionare. In pochi settori, tuttavia, si è registrata un’innovazione tanto vasta e profonda quanto in quello del software, e poche tecnologie hanno cambiato così radicalmente il nostro modo di vivere. Vi sorprenderebbe sapere che quasi nessuna delle innovazioni fondamentali per lo sviluppo di questo settore ha avuto luogo sotto la protezione del monopolio intellettuale? Nessuno degli elementi menzionati precedentemente, infatti, deve la sua esistenza al copyright o ai brevetti! Il nostro viaggio nel mondo segreto in cui prospera l’innovazione in una situazione di concorrenza comincia qui, nel settore del software.
Non sappiamo se ridere o piangere alla notizia che Amazon ha intentato una causa contro Barnes & Noble per violazione di brevetto, mentre è stata a sua volta citata in giudizio da IBM per lo stesso motivo, così come quando veniamo a sapere che Microsoft insinua che ci farà causa per violazione di brevetto se usiamo GNU/Linux anziché Windows (non lo ha ancora fatto, in realtà, ma la minaccia continua a incombere). Si tratta di storie vecchie, datate 2005-2006. Nel frattempo il ricorso ad azioni legali è andato crescendo a dismisura: mentre scriviamo questo libro, leggiamo che nell’ottobre del 2010 Motorola ha portato in giudizio Apple dopo che, alcuni giorni prima, Microsoft le aveva fatto causa per motivi analoghi. Un anno prima Nokia aveva fatto lo stesso con Apple, e la ragione appare sempre identica: aver usato, nel software per la propria telefonia mobile, delle linee di codice brevettate dall’impresa che fa causa.
Pare che nessuna industria sia tanto soffocata dal problema del monopolio intellettuale quanto quella che opera nel settore del software. Eppure non è stato sempre così: negli ultimi venticinque anni il settore del software ha beneficiato di enormi mutamenti legali, approvati da un organo non elettivo, la Corte Suprema degli Stati Uniti. Prima, infatti, della sua decisione del 1981 nel caso Diamond vs Diehr, non era in alcun modo possibile ottenere il brevetto per un software. Con la sentenza in questione, invece, la Corte Suprema stabilì la possibilità di brevettare un software nel caso in cui questo costituisse parte integrante di una macchina o di un processo, ossia quando la macchina o il processo dipende dal software per il proprio funzionamento o svolgimento. In pratica, se non fossero stati già in uso da molto tempo, sarebbe stato possibile da allora brevettare il mouse o il monitor del PC. La folle esagerazione attuale, di brevettare ogni click del mouse e ogni linea di software, ha inizio con la successiva estensione dei brevetti ai prodotti di software in isolamento (quelli cioè non installati in alcuna macchina o processo), stabilita nel 1994 dalla sentenza In re Alappat emessa dalla Corte Federale.
Questi mutamenti legali hanno forse dato luogo all’esplosione di innovazioni utili nel campo del software? Neanche per sogno. Abbiamo detto all’inizio che Amazon ha fatto causa a Barnes & Noble quando quest’ultima ha offerto la possibilità di fare acquisti online attraverso l’uso di one-click: un’idea che, a quanto pare, Amazon è riuscita a brevettare. Domandiamoci quanto sia stato difficile realizzare un’innovazione come questa, non tanto per fare della facile ironia (ci volle effettivamente molto poco!), ma per vedere cosa ci sia sotto, ossia per capire come funziona l’innovazione nel campo del software. Qualsiasi sia il valore di one-click, esistono certamente molte altre invenzioni di software altrettanto importanti e meno ovvie. Pensiamo, per rimanere in tema, a tutti i sistemi grafici di interfaccia, ai vari bottoni, simboli e immagini, ai compilatori di programma, agli object oriented programs, alle linked lists, alle basi di dati, agli algoritmi di ricerca, alle diverse fonti e ai differenti processatori di testo, ecc.: un vasto gruppo di algoritmi e metodi in uso anche nel più semplice programma moderno. Non solo queste innovazioni sono tutte difficili e importanti, ma il dato più rilevante è che ognuna di esse viene utilizzata ed è necessaria per far funzionare quel singolo click di Amazon o quei due click a cui Barnes & Noble ha dovuto adattarsi. Detto altrimenti: ammesso e non concesso che il singolo click sia da considerarsi un’innovazione, esso è davvero un nano che siede sulle spalle di moltissimi giganti.
Il punto rilevante, tuttavia, è un altro. Nessuno di questi giganti è stato introdotto grazie agli incentivi offerti dai brevetti, per una semplice ragione: ognuna di tali invenzioni si è verificata prima del 1981, quando il software non era nemmeno teoricamente brevettabile. Non solo: se tutte queste parti del complesso del software che fa funzionare un computer in rete fossero state brevettate, come sicuramente sarebbe avvenuto in base alle normative attuali, il progresso nel settore del software, lungi dall’essere potenziato, non avrebbe mai nemmeno avuto luogo. Secondo Bill Gates – difficilmente definibile come un radicale o un utopista contrario ai brevetti – «se la gente avesse capito come si concedono i brevetti nel momento in cui la maggioranza delle idee di oggi sono state inventate, e avesse chiesto di brevettarle, il settore sarebbe entrato in una completa impasse».
Non solamente i brevetti non hanno giocato alcun ruolo nel processo innovativo che ha trasformato il settore del software, ma anche il copyright vi ha giocato solo un ruolo limitato. Nei primi anni in cui i programmi di computer erano spesso protetti da copyright, raramente quest’ultimo veniva rispettato: i consumatori acquistavano programmi e li usavano in vari computer in violazione dell’accordo di licenza; si compravano e vendevano computer e se ne creavano di nuovi impiegando pezzi, moduli e idee dei programmi esistenti. Se è vero che probabilmente l’introduzione del copyright ha limitato l’abitudine di copiare i software realizzati da altri, va anche sottolineato che la sua violazione non veniva sanzionata così severamente come accade adesso.
Il settore del software è il miglior esempio di una delle conclusioni a cui la ricerca illustrata in questo libro è pervenuta: il monopolio intellettuale non è causa dell’innovazione, quanto piuttosto una conseguenza, socialmente non apprezzata, anche se piacevole per il privato che ne trae beneficio. In un settore giovane e dinamico, pieno di idee e creatività, il monopolio intellettuale non gioca un ruolo utile. Come prova l’esempio del software, e come proveranno altri esempi nelle sezioni seguenti, le industrie creative e in grande crescita sono tali perché centinaia o anche migliaia di imprenditori fiutano delle opportunità di profitto e di conseguenza, imitandosi, copiandosi, superandosi, producono la crescita travolgente che sempre caratterizza il decollo di una nuova industria. È quando le idee cominciano a scarseggiare e le imprese del settore si ritrovano a lottare per l’accesso a quelle poche idee buone rimaste che alcuni si rivolgono allo Stato – appellandosi alla proprietà intellettuale – per proteggere la loro vecchia e redditizia maniera di fare affari.
Se esaminiamo l’impegno profuso da Microsoft per impedire che il proprio software venga «rubato dai pirati», scopriamo che nei decenni iniziali lo sforzo, sia legale che tecnico, era minimo. A Microsoft, ovviamente, interessava senz’altro proteggere la sua proprietà intellettuale, ma non le premeva poi più di tanto rendere effettiva tale protezione, visto che aveva da fare altre cose maggiormente redditizie, come per esempio innovare. È solo ora, nel XXI secolo, che Microsoft investe tempo e risorse nella protezione del proprio potere di monopolio. È significativo, quindi, che, confrontando i sistemi operativi lanciati durante l’ultimo decennio, sia difficile rilevare in essi un’innovazione decisiva, mentre risulta piuttosto comune un andamento deludente. Basta pensarci un attimo per vedere che questa osservazione è applicabile più in generale: quale è stata la più grande innovazione di Microsoft dal 1994 a oggi? Senza dubbio il navigatore Internet Explorer. Ma chi ha inventato il navigatore? Non Microsoft, bensì un piccolo gruppo di concorrenti creativi dai quali più tardi Microsoft trasse l’idea (che non venne brevettata probabilmente solo perché In re Alappat arrivò con qualche mese di ritardo) acquistando, da un ente terzo che ne deteneva quasi per caso il copyright, la maggior parte del codice di base! La prima versione popolare di un navigatore, NCSA Mosaic, apparve nel marzo del 1993, mentre fu solo nell’agosto del 1995 che Microsoft lanciò Internet Explorer 1.0.
Provate a immaginare come dovrebbe essere riscritta la storia economica e sociale degli ultimi quindici anni se i creatori di Mosaic avessero avuto le risorse finanziarie di Microsoft e se, prevedendo che Amazon avrebbe un giorno brevettato il concetto di one-click con l’appoggio dei giudici federali, fossero riusciti a brevettare l’idea del navigatore di rete! Sarebbe davvero stato più utile a tutti se fosse stata applicata a questo caso la dottrina della proprietà intellettuale?
Software libero e aperto
La prova migliore che il copyright e i brevetti non sono necessari e che la concorrenza invece produce una notevole innovazione sta nel fatto che esiste una porzione sempre più rilevante del settore del software che ha volontariamente rinunciato al proprio monopolio intellettuale, ossia ha rinunciato sia al copyright sia ai brevetti. Questo straordinario esempio di creatività imprenditoriale in situazione di concorrenza è noto come open-source software (OSS). Quasi sempre questo software viene distribuito con una licenza che è l’opposto del copyright, e anzi in molti casi essa induce chiunque voglia vendere tale software a permettere ai suoi concorrenti di copiarlo. Tale accordo copyleft è un impegno volontario da parte dei produttori di software per evitare il monopolio intellettuale e operare in condizioni di libera concorrenza.
Vi chiederete come sia possibile che la rinuncia volontaria a un monopolio si incontri con l’interesse economico di una ditta o di un individuo: la risposta è, anzitutto, che questo fornisce un’importante assicurazione agli acquirenti del prodotto. Per esempio, un nuovo arrivato nel campo del software può trovare il suo mercato limitato dal fatto che i potenziali clienti si mostrano dubbiosi sulla sopravvivenza a lungo termine della ditta: chi è intenzionato ad acquistare non desidera certo ritrovarsi bloccato con un software brevettato, per poi magari vedere scomparire l’unico fornitore autorizzato. Non solo: quando io acquisto un software non brevettato mi aspetto di ricevere vantaggi dalla concorrenza futura, perché ogni nuovo prodotto concorrente, che usi lo stesso codice come punto di partenza e lo migliori, risulterà compatibile con quanto ho già installato. Ma questo vale anche per l’impresa che innova per prima: ogni nuovo concorrente che usi il mio codice e lo migliori dovrà rispettare le regole della licenza open-source o copyleft, il che mi permetterà, se ne sono capace, di utilizzare a mia volta la sua innovazione. Tutti questi fattori aumentano la domanda del prodotto open-source originario, cosicché, molto spesso, la rendita ottenuta dall’essere i primi a entrare nel mercato è sufficientemente alta da rinunciare volontariamente al monopolio futuro.
Nel caso del software open-source, è sorprendente quanto tale modalità sia diffusa, e soltanto i nostri paraocchi spesso ci impediscono di notarlo. Se oggi avete navigato in rete, è quasi certo che abbiate usato un software open-source. Sebbene probabilmente pensiate a voi stessi come a dei fruitori di Windows o di Macintosh, la realtà è che siete anche fruitori di Linux: ogni volta che usate Google, la vostra richiesta viene elaborata da un software open-source creato da L...