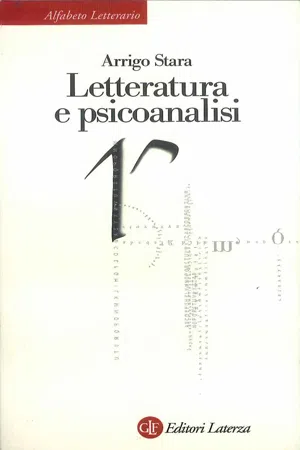1.
Un sapere di cui l’uomo non sa nulla
La scoperta freudiana
Il ‘Sacro Romano Impero’
«Ogni critico ha (o dovrebbe avere) la sua battuta critica preferita», scrive Harold Bloom (n. 1930) all’inizio del capitolo dedicato a Sigmund Freud (1856-1939) nel Canone occidentale (1994), il libro che racchiude la sua scelta degli autori fondamentali nella storia dell’intera tradizione occidentale. «La mia consiste nel paragonare la ‘critica letteraria freudiana’ al Sacro Romano Impero: non sacro, non romano, non impero; non freudiana, non letteraria, non critica». Sarà pure una battuta, anche divertente, ma è certo che il giudizio che contiene non avrebbe potuto essere più sprezzante. Quando poi, procedendo nella lettura, ci accorgiamo che il seguito del capitolo dedicato da Bloom alla psicoanalisi continua sulla stessa falsariga (essa gli appare come «una riduttiva parodia di Shakespeare», che per nostra fortuna «sta morendo, forse è già morta»), il sospetto che non si tratti solo di una battuta, ma di uno di quei motti di spirito tendenziosi che enunciano il proprio pensiero più autentico sotto forma di boutade, risulta confermato. Tanto più che Bloom non è il solo a pensarla così; si può dire anzi che, all’inizio del nuovo millennio, il numero di quanti concordano con la sua tesi si vada facendo ogni giorno più vasto: dopo soltanto un secolo dalla sua nascita, a poco più di cent’anni dalla pubblicazione dell’Interpretazione dei sogni (1899), la psicoanalisi, la scienza inventata da Sigmund Freud, celebra un anniversario che, per molti versi, ha già gli accenti di una celebrazione postuma.
Ma è poi mai stata davvero una scienza, la psicoanalisi? Può un uomo, come ha fatto Freud, inventarsi una scienza, attraverso i suoi scritti e con la conferma pressoché esclusiva, almeno nei primi anni, della propria pratica clinica? Alcune delle domande che avevano costituito la base della prima resistenza a Freud e alle sue teorie, al momento del loro apparire, sembrano essere tornate oggi di grande attualità. Ha ancora un senso, per noi, continuare a occuparci di psicoanalisi? Tanto più, quando non lo si faccia in maniera professionale, clinica, considerandola quale un metodo di cura per alcune malattie psichiche, ma la si utilizzi soltanto, per così dire, di scorcio, come un ausilio alla comprensione di un’altra forma di sapere, nel nostro caso la letteratura? Non si finirà con l’aggiungere un problema a un altro, vanificando in questo modo l’oggetto stesso della ricerca? E poi, quale bisogno hanno la letteratura, o la critica letteraria, del sostegno della psicoanalisi? Perché, si domanda Bloom, Freud dovrebbe essere utile per analizzare Shakespeare, e non Shakespeare per analizzare Freud? In fatto di psicologia, si chiede René Girard (n. 1923) in Critique dans un souterrain (1976), chi ci dice che un autore come Fëdor Dostoevskij (1821-1881) ne sappia meno di Freud? Chi fra i due potrebbe spiegare all’altro qualcosa, ad esempio, sul narcisismo, sull’ambivalenza dei sentimenti, sul conflitto con il padre, o sul senso di colpa?
Sono solo pochissimi esempi di un ripensamento del valore della psicoanalisi in rapporto alla letteratura e all’arte che appare sempre più diffuso e che, dopo una fase di relativa concordia, di pacificazione durata per qualche decennio (diciamo approssimativamente tra gli anni Sessanta e Ottanta del Novecento), sembra tornare a mettere in scena, come spesso accadeva nella saggistica dell’inizio del secolo, una sorta di conflitto di competenza fra due domini, o fra due imperi, per riprendere la metafora di Bloom: da un lato la letteratura, dall’altro la psicoanalisi, contro le cui pretese invadenti è legittima la rivendicazione, da parte della letteratura, di una totale egemonia sulle province del proprio territorio. Ma, potremmo chiederci oggi, di quale territorio, di quale impero si tratta? Quale è la posta in gioco? Tanto più che negli anni trascorsi dall’inizio del Novecento l’impero stesso, il territorio conteso, pare essersi trasformato in una sorta di continente quasi totalmente immaginario, a proposito del quale non avrebbe più alcun senso, dunque, rivendicare il proprio dominio su questa o quella provincia.
Il territorio che letteratura e psicoanalisi hanno in comune sembra essersi infatti, nell’arco di un secolo, modificato in maniera tale che entrambe fanno fatica a riconoscerlo, e a riconoscere la validità delle proprie pretese conoscitive riguardo a esso. Quel territorio è l’uomo, «la descrizione della vita interiore dell’uomo», come Freud scriveva nel saggio sulla Gradiva dal quale ho tratto l’epigrafe per questo lavoro; o meglio una parte, una metà dell’uomo, sopra la quale la psicoanalisi era sembrata potere accampare per prima le proprie pretese, salvo poi riconoscere invece che la letteratura, quella metà dell’uomo, l’aveva conosciuta, frequentata, abitata da sempre. Soltanto il nome trovato da Freud era nuovo, umile e insieme geniale: l’inconscio. Ma forse che l’uomo, prima di Freud, non aveva avuto un inconscio? E la letteratura non ne aveva parlato già da molti secoli, dalle antiche tragedie di Eschilo e di Sofocle, passando per i grandi classici, William Shakespeare (1564-1616) e Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), per arrivare fino ai romanzi più moderni, eccelsi come quelli di Dostoevskij, ma anche «più modesti» come quelli di Wilhelm Jensen (1873-1950) o come quelli prodotti dalla letteratura di consumo?
Non solo gli autori, ma persino i personaggi della letteratura, mostravano di conoscere, di essere in grado di mettere in scena l’inconscio molto tempo prima di Freud, che infatti proprio a essi si sarebbe dovuto richiamare. Basti pensare a Edipo, oppure ad Amleto; ma anche a Norbert Hanold – il protagonista del romanzo breve di Jensen Gradiva. Una fantasia pompeiana (1903) –, la cui nevrosi, la cui lunga rimozione, i cui deliri e sogni, fino ad arrivare alla conclusiva redenzione, sembravano avere anticipato punto per punto alcune delle più importanti scoperte di Freud. Che cosa mai, dunque, si poteva dire che egli avesse davvero scoperto? Proprio nel saggio sulla Gradiva, Freud fornisce una definizione particolarmente esplicita di inconscio:
Noi vorremmo che questo concetto di inconscio fosse sottratto a tutte quelle dispute dei filosofi e dei filosofi naturali, che per lo più si riducono a pure questioni etimologiche. Per il momento non disponiamo di un termine migliore per designare quei processi psichici che si comportano attivamente senza tuttavia giungere alla coscienza di una determinata persona, e questo è tutto ciò che vogliamo dire con il termine «inconscio».
Di questo «sapere di cui l’uomo non sa nulla» – come Freud scriverà in una delle lezioni di Introduzione alla psicoanalisi di qualche anno successive (1915-1917) – e che pure ne determina ogni comportamento, fino ai dettagli più infimi (come i lapsus, le paramnesie o gli atti mancati), ai quali nessuno scienziato aveva fino allora dato credito, soltanto i poeti sembravano avere avuto una qualche forma di consapevolezza. Freud non solo non vuole negarlo, ma è anzi deciso a condividere con loro la responsabilità della scoperta: «Probabilmente, noi e lui», scrive Freud, ossia lo scienziato e il poeta, «attingiamo alle stesse fonti, lavoriamo sopra lo stesso oggetto, ciascuno di noi con un metodo diverso; e la coincidenza dei risultati sembra costituire una garanzia che entrambi abbiamo lavorato in modo corretto».
Nessuna disputa con i poeti o i letterati, dunque, da parte di Freud; nessun desiderio di inoltrarsi in questioni di primogenitura o di filiazioni etimologiche sui termini essenziali della propria teoria; semmai, al contrario, la necessità di distinguersi, di fare i conti con una somiglianza perfino troppo ingombrante; il desiderio di non costringere nessuno dei due, né il poeta né lo scienziato, ad abdicare alla specificità del proprio metodo, pur davanti alla riconosciuta identità dell’oggetto della ricerca. Con buona pace di Bloom, allora, probabilmente Freud stesso avrebbe riso della tendenziosità trasparente della sua battuta sul «Sacro Romano Impero», visto che non riponeva affatto fra le proprie ambizioni quella di fondare qualcosa come una critica letteraria psicoanalitica, né tantomeno riteneva utile il perdere tempo in questioni di priorità. Il rischio semmai era per lui quello di confondere troppo, costretti dall’evidenza dei fatti, sapere letterario e sapere scientifico, perdendo di vista in tal modo una necessaria diversificazione delle competenze che egli, se soltanto avesse potuto, avrebbe preferito che fosse molto più netta.
Sul concetto di inconscio
La metafora di cui ci siamo appena serviti con l’avallo di Bloom – quella di un «impero», di un «territorio» o di un «regno» dell’inconscio – può permetterci intanto di dire qualcosa di preliminarmente necessario al nostro discorso su psicoanalisi e letteratura riguardo alla natura della scoperta di Freud. Che cosa ha scoperto Freud? Una regione, un dominio psichico, un regno situato nell’interiorità dell’uomo, che prima di allora era rimasto ancora sconosciuto, dove nessuno si era mai inoltrato, ma che nel passato avrebbe potuto magari essere ritrovato ed esplorato da qualcun altro: da un filosofo come Platone o Nietzsche, da uno scienziato come Copernico o Darwin, oppure da uno scrittore di genio come Shakespeare, Goethe o Dostoevskij? Certamente no; ma il paradosso è che, se ci fosse stato nell’uomo un territorio, un «regno» come quello dell’inconscio da scoprire, essi certamente l’avrebbero fatto. Prima di Freud dunque – in un senso che vorremmo cercare di comprendere – l’inconscio, nei termini in cui oggi se ne parla, non esisteva; la scoperta di Freud è dunque qualcosa di totalmente diverso da un ritrovamento, dal disoccultamento di qualcosa che prima era già lì.
Ma Freud neppure ha inventato l’inconscio. Se Freud si fosse semplicemente inventato l’inconscio dal nulla, esso di certo non avrebbe convinto nessuno, né tantomeno la psicoanalisi avrebbe potuto guarire la gente da alcuni mali che sembravano al tempo di Freud (e in parte sono ancora oggi) straordinariamente diffusi. La scoperta di Freud non rassomiglia dunque né a un ritrovamento, né a un’invenzione, ma sembra piuttosto avere a che fare con qualcosa cui accenna un teorico della letteratura come Francesco Orlando (n. 1934). All’inizio di un saggio sul Repertorio dei modelli freudiani praticabili del quale mi servirò spesso in questo lavoro, Orlando scrive, riprendendo una formula «sfolgorante» di Jacques Lacan (1901-1981), che noi non dobbiamo convincerci, né credere, né avere fede nella teoria di Freud; noi dobbiamo, piuttosto, «prendere posto in essa» («A una verità nuova non ci si può accontentare di far posto», suonano esattamente le parole di Lacan nel saggio L’istanza della lettera nell’inconscio, «si tratta piuttosto di prender posto, il nostro posto in essa»).
Non si prende posto in una filosofia, in una religione o in una scienza. Nello stesso senso, non si prende posto in una teoria o in un’opera letteraria. Vogliamo dire qualcosa di molto diverso, quando ci definiamo, ad esempio, cristiani, o cartesiani, o proustiani, oppure, appunto, freudiani. Nelle teorie di Freud non si crede, ma neppure ci si può dire certi di esse, come se si trattasse di convinzioni matematiche o fisiche. Come Marx, come Darwin, Freud appartiene invece a quella specie di pensatori tipicamente moderni (ma non solo) che, riprendendo una formula di Michel Foucault (1926-1984), potremmo chiamare «fondatori di discorsività». Marx, Darwin o Freud, scrive Foucault, sono ben più che autori di libri; essi sono fondatori «di una teoria, di una tradizione, di una disciplina all’interno della quale altri autori e altri libri potranno a loro volta prender posto». Essi sono all’origine di una «possibilità indefinita del discorso»; la loro parola originale, fondativa, spalanca uno spazio, un «territorio» appunto, entro il quale innumerevoli altri scrittori potranno a loro volta muoversi, secondo un complesso reticolo di similarità e differenze con quella parola fondativa (ciò che giustifica, soltanto a loro riguardo, l’idea di un ritorno a). Ma esisteva il marxismo prima di Marx, o il darwinismo prima di Darwin? In un senso dovremmo dire certamente di sì; ma immediatamente dopo quella nostra risposta ci sembrerà paradossale. Marx o Darwin aprono delle possibilità di discorso, stabiliscono un ponte, un contatto fra il reale e il simbolico, fra il mondo e il linguaggio, assolutamente inediti; pure non scoprono nulla, né la realtà del lavoro alienato e del capitale, né le leggi dell’evoluzione degli esseri organici sulla terra. Con la loro parola aprono un varco, stabiliscono un contatto, danno forma a un insieme di fatti e di leggi che prima non ne aveva alcuna. Una volta aperta quella breccia e stabilito quel passaggio, per moltissimi altri pensatori sarà possibile entrare nei territori aperti da quella loro fondazione, e procedere oltre.
La strategia di Münchhausen
Della stessa natura è la scoperta dell’inconscio. Quella di Freud è una tipica parola fondativa: pure essa non scopre nulla, non rivela nulla che già non fosse lì. Il suo non è un discorso religioso, filosofico, letterario, scientifico: è un tipo di discorso che ha con il proprio oggetto una relazione che per certi versi, rispetto alla scienza del passato, può apparire del tutto nuova e sorprendente. Per definirla, potremmo ricorrere a uno dei pensieri contenuti nelle Minima moralia (1947) di Theodor W. Adorno (1903-1969), nel quale viene delineata una figura, un’immagine archetipica, quasi un moderno mito di fondazione, inscritto in molti degli esiti più rilevanti del pensiero del ventesimo secolo.
Al pensatore odierno non si chiede niente di meno che questo: essere nello stesso momento nelle cose e al di fuori delle cose; e il gesto del barone di Münchhausen, che si solleva dallo stagno afferrandosi per il codino, diventa lo schema di ogni conoscenza che vuole essere qualcosa di più che constatazione o progetto.
Il barone di Münchhausen, il protagonista di quella serie di opere dove vengono narrate le sue fantastiche avventure, è un grande bugiardo, un fanfarone, un mentitore nato che non ha affatto paura dell’eventuale inverosimiglianza dei propri racconti. Fra essi, uno dei più celebri è quello in cui egli, caduto dentro una palude, in procinto di venire ricoperto dal fango, cerca disperatamente un qualunque appiglio per venirne fuori. Non trovandone alcuno, pensa di potere usare i propri capelli come una fune, e di potere uscire dalla palude aggrappandosi ad essi: ci prova, e il suo tentativo naturalmente riesce. L’immagine di questa sua peripezia ricorre moltissime volte, quasi fosse una specie di archetipo, nelle pagine di alcuni dei più originali pensatori del Novecento: Münchhausen che si salva grazie al proprio codino è l’emblema di un tipo di ricercatore che deve creare allo stesso tempo il proprio oggetto e la teoria di quell’oggetto; che non ha, in parole più semplici, alcun territorio predeterminato, sicuro e stabile, sopra il quale poter condurre le proprie osservazioni.
La fisica ha dato un nome scientifico a questa avventura di Münchhausen; l’ha chiamata ipotesi, o effetto, o modello, del bootstrap, ossia, letteralmente, «tirante di stivale», più esplicitamente del «sollevarsi reggendosi ai tiranti dei propri stivali». È un’immagine che oggi ricorre anche nell’epistemologia delle scienze più rigorose (fisica, biologia, matematica, informatica) e che troviamo immancabilmente iscritta nei momenti di fondazione delle cosiddette scienze del linguaggio (linguistica, filosofia). Indica la compenetrazione, l’indistinguibilità fra il modello fondativo di una scienza e la teoria che ne consegue, fra oggetto di un sapere e sapere su quell’oggetto. Se leggiamo, ad esempio, le pagine di Ferdinand de Saussure (1857-1913) all’inizio del Corso di linguistica generale (1916), o di Ludwig Wittgenstein (1889-1951) ad apertura delle Ricerche filosofiche (1953), ci rendiamo conto di come la loro difficoltà principale stia proprio nel tenere distinto quanto nel loro sapere dovrà essere oggetto, e quanto di quell’oggetto dovrà invece essere regola, legge, teoria. Proprio come Freud, anche Saussure o Wittgenstein scoprono un territorio del quale è difficilissimo stabilire i confini, ossia le leggi, perché essi sono inestricabilmente confusi e indistinguibili dalle normali strade, come dire dai contenuti, dalla materia della loro teoria.
Se andiamo all’inizio del Corso di linguistica generale, o all’apertura delle Ricerche filosofiche, notiamo come tanto Saussure quanto Wittgenstein, come già era accaduto a Freud qualche anno prima, siano costretti a compiere una serie di passi preliminari che ci appaiono indispensabili per il modo di procedere di questi pensatori. Nessuno di loro muove dalla sfiducia nella scienza che li ha preceduti; anzi, essi cercano con ogni mezzo di trovare delle leggi in grado di racchiudere il sapere che hanno ereditato dal passato i...