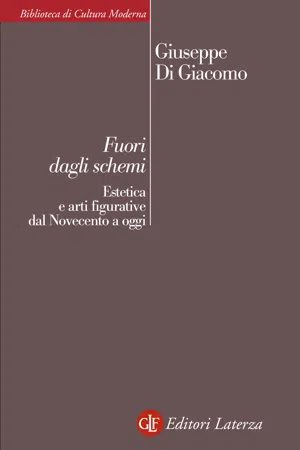
- 240 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Un percorso che attraversa più di un secolo di storia dell'arte, dall'Astrattismo all'Espressionismo astratto, dal Dadaismo alla Pop Art, dal Cubismo alle tendenze più significative degli ultimi decenni. Giuseppe Di Giacomo individua i temi e i problemi teorici fondamentali della produzione artistica moderno-contemporanea: il rapporto tra arte e realtà, il ruolo del mercato e quella connessione di etica ed estetica, di memoria e testimonianza che caratterizza alcuni fenomeni artistici dagli anni Ottanta in poi.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Fuori dagli schemi di Giuseppe Di Giacomo in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Filosofia e Estetica in filosofia. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
FilosofiaCategoria
Estetica in filosofia1. Arte e filosofia
dai primi del Novecento ai giorni nostri
1.1. La questione della modernità
Il presente libro non è una storia dell’arte in senso stretto, né un insieme di critiche o di teorie dell’arte: esso si pone all’incrocio di queste modalità di approccio. Presentare l’arte del XX secolo in modo da renderla comprensibile sembra tanto più necessario, dal momento che essa non ha fatto altro che dedicare le proprie energie alla distruzione di tutti i modelli di riferimento. Per comprendere l’arte del Novecento, non è possibile prescindere da quelle avanguardie, quali l’Astrattismo1 e il Dadaismo, che sono state in grado di operare una sovversione dei paradigmi tradizionali dell’opera d’arte, che fino alla fine del XIX secolo si affidavano alla dimensione mimetica e referenziale dell’immagine, alla sua compiutezza e alla sua capacità di esprimere la Bellezza, l’Eternità e il Senso assoluto. Di particolare interesse è il fatto che negli anni Dieci del XX secolo Marcel Duchamp inventi il ready-made e Kazimir S. Malevič dipinga il Quadrato nero su fondo bianco: si tratta di due eventi di una portata tale da segnare le due strade principali che determineranno la produzione artistica di tutto il Novecento, pur essendo fra loro antitetici.
Se infatti il Quadrato nero fa tabula rasa del passato e del concetto di mimesis, e troverà il suo sviluppo nell’Espressionismo astratto americano e in altre manifestazioni astrattiste successive, basandosi sulla netta separazione fra arte e vita (realtà), il ready-made invece mette in crisi in maniera radicale proprio tale separazione, identificando l’arte con la vita (realtà), secondo un orientamento che approderà alla Pop Art, al Minimalismo e a certe tendenze dell’arte degli ultimi decenni. Tuttavia, mentre nel Quadrato nero il rifiuto della rappresentazione implica la persistenza della rappresentazione stessa, il ready-made rinuncia alla rappresentazione mediante la «presentazione» dell’oggetto in quanto tale. In questo senso, Pablo Picasso esprime con la sua opera il tentativo estremo di tenere insieme le due tendenze perché, proprio nel momento in cui il Cubismo sembra sfociare nell’Astrattismo, egli arresta tale processo, inserendo nei suoi quadri elementi naturali e materiali che reintroducono la realtà esterna all’interno del quadro. È quanto gli rimprovereranno non a caso quegli astrattisti, come Malevič e Piet Mondrian, che attraverseranno il Cubismo per arrivare all’astrazione totale.
Non bisogna d’altronde cadere nell’equivoco di tradurre queste due strade maestre in termini di contrapposizione tra figuratività e non-figuratività: di fatto l’elemento della figurazione resta un riferimento imprescindibile anche in ambito astrattista, seppur negato dialetticamente, oppure, come accade in artisti come Francis Bacon e Alberto Giacometti, mantenuto attraverso un’operazione di s-figurazione in cui si manifesta paradossalmente il rifiuto della figura stessa. Dirompente è il recupero della figurazione intesa in termini mimetico-referenziali, che ha fatto la fortuna di grandi star dell’arte contemporanea come Jeff Koons e Damien Hirst. Se perciò in modalità concettualmente opposte la figurazione continua ad attraversare l’arte del Novecento, a tal proposito resta decisiva, come vedremo, la riflessione che Theodor W. Adorno nella sua Teoria estetica rivolge alla nozione di mimesi la quale, piuttosto che ridursi a sinonimo di copia, esprime l’esigenza che l’arte moderna ha di dire qualcosa del mondo senza però identificarsi con esso. Mimesi, infatti, nella terminologia adorniana indica la capacità dell’opera di prendere posizione nei confronti del vigente in maniera critica, sempre però a livello di forma, che deve assumersi l’obbligo etico di denunciare e testimoniare le fratture e il non-senso della realtà. Questo è il «contenuto di verità» dell’opera, che è mimesi non già di un modello a essa esterno, ma «mimesi di se stessa», ovvero rappresentazione della storia in essa accumulata e sedimentata; è quanto troveremo nell’Astrattismo (soprattutto nelle fasi finali dei suoi maggiori rappresentanti) e in autori come Paul Klee, Jackson Pollock e i già citati Bacon e Giacometti. Perciò l’opera d’arte continua a rappresentare il mondo, rinunciando però a quel didascalismo che è finito, in maniera sempre più decisa, a servire gli interessi del mercato e dell’industria culturale.
È indubbio che nell’arte del Novecento si ha a che fare con il superamento della contrapposizione fra tradizione e modernità: se infatti la tradizione è trasmissione di un modello da un secolo all’altro, la modernità è caratterizzata da un continuo superamento dei modelli e dei codici precedenti, tanto che in questo caso è la stessa rottura a costituire la tradizione. Una tale «tradizione moderna» designa il periodo storico che ha inizio verso la metà del XIX secolo con la messa in discussione dell’accademismo, basato sulla concezione secondo la quale al reale deve subentrare l’ideale. Charles Baudelaire e Gustave Flaubert in letteratura, Gustave Courbet e Édouard Manet in pittura sarebbero i primi moderni, i fondatori di questa nuova tradizione, seguiti dagli impressionisti e dai simbolisti, da Paul Cézanne e da Stéphane Mallarmé, dai cubisti e dai surrealisti. A voler radicalizzare una tale prospettiva, ci troviamo di fronte al fatto, apparentemente sconcertante, che il «conformismo del non conformismo» è il circolo vizioso di ogni avanguardia. Allo stesso modo la contrapposizione tra classicismo e romanticismo, fra antico e moderno, è ormai solo quella fra due presenti: l’idea è che i classici sono stati i romantici del loro tempo, mentre i romantici di oggi saranno i classici di domani. Insomma, se l’attualità di oggi diventa il classicismo di domani, allora la modernità si rovescia continuamente nel classicismo e diventa la propria antichità. Sarà Baudelaire, l’osservatore più perspicace del XIX secolo, a valutare meglio di chiunque altro gli effetti dell’identificazione dell’arte con l’attualità. E se il senso del presente è per Baudelaire costitutivo di ogni esperienza estetica, resta il fatto che il paradosso è evidente nell’espressione di «rappresentazione del presente» che stabilisce una distanza rispetto allo stesso presente nel momento in cui ne afferma l’immediatezza.
È a partire da qui che Baudelaire arriva all’analisi dei rapporti tra arte e moda; analisi che consiste nel distillare dalla moda ciò che essa può contenere di poetico nella trama del quotidiano, e quindi nell’estrarre l’eterno dall’effimero. Insomma, a una modernità che, intesa come senso del presente, annulla ogni rapporto con il passato, al movimento continuo e inarrestabile di una modernità schiava del tempo e che si autodivora, negando la novità di ieri, Baudelaire contrappone l’eterno e l’atemporale. Il poeta ritiene che Courbet e Manet abbiano fallito a causa del loro positivismo, perché dipingono senza immaginazione ciò che vedono. In questo modo, sfugge a Baudelaire la modernità della loro pittura, cioè l’incompiutezza, la frammentazione, l’assenza di totalità e di senso; si tratta di caratteri che contribuiscono alla distruzione dell’illusione legata alla prospettiva geometrica rinascimentale e a quell’appiattimento della pittura che va di pari passo con la perdita di senso di quest’ultima. Con Baudelaire sono così annunciati i tratti essenziali e paradossali della tradizione moderna, tradizione che per lui è sempre inseparabile dalla decadenza. E se Courbet e Manet hanno fatto scandalo, come del resto anche Flaubert e Baudelaire, tuttavia in nessuno di loro si ritrova quel tratto che è divenuto ai nostri occhi caratteristico della modernità: la consapevolezza della rottura con il passato e insieme la consapevolezza del rifiuto di un inizio e di una fine rigorosamente stabiliti. I primi moderni non ricercano il nuovo e non credono nel dogma del progresso, dello sviluppo e del superamento; il loro eroismo è quello del presente, non del futuro, dal momento che utopia e messianismo sono a loro sconosciuti. Insomma, i primi moderni non immaginano di costituire un’avanguardia.
Di fatto, se la modernità si identifica con una passione per il presente, l’avanguardia presuppone la volontà di essere in anticipo sul proprio tempo, con la conseguenza che a costituire l’avanguardia sono due dimensioni contraddittorie: la distruzione e la costruzione, la negazione e l’affermazione. A proposito di questa tensione dialettica che attraversa la modernità, già per Hegel quest’ultima rappresenta il momento in cui il contingente e l’eterno si contrappongono, sì che da un lato abbiamo l’Immutabile e dall’altro il Mutevole. Ovviamente, per Hegel l’essenza dello Spirito è il coesistere di entrambi in Uno ma, secondo lui, l’essenza del modernismo consiste nel non riuscire a cogliere quest’unità. La «Coscienza infelice» sa di essere duplice e divisa ma non sa, o non può accettare, che tale divisione sia la sua unità, né tale coscienza potrà mai afferrare la mera differenza, abbracciandola come la propria Verità, perché la differenza si fonda sulla in-differenza, il contingente sull’essenziale ed è per questo che, come scrive Malevič, «Dio non è stato detronizzato».
La tradizione moderna è la storia della purificazione dell’arte, della sua riduzione all’essenziale, insomma del suo «formalismo». Per collocare gli inizi di questo formalismo si cita abitualmente la frase del pittore Maurice Denis del 1890: «Ricordarsi che un quadro, prima di essere un cavallo di battaglia, una donna nuda o un qualunque dettaglio, è essenzialmente una superficie piana coperta di colori riuniti secondo un certo ordine»2. Questo è indubbiamente un richiamo all’autoreferenzialità e all’autonomia, considerate ormai come condizioni dell’arte autentica. È sufficiente portare al suo termine questa liberazione dalla forma per emancipare la pittura da ogni rappresentazione di oggetti riconoscibili, cioè da ogni oggetto quale che sia: il mondo esteriore scompare dalla pittura. Che resta allora da dipingere se si afferma che gli oggetti nuocciono alla pittura e che è necessario liberare l’arte dal peso inutile dell’oggetto? Del resto, come giudicare e valutare le opere che rivendicano la loro totale autonomia e rifiutano i criteri accademici e tradizionali ereditati dal passato? Saranno questi i problemi affrontati dai maggiori rappresentanti dell’avanguardia di inizio Novecento. La pittura appare come il semplice pretesto per una rivoluzione filosofica e spirituale più globale, nella quale i problemi formali finiranno per scomparire, rivelando che agire sulla forma delle opere fino all’astrazione più totale significa agire sul loro contenuto e creare idee nuove.
È questa convinzione che permette a Vasilij Kandinskij di enunciare uno dei problemi fondamentali dell’estetica e dell’arte del XX secolo: per lui la questione dell’arte è una questione non solo di forma, ma soprattutto di contenuto artistico. Il manifesto del Suprematismo, esposto da Malevič nel 1915, testimonia ugualmente una innegabile dimensione filosofica, in quanto affermare la supremazia della sensibilità pura nelle figure geometriche sprovviste di ogni significato vuol dire mettere in causa, in modo radicale, la rappresentazione classica e figurativa dell’oggetto come ciò che dà accesso alla conoscenza. In Malevič questa filosofia dello «zero delle forme» ha valore di metafisica e di teologia, almeno finché la Russia e la rivoluzione gli lasciano intravedere la possibilità di un mondo nuovo. Del resto, anche la «rivoluzione surrealista» enuncia il programma di una filosofia del cambiamento: cambiare la vita e, più tardi, cambiare la politica, perché il Surrealismo possa mettersi al servizio della rivoluzione (comunista). Nei due manifesti del Surrealismo (1924 e 1930), infatti, André Breton è sufficientemente chiaro sulle implicazioni filosofiche del movimento, perché non lo si riduca semplicemente a una corrente letteraria e artistica. In definitiva, è indubbio che gli artisti delle prime avanguardie e quelli tra le due guerre siano i primi teorici delle loro opere. Essi esplorano le molteplici possibilità offerte dalla loro epoca, legate all’utilizzazione di nuovi materiali e procedimenti e alla scelta di forme inedite, interrogandosi nello stesso tempo sulle implicazioni sociali, politiche e metafisiche dell’arte moderna.
Bisogna attendere l’inizio degli anni Sessanta perché il dibattito politico-estetico si attenui progressivamente. Lo sviluppo dei mezzi di riproduzione, le possibilità di diffusione di massa e l’accesso di un pubblico sempre più largo a tutte le forme dell’arte moderna e contemporanea modificano in profondità la percezione delle finalità della creazione artistica. Se la fine degli anni Sessanta vede risorgere le idee avanguardiste degli anni Venti, la volontà di rimettere in vigore il progetto di emancipazione e di cambiamento formulato dai movimenti radicali dell’epoca si arena davanti al potenziamento sempre maggiore della società dei consumi. L’esposizione di potenti sistemi di produzione e di distribuzione di oggetti culturali accelera l’integrazione di tutte le forme d’arte passata e attuale nel circuito complesso, e a volte imprevedibile, della promozione e del rilancio economico. Più che mai si tratta di dissipare le zone d’ombra e di incomprensione che oscurano le relazioni tra il pubblico e l’arte attuale, e nello stesso tempo di accompagnare l’avventura imprevedibile e sempre inedita della creazione artistica. Resta comunque il fatto che, superati o no, i dibattiti avvenuti alla svolta del XX secolo hanno in effetti lasciato tracce profonde nel modo di percepire i rapporti che l’uomo delle società postindustriali intrattiene con le differenti forme di espressione della sensibilità e dell’immaginario. Di fatto, o si considera l’arte moderna e la dislocazione delle forme tradizionali come un riflesso della decadenza della società occidentale, o si vede in esse un modo di espressione privilegiato, grazie al quale gli artisti adottano una posizione critica di fronte alla realtà, ed enunciano precisamente ciò che è accaduto nel mondo con la speranza di trasformarlo. D’altronde non si può non constatare la destabilizzazione della teoria estetica di fronte allo sviluppo senza precedenti di una cultura planetaria: la messa in causa della modernità, l’esigenza di un ritorno ai valori classici e la dissoluzione dei criteri di giudizio che disorientano sia la critica che il pubblico.
1.2. Benjamin e Adorno: perdita dell’aura e autonomia dell’arte
In L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica (1936), Benjamin sostiene che il «valore cultuale» dipende dall’autenticità dell’oggetto sacro, le cui proprietà miracolose o creative non vengono trasmesse alle repliche o alle riproduzioni, mentre la cultura delle copie a stampa di opere d’arte originali, che comincia a diffondersi nel Rinascimento, aggiunge il «valore espositivo» a quello cultuale. Ma questa forma di copia è nettamente distinta dall’opera d’arte, il cui statuto originale rimane intatto; e tale statuto di unicità è proprio ciò che Benjamin chiama «aura». Un cambiamento radicale delle condizioni di produzione avviene con l’industrializzazione, basata sulla produzione in serie di oggetti a partire da una matrice o «stampo», come mostra la fotografia quale mezzo di riproduzione completamente meccanico. L’autenticità e l’aura connessa all’originale vengono così strutturalmente rimosse dall’oggetto prodotto meccanicamente che, come sostiene Benjamin, sostituisce una molteplicità di copie a un’esistenza unica. Se è possibile descrivere tale esistenza come legata al tempo e al luogo della sua origine, e quindi distante da chi la guarda, la riproducibilità tecnica annulla questa lontananza, perché soddisfa l’esigenza di impossessarsi dell’oggetto attraverso la riduzione della distanza nella riproduzione; afferma inoltre Benjamin che «la liberazione dell’oggetto dalla sua guaina, la distruzione dell’aura sono il contrassegno di una percezione, la cui ‘sensibilità’ per ciò che nel mondo è dello stesso genere, è cresciuta a un punto tale che essa, mediante la riproduzione, attinge l’eguaglianza di genere anche in ciò che è unico»3. Il numero degli artisti le cui opere sono state consciamente o inconsciamente ideate per la riproducibilità (da Duchamp a Andy Warhol, e così via) avvalora la previsione di Benjamin secondo la quale il cambiamento del modo di produzione avrebbe spazzato via tutti i valori estetici che lo precedono.
Le riflessioni estetiche di Benjamin non sono mai espresse nella forma di un’opera coerente; Parigi, la capitale del XIX secolo (1940) simboleggia per lui le contraddizioni della modernità, quelle stesse che Baudelaire era arrivato a esprimere sul modo della creazione poetica: come si possono continuare a realizzare opere d’arte in piena rivoluzione industriale, all’apogeo del capitalismo? Moltiplicare un’opera d’arte per presentarla simultaneamente a una moltitudine di spettatori compromette o no l’originale? Di fatto, per Benjamin è vero che qualcosa cambia; ma tale cambiamento riguarda meno l’originale in se stesso che il rapporto tra il pubblico e l’opera originale propriamente detta. Ci...
Indice dei contenuti
- Prefazione
- 1. Arte e filosofia dai primi del Novecento ai giorni nostri
- 2.Le avanguardie storiche
- 3. L’arte tra figurazione e rifiuto della forma
- 4. L’Espressionismo astratto: il ritorno dell’Astrattismo nell’arte americana del secondo dopoguerra
- 5. Coincidenza di arte e vita: processi di mercificazione della produzione artistica
- 6. Estetica ed etica: l’opera d’arte come testimonianza
- Bibliografia