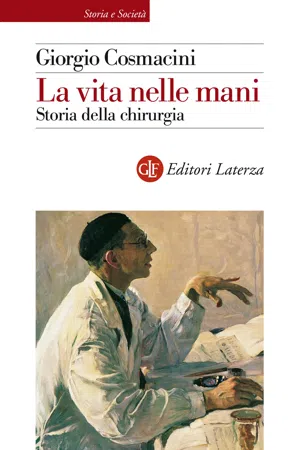Capitolo quarto.
L’Età moderna
1. La chirurgia sperimentale
Il Rinascimento è stato un periodo nel quale una maggiore disponibilità di risorse consentì alla popolazione europea di espandersi notevolmente e anche di contare su di un modico aumento dell’aspettativa di vita alla nascita: un indice di salute, dati i tempi, non del tutto irrilevante, ma al quale la rinascimentale arte della cura, e in essa la chirurgia, non portò un contributo di rilievo. Si viveva, ci si ammalava, si premoriva o si sopravviveva, si invecchiava, indipendentemente o quasi dai presìdi dell’arte.
La realtà era diversa dal sogno. Questo era passato, e passava ancora, attraverso l’aspettativa della longevità garantita o dell’eterna giovinezza. Passava anche attraverso l’idea della trasmutazione del metallo ignobile, il piombo, nel metallo nobile, l’oro, e attraverso il corollario della trasformazione dell’oro stesso da solido a liquido. L’«oro potabile» prometteva di essere la pozione magica della salute perenne, l’«elisir di lunga vita» già promesso dagli alchimisti del Medioevo. Ma il sogno della longevità passava anche attraverso l’idea della trasfusione dell’umor vitale per eccellenza, il sangue, veicolante il «calore innato» e l’«umidità radicale», qualità elementari e primarie della corporea materia vivente. Si trattava, peraltro, di un’idea trasferibile in una pratica chirurgica che, rispetto alla pratica alchemica, era sì altrettanto miracolosa, però molto più pericolosa.
Le forze vitali di papa Innocenzo VIII [Giovanni Battista Cybo], scrive Pasquale Villari nella sua Vita di Girolamo Savonarola (Firenze 1859), svanivano rapidamente. Si cercava invano ogni mezzo per ridestare la spenta vitalità del Papa, quando un medico ebreo propose di tentare con un nuovo strumento la trasfusione del sangue: cosa tentata fino allora soltanto sugli animali. Il sangue del decrepito Pontefice doveva passare tutto nelle vene di un giovane che doveva cedergli il suo. Tre volte fu tentata la difficile prova, nella quale, senza alcun giovamento del Papa, tre giovinetti perdettero successivamente la vita, forse a cagione di aria introdottasi nelle loro vene. Il giorno 25 aprile 1492 cessava di vivere Innocenzo VIII1.
Papa Innocenzo VIII, per aver regnato sul trono di Pietro fino al 1492, data periodizzante che secondo molti storici segna il passaggio all’Età moderna, può essere considerato l’ultimo papa dei «secoli bui»; come buia fu considerata la figura del chirurgo ebreo che lo trasfuse. «Detta e ridetta un cospicuo numero di volte», questa favola è «diventata un classico della storia delle trasfusioni»2, così come nella storia delle amputazioni è diventata un classico la diceria dello spregiudicato, omicida intervento chirurgico compiuto venticinque anni dopo da un altro chirurgo ebreo sul corpo ferito di Giovanni dalle Bande Nere (vedi il Prologo di questo libro).
Pregiudizi antiebraici a parte, l’idea della trasfusione di sangue fu abbozzata da Francis Bacon (1561-1626), Bacone, nella sua utopistica New Atlantis (Londra 1637). Nella visione avveniristica di migliorare e prolungare la vita umana, Bacone pensò che si sarebbe potuto ritardare l’arresto della macchina-uomo mediante un ricambio del sangue che alimentava la macchina. I baconiani della Royal Society preconizzarono i benefici che in futuro sarebbero potuti derivare all’uomo dalla sostituzione dei suoi organi avariati con organi sani o dalla sostituzione dei suoi vecchi umori guasti con umori giovani e freschi. Era il presentimento di una futurologia organicista, che puntava al ricambio degli organi, e di una futurologia umoralista, che si sarebbe realizzata un giorno con la dialisi del sangue.
A prescindere dai precorrimenti, in un rendiconto degli esperimenti fisiologici compiuti sotto l’egida della Royal Society è detto di un certo Mister Gayant che «trasfuse il sangue di un cane giovane nelle vene di un cane vecchio, il quale due ore più tardi saltava e faceva capriole, mentre prima riusciva appena a muovere la coda». Fu Richard Lower (1631-1691), autore di un Tractatus de corde (Londra 1668) posteriore di quarant’anni al De motu cordis (Francoforte 1628) di William Harvey (1564-1642), fondatore della moderna fisiologia cardiocircolatoria, colui che praticò nel 1666 il primo tentativo sperimentale della trasfusione di sangue animale, da cane a cane, mettendo in comunicazione l’arteria carotide dell’animale donatore con la vena giugulare dell’animale ricevente. Un anno dopo, il 15 giugno 1667, fu Jean-Baptiste Denis (1620-1704) il primo a praticare la trasfusione di sangue nell’uomo. Egli trasfuse tre once di sangue d’agnello a un giovane demente, ottenendo in modo tanto fortuito quanto fortunato una sorta di ematoshock salutare, che favorì per breve tempo un certo credito nei confronti della pratica prematura, rischiosa e perniciosa, dell’emotrasfusione3.
L’azzardata pratica, eseguita da chirurghi ancora ignari di gruppi sanguigni e di incompatibilità gruppali, era comunque una tappa sul percorso di quella chirurgia sperimentale che, attraverso un «arrischiato provando e riprovando» e «al banco di prova del tentativo in corpore vili»4, contribuì allo sviluppo della seicentesca anatomia viva o fisiologia. Quest’ultima fu anche l’approdo dell’anatomia chirurgica del Cinquecento, nata con Vesalio e cresciuta, nella stessa Padova, con gli anatomisti post-vesaliani Matteo Realdo Colombo (1515-1559), scopritore della circolazione sanguigna cuore-polmoni, Gabriele Falloppio (1523-1562), scopritore delle tube uterine, e Girolamo Fabrizi d’Acquapendente (1533-1619), scopritore delle valvole venose confermanti l’unidirezionalità del fluire del sangue.
Fabrizi, lettore di chirurgia con l’obbligo d’insegnare anche anatomia, era stato il chirurgo più in voga nell’Italia del Rinascimento. In lui le innovazioni in campo chirurgico erano andate di pari passo con le scoperte in campo anatomico: con lui la chirurgia aveva potuto diventare una tecnica sempre più raffinata, una pratica sempre più arricchita di scienza. Grazie all’abilità nella legatura delle arterie, Fabrizi operava con poco spargimento di sangue; sapeva come eseguire la litotomia seguendo perfettamente la curvatura dell’uretra; sapeva come meglio praticare la «scannazione» (tracheotomia) per ovviare allo «strozzamento» da mal del garrotillo (croup difterico); sapeva applicare con maestria ingegnosi apparecchi ortopedici per curare il gibbo e il collotorto. Richiestissimo dai più illustri personaggi del tempo, era stato lo specialista sublimato a consulente del potere, creato cavaliere dal Senato veneziano «con ricca ricompensa di collana e medaglie»5.
La conoscenza anatomo-fisiologica della direzione del fluire del sangue venoso, regolata da valvole, permise a Fabrizi di ridurre, mediante compressioni e legature (non delle vene, ma delle arterie), l’irrorazione sanguigna del campo operatorio, con grande vantaggio per le operazioni chirurgiche; all’inverso, la chirurgia sperimentale su cani vivi, «legati e incisi nel basso ventre», consentì a Bartolomeo Eustachi (1500-1574), in cattedra alla Sapienza di Roma, di pervenire alla conoscenza anatomo-fisiologica «di qual guisa l’orina dagli ureteri scendesse in vescica». L’Eustachi, autore degli Opuscula anatomica (Venezia 1564), fu colui che diede il nome ai condotti – «trombe di Eustachio» – che uniscono orecchi e retrobocca; ma soprattutto fu colui che mise il sigillo dei tempi alla sperimentazione anatomica: l’anatomista, tagliati i nervi ricorrenti ai cani perché non potessero latrare, «apriva» gli animali vivi «per far vedere in qual modo il cuore battesse»6.
La rilevanza della chirurgia sperimentale quale fornitrice di conoscenza anatomo-fisiologica era ormai universalmente acclarata. Amato Lusitano (1514-1568), medico ebreo portoghese migrato in Italia, nel prendere partito nella «centuria prima» delle sue sette Curationum medicinalium centuriae (pubblicate tra il 1549 e il 1561) in merito all’annosa questione circa la vena da salassare in caso di polmonite – vena che Vesalio diceva dover essere sempre quella dell’avambraccio destro, mentre altri (tra cui lo stesso Amato) dicevano dover essere quella dell’avambraccio dello stesso lato del polmone affetto –, aveva puntualmente descritto la propria sperimentazione, compiuta nel 1547 a Ferrara, con la quale, insufflando aria nella vena cava, diceva d’aver visto la vena azygos gonfiarsi e viceversa, insufflando aria nella vena azygos, d’aver visto la vena cava restar floscia; dal che aveva ritenuto di poter arguire la direzione del flusso del sangue venoso dalla vena cava alla vena azygos e non in senso contrario. Era invece proprio un controsenso, un errore: il sangue venoso non fluisce in quella direzione, ma in direzione opposta.
Come poté mai accadere che una sperimentazione che abbiamo motivo di ritenere compiuta correttamente avesse prodotto dei risultati falsamente positivi? Il blocco mentale della dominante dottrina galenica – questa la possibile spiegazione – impedì ad Amato la falsificazione della sua verifica. Di che meravigliarsi? Lo stesso Vesalio aveva negato l’evidenza dei fatti allorché aveva sostenuto che il setto cardiaco interventricolare, da lui osservato come compatto e impermeabile, doveva essere considerato cribroso e pervio al passaggio del sangue (dal ventricolo destro al ventricolo sinistro) in ossequio all’autorità di Galeno e all’infinita potenza di Dio. Ciò che più conta è il fatto che la sperimentazione anatomica fosse, già a metà Cinquecento, ritenuta fondamentale ai fini della conoscenza fisiologica, premessa indispensabile di una buona chirurgia. Scrive Amato che un chirurgo privo di tale bagaglio «è paragonabile a un falegname affetto da cataratta che tenti di tagliare un bosco per fabbricare una sedia»7.
I cultori dell’anatomia sub specie physiologica e della chirurgia praticata con finalità sperimentale non godettero di buona stampa da parte dei custodi a oltranza della tradizione anatomo-chirurgica. Contro Vesalio s’era scatenato il finimondo. Il chirurgo parigino Jacques Dubois – Iacobus Sylvius – lo aveva letteralmente aggredito con un libell...