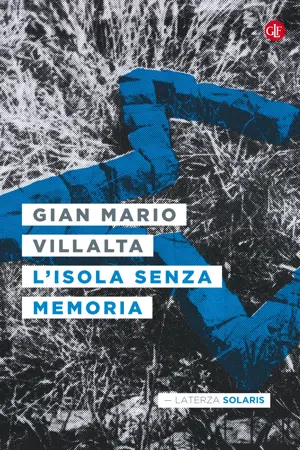Capitolo primo
Sono nato nel 1959 in un paesino del Friuli occidentale al confine con il Veneto, in una famiglia di agricoltori e artigiani. Erano stati emigranti nella Francia meridionale e in seguito in Corsica (dove è nato mio padre nel 1934), dalla quale sono rientrati nel 1941.
Nel paese dove sono nato, nel 1959 si lavorava la terra con pochi attrezzi, i più fabbricati in casa, e dalla terra si produceva quasi tutto quello che era necessario alla sussistenza, tranne il caffè, il sale, il tabacco e poco altro; per trainare i carri, per l’aratura e per fare i solchi si usavano i buoi o le vacche. Gli unici che conoscevamo a possedere un’automobile, il medico e il proprietario di un’officina, abitavano in un paese vicino. La televisione si andava a vedere all’osteria, però c’erano due sale cinematografiche, una privata e una parrocchiale. Alcuni giovani, tra i quali mio padre, e pochissimi dei meno giovani, tra questi mio nonno, possedevano una motocicletta.
Per alcuni anni non si è prodotto un grammo di immondizia domestica.
Lo squilibrio tra le condizioni materiali di vita e la coscienza della diversa vastità del mondo, nonché della potenza della tecnologia, inquietava la vita dei giovani e dei meno giovani, per ragioni diverse e con esiti del tutto differenti, come si sarebbe cominciato a vedere di lì a pochi anni. Ma intanto, dal 1959, la sostituzione del vecchio mondo con il nuovo sarebbe proseguita lenta e faticosa per un intero decennio, per poi accelerare con violenza dalla fine degli anni Sessanta all’inizio dei Settanta.
Questi appunti autobiografici raccontano una storia collettiva che potrei ricostruire con maggiori dettagli, segnalando i passaggi successivi, dove l’aspetto pratico materiale dei fatti e il loro significato per la mentalità e le conseguenze nei rapporti umani è per me difficile da distinguere. Anche la divisione tra eventi privati e sociali è difficoltosa: l’acquisto del trattore, del televisore, della lavatrice e la breve vacanza al mare sono parte della vita privata famigliare che diventano segnali collettivi; la costruzione del nuovo campo di calcio, il negozio della parrucchiera (la prima donna che, in paese, avvia un’attività propria, e perciò circonfusa di un alone di immoralità), l’asfalto sulle strade vecchie, la nuova provinciale che taglia in due il paese, se pure sono eventi esterni alla famiglia, riguardano me come ognuno degli abitanti. Poi, dopo i conflitti degli anni Settanta, in famiglia e fuori, diventiamo più uguali a tutti gli altri italiani. Il primo segnale, orgoglio di alcuni, ridicolo per altri, è che ci sono dei genitori che parlano ai figli in italiano.
Tutto questo avveniva sotto i miei occhi, era ciò che vivevo giorno per giorno non solo come fatti, ma come discorsi, credenze, aspirazioni, paure.
E poi c’era il fiume, c’era acqua ovunque, fosse, canali, alberi e canne. Mattine luminose, limpide come cristallo, e giornate di fine autunno quando non arrivava mai la luce. Infiorescenze che stordivano a primavera. Giornate di luglio quando percorrere in bicicletta le strade di polvere nella canicola deserta del dopopranzo significava trasformare una passeggiata di pochi chilometri in un viaggio interiore.
Per molto tempo, molto più tardi, ho pensato a quell’origine come il mio unico possesso, la mia riserva di salvezza. Avevo potuto ignorare che lì vicino si addestravano per uccidere, che poco più lontano imprigionavano, che dovunque nel mondo continuavano a sparare e torturare, che la paura respirata con l’infanzia era ben motivata da quanto stava succedendo ovunque, troppo vicino al posto dove, al momento, sembrava quasi pace una guerra diversa, quella del “progresso”.
Infatti, negli stessi anni, c’era quello che non vedevo. La guerra conclusa nel ’45, con le conseguenze dell’occupazione tedesca, la presenza dei fascisti di Salò e dei partigiani delle diverse fazioni. Era finita, certo. Ma per molti dei miei familiari e dei miei compaesani era ancora una realtà così vicina da incidere sulla vita quotidiana. Loro sapevano.
Un’altra cosa che non vedevo era la vicina realtà del confine orientale. Le parole “istriano”, “dalmata”, “slavo” (o anche peggio: s’ciavo) per me, nella sostanza, non volevano dire niente di diverso da “napoletano” o “milanese”. Eppure loro sapevano, o credevano di sapere.
E poi non vedevo – non vedevo per quello che significavano, perché semplicemente c’erano – le processioni dei convogli militari, i tuoni delle esercitazioni, le migliaia di soldati concentrati nelle caserme quasi in ogni paese.
Così come non vedevo davvero gli americani della base Nato di Aviano, così numerosi e ben stipendiati da trasformare l’area di tre comuni in una Little America, con i bowling, i drive in, le steak house – anche loro, per me, c’erano e basta.
Quando si è bambini, il mondo che ci riceve pare essere stato così da sempre. Appare come il nostro mondo, senz’altro, e le novità che vi si presentano come le prime novità da sempre. Anche quando ci raccontano il passato, per molto tempo lo collochiamo nel presente come una sua parte dimenticata e incongrua.
Per un certo periodo una giovane donna istriana aveva abitato in casa di un mio zio, che era rimasto vedovo da qualche anno. Quando si parlava di lei c’erano sempre dei sottintesi, che capivo solo in parte.
E non erano gli unici discorsi misteriosi. Anche su qualcuno che era stato partigiano o fascista sentivo delle frasi, dei commenti che non comprendevo.
In casa non mancavano le tensioni e la violenza. Abitavamo insieme con i genitori di mio padre e un cugino di qualche anno più grande di me, che una mia zia aveva lasciato lì “per un po’” e poi non era più venuta a riprendere: allora i bambini venivano addestrati all’obbedienza con ogni mezzo e in casa il conflitto per stabilire chi comandava era sempre aperto. Nonostante questa situazione, venivo preservato dagli odi esterni.
Non credo che ciò fosse dovuto a un rispetto speciale per la mia persona, ma all’abitudine al silenzio e alla reticenza. Rientrati dall’emigrazione con qualche denaro, i miei parenti erano rimasti degli estranei per il paese negli anni difficili dopo l’8 settembre del ’43. Avevano vissuto come prima, da emigranti, anche se adesso stavano di nuovo in patria, che però non era più quella che avevano lasciato.
Una condizione, la mia, che produceva qualcosa di buono e di meno buono. Il buono era che sono cresciuto completamente intatto dalla maldicenza, dall’invidia, dalla cattiveria generate dalla solidarietà obbligata del paese. Mi insegnavano la generosità, con durezza, perché la generosità costa cara, ma convinti che fosse un bene irrinunciabile. E questo era il buono.
Meno buono era il fatto che troppo spesso i miei familiari cambiavano discorso quando mi avvicinavo.
Anche in piazza, o all’osteria, oppure dal droghiere, mio padre o mia madre si affrettavano a lanciare una piccola provocazione o anticipare i saluti. A volte mi umiliava il fatto che i “grandi” avessero accesso a una parte di mondo che mi era interdetta.
Ma i silenzi, i gesti, il passaggio brusco alla frase pronunciata in francese, l’accoglienza sempre cortese e il sollievo, quando l’ospite usciva, perché era andato tutto bene, costruivano una conoscenza, creavano un mondo altro, incomprensibile e deforme.
Dei campi di concentramento, delle foibe, di tutti gli orrori della guerra recente, di tutto ciò che la guerra aveva prodotto e che era ancora lì, io non sapevo. E non ho saputo nulla, credo, fino alla scuola media. Oggi sospetto un ex fascista ancora convinto nel mio maestro elementare – ma non voglio chiedere. A chi chiedere? A un archivio? Resta il fatto che le vicende apprese durante la scuola media, e la lettura di Calvino, di Primo Levi, arrivavano come da un altro mondo. Come da un altro mondo arrivava la lingua italiana e i paesaggi che l’accompagnavano, nei libri di scuola toscaneggianti, informati da una cultura ancorata ai residui della classicità e a un patriottismo di maniera.
Non ho mai sentito, credo, la parola “ebreo” per tutto il periodo dell’infanzia, e se l’ho sentita non l’ho identificata come “speciale”, mentre nella parola s’ciavo, con cui venivano appellati anche gli italiani provenienti dal confine orientale, ho percepito da sempre la sgradevole consonanza con la schiavitù.
Questi riferimenti personali mi sono necessari per segnalare quanto diverso sia il sapere dell’esperienza da quello proveniente dall’informazione. Per molto tempo non ho conosciuto nessuno che avesse nel vissuto proprio o famigliare il racconto della persecuzione ebraica. E quando l’ho conosciuto, e saputo più a fondo, è stato dopo che quella vicenda era diventata la mia “piccola ossessione”, cresciuta dentro di me attraverso la letteratura.
Forse per questo l’incontro con Ligio Zanini e l’apprendere per la prima volta dalla voce di un testimone la realtà – se pure non intera – di Goli Otok, ha avuto un effetto così invadente.
Viene in evidenza, da queste annotazioni, anche qualcosa di diverso: quando veniamo al mondo, privi di un “prima”, mentre formiamo la nostra incerta identità di bambini, siamo immersi nella memoria di altri, i genitori, i parenti, i vicini, le altre persone che formano la comunità in cui viviamo. Ci sono i fiumi, i campi, le strade, che erano lì da prima di loro, e poi ci sono i monumenti, le chiese, le dimore antiche. Ci sono oggetti, e anche questi parlano, come l’elmetto tedesco che mia madre usava come vaso da fiori, o l’arazzo con l’immagine della sfinge appeso in camera dei nonni, trofeo della guerra africana. Ma tutto questo è ben poco al confronto di quanto grande è la memoria di altri che accompagna il nostro primo orientarci nel mondo. Non mi riferisco solo alla memoria consapevole, quella che ci viene trasmessa con intenzione, ma a quella più vasta e involontaria che passa con i gesti e le parole, con il cibo quotidiano, con le paure e le speranze che portano in sé un passato che non è stato il nostro. E con i silenzi.
Siamo un corpo e abbiamo un corpo. Allo stesso modo si può dire che abbiamo memoria e siamo memoria?
Ecco allora che, mentre crescevo, avevo una memoria, con la quale riconoscevo me stesso, ma ero anche memoria di qualcosa che non potevo riconoscere, che agiva, però, in me, e formava desideri e paure, un sentire e un volere.
La certezza di essere un corpo, che mi collocava sempre di nuovo nell’apertura del presente, era già allora segnata da qualcosa che non conoscevo e che inquietava la mia coscienza di avere un corpo.
Ero già diviso, allora, e forse cercavo tra il mio essere e il mio riconoscermi una dimensione diversa, dove il riconoscermi avrebbe dovuto dare ragione anche della memoria non mia?
Eppure io invidiavo tutte le persone più grandi di me abbastanza da poter affermare con sicurezza una loro certa opinione, una visione sulle cose che fondava giudizi e decisioni.
A mia volta imitavo, per gioco, le formule ...