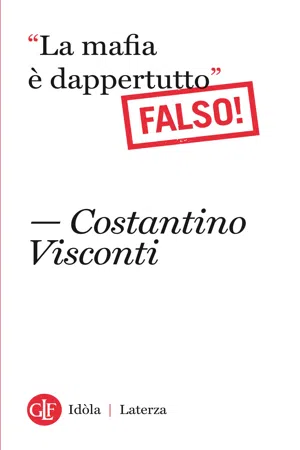
- 152 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Esasperati dalla corruzione sistemica e diffusa, frustrati dal clientelismo, avviliti dalle cronache giudiziarie, rischiamo di convincerci che l'illegalità in Italia sia invincibile e che la criminalità organizzata abbia sempre la meglio, da Milano a Palermo passando per Mafia Capitale. C'è una buona notizia: non è così.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a "La mafia è dappertutto" di Costantino Visconti in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Economics e Economic Policy. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
EconomicsCategoria
Economic Policy1.
Il Nord è in mano
alla ’ndrangheta
In un recente libretto dal titolo molto impegnativo, Manifesto dell’Antimafia, Nando dalla Chiesa rivela di aver via via maturato la convinzione che «la magistratura nel suo insieme costituisca spesso una remora allo sviluppo di una lotta coerente alla mafia». Quale sarebbe la colpa dei magistrati? Ebbene, secondo lo storico esponente del movimento antimafia e presidente di Libera, «il magistrato medio, al Nord, sembra ragionare più o meno come il politico medio (...). Pensa che la mafia nella sua regione non esista sul serio (...). Di più e più grave: mostra spesso di non conoscere nemmeno la legge istitutiva dell’associazione mafiosa, il famoso 416 bis, che costò la vita al suo ideatore, Pio La Torre».
Parole forti, le sue. Che il sociologo, a lungo prestato anche alla politica, giustifica aggiungendo anche che secondo lui «da qualche anno» importanti indagini e processi «vengono azzerati o misconosciuti da una pletora sempre più numerosa di magistrati di ogni ordine e funzione (...) processi disfatti, negazione dell’esistenza dell’associazione mafiosa su questo o quel territorio, festeggiamenti dei clan assolti come nella migliore tradizione siciliana degli anni Settanta, sgomento e senso di abbandono nei cittadini e nell’opinione pubblica».
Ma cosa è successo nei tribunali del Nord per spingere un uomo solitamente solidale con la magistratura a descrivere scenari così sprezzanti per giudici e pubblici ministeri? Per chi ha seguito le cronache giudiziarie degli ultimi anni, oltretutto, le parole di dalla Chiesa fanno a pugni con l’idea che un po’ tutti ci siamo fatti leggendo i giornali, ossia di una nuova stagione di forte repressione delle mafie dispiegatasi proprio al di fuori dei tradizionali confini meridionali, in Piemonte, in Liguria, in Lombardia e in Emilia Romagna. Giusto nel 2015, tanto per essere più precisi, sono arrivati a sentenza definitiva importanti processi contro le «locali» di ’ndrangheta insediate al Nord: le inchieste «Albachiara» e «Minotauro» a Torino, «Infinito» e «Crimine» a Milano, con condanne a carico di centinaia di persone a titolo di associazione mafiosa. Per non parlare del vero e proprio maxiprocesso che si è aperto a Bologna a seguito dell’indagine «Aemilia» e che ha portato alla sbarra circa duecento indiziati mafiosi operanti a Reggio Emilia e dintorni.
Tutto si può dire, insomma, salvo che la magistratura non abbia fatto la sua parte nel disvelare la preoccupante espansione di formazioni ’ndranghetiste nelle regioni del Nord, servendosi dello strumento principale a sua disposizione, cioè di quel reato di associazione mafiosa che invece dalla Chiesa ritiene poco conosciuto e/o apprezzato dai giudici. Non sono mancate, inoltre, sentenze di condanna anche per insospettabili «colletti bianchi»: imprenditori, politici, professionisti, pubblici funzionari, perfino magistrati, accusati di aver favorito in svariati modi le attività criminali degli ’ndranghetisti. A ciò si aggiunga un altro dato molto significativo, e cioè l’impennata registrata nell’ultimo quinquennio, soprattutto in Lombardia e in Piemonte, di sequestri e confische di beni ritenuti di provenienza illecita in possesso dei mafiosi.
Vero è, d’altra parte, che l’applicazione dell’arsenale giuridico-penale antimafioso ai fenomeni nordisti di addensamento ’ndranghetista ha sollevato in giurisprudenza non pochi problemi di tipo tecnico-interpretativo. Talora vi sono stati giudici che hanno ritenuto non applicabile il reato di associazione mafiosa previsto dall’art. 416 bis in alcune vicende processuali. Ad esempio, due monumentali sentenze emesse a Torino e a Genova hanno assolto gruppi di calabresi, tra loro moltissimi residenti da tempo in quelle città, dall’accusa di aver agito «mafiosamente», e cioè di aver dato vita a un sodalizio con le caratteristiche descritte dall’art. 416 bis. In altri casi è stata la Cassazione ad annullare sentenze, stavolta di condanna, pronunziate nelle medesime città, ritenendo giuridicamente non corretta l’interpretazione del reato di associazione mafiosa.
All’interno della stessa Cassazione, inoltre, è divampato un contrasto interpretativo proprio sull’applicabilità dell’art. 416 bis in «regioni tradizionalmente refrattarie» al fenomeno mafioso, contrasto che spesso ha preso le mosse dal controverso concetto di «mafia silente» che già aveva impegnato i giudici milanesi nel decennio precedente. Ci torneremo.
Forse dalla Chiesa allude a questi contrasti quando, piuttosto che riconoscere il lavoro fin qui compiuto dai magistrati, ne mette in discussione il valore, gli esiti e addirittura la professionalità? Ebbene, se così fosse credo che ancora una volta emerga un problema che ciclicamente affligge il movimentismo antimafia, facendogli prendere non di rado vere e proprie cantonate: l’ignoranza. Sì, proprio così: ignoranza. Non generalizzata ovviamente, ma specifica: cioè ignoranza giuridica, penalistica in particolare. Quell’ignoranza che impedisce a molti, troppi personaggi che popolano l’arena pubblica sul fronte antimafioso, di distinguere ad esempio il piano delle inchieste giornalistiche e delle analisi sociologiche da quello della giustizia penale.
Si può ben sostenere dal punto di vista socio-criminologico, infatti, che il fenomeno dell’espansione delle mafie tradizionali nelle regioni del Nord sia stato a lungo sottovalutato e che ciò abbia consentito, soprattutto alla ’ndrangheta, di passare dall’infiltrazione al ben più grave e profondo radicamento in numerose comunità locali. Ma se anche fosse azzeccata una simile chiave ricostruttiva, non per questo la magistratura sarebbe obbligata a sfornare a raffica sentenze di condanna per associazione mafiosa. Né che ogni calabrese preso con le mani nel sacco mentre delinque o si riunisce in modo sospetto insieme ad altri suoi compaesani in terra padana debba per ciò solo essere condannato per mafia.
La verità è che ravvisare in un caso concreto tutti gli elementi di fatto che legittimano l’applicazione del reato di associazione mafiosa è operazione piuttosto complicata, a dispetto delle banalizzazioni giornalistiche, politiche o sociologico-movimentiste. Del resto, per rendersene conto, anche da profani, basta dare una scorsa al testo della norma e in particolare al terzo comma, che ne costituisce il «genoma»:
L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Come qualcuno ha detto, più che una fattispecie penale sembra una descrizione uscita dalla penna di un creativo. Ecco perché si sono versati fiumi d’inchiostro per interpretarla correttamente, interi libri per tratteggiarne i significati in modo meno sfuggente possibile. Ad esempio, Giuliano Turone, un magistrato colto ora in pensione, dal 1982 ad oggi avrà pubblicato almeno quattro edizioni di un manuale dedicato al reato di associazione mafiosa: sempre più voluminoso, per la necessità di dar conto della mole di problemi sollevati dall’interpretazione di questo testo normativo.
Si badi, non si tratta di scrupoli ipergarantistici o di cavilli da azzeccagarbugli, bensì della normalissima, ordinaria grammatica del diritto. Vediamo perché.
Già ai primi vagiti, più di trent’anni addietro, il reato di associazione mafiosa dette vita a plurime interpretazioni che scaturivano da un testo normativo oggettivamente molto articolato, pieno zeppo di parole dai confini semantici incerti. Ma qual era – ed è rimasto nel tempo – il punto nodale? Sicuramente la definizione del cosiddetto «metodo mafioso» che troviamo scolpito nel terzo comma dell’art. 416 bis sopra citato: un gruppo criminale può qualificarsi «di tipo mafioso» in senso penalisticamente rilevante soltanto quando coloro che ne fanno parte «si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva». L’interpretazione giurisprudenziale di tale non felicissimo costrutto linguistico che si è consolidata nel tempo è, in estrema sintesi, la seguente: un’associazione è di tipo mafioso quando si riesce a provare che
a) il sodalizio ha acquisito un’effettiva, attuale (e non solo potenziale) forza di intimidazione tale da
b) determinare nell’ambiente in cui opera assoggettamento e omertà.
Molte sentenze hanno inoltre precisato un risvolto necessario in campo processuale di tale impostazione: occorre, infatti, dimostrare «un’esteriorizzazione» del predetto «metodo mafioso». Non basta, in altre parole, che un gruppo di temibili delinquenti costituisca un’associazione con il programma di commettere ogni sorta di reato e di sfruttare a tal fine la propria fama criminale (in questo caso si tratterà tutt’al più di una comune associazione per delinquere punita molto meno gravemente dall’art. 416). Per applicare il 416 bis è necessario, infatti, che vi sia il riscontro di un – appunto – «avvalersi» effettivo della forza di intimidazione di cui dispone il sodalizio e del corrispondente stato di diffuso assoggettamento e omertà generatosi nel contesto in cui opera.
Ebbene, questo modo di leggere la norma e di applicarla nei processi – consolidatosi, lo ribadiamo, in decenni di sentenze – è stato ritenuto in alcuni recenti processi un impedimento per reprimere efficacemente le cellule ’ndranghetiste insediate in regioni settentrionali, soprattutto in quei casi in cui i pubblici ministeri non disponevano della prova di una effettiva «esteriorizzazione» del metodo mafioso nell’ambiente circostante. Da questa esigenza nasce il tentativo giudiziario, purtroppo in parte riuscito, di cambiare le carte in tavola, con una serie di accorgimenti semantici talora sfocianti in veri e propri giochi linguistici.
In proposito si rivelano illuminanti gli scambi di battute tra giudici di Cassazione e giudice di merito in una vicenda ligure. I primi raccomandano al tribunale di accontentarsi di accertare una capacità intimidatoria «solo potenziale», perché diversamente diverrebbe impossibile «configurare l’esistenza di associazioni mafiose in regioni refrattarie, per una serie di ragioni storiche e culturali, a subire metodi mafiosi».
Il giudice di merito, invece, risponde per le rime, accusando la Cassazione di voler «riconoscere a tutti i costi l’esistenza di una associazione mafiosa, sul modello di quelle meridionali, là dove pure non si riproducono le condizioni di intimidazione e di assoggettamento e omertà tipiche di quelle regioni». D’altro canto, lo stesso giudice genovese, se, per un verso, accerta nel processo che gli imputati «si incontrano e si riuniscono nel rispetto delle tradizioni ’ndranghetiste, partecipano al conferimento di cariche proprio del sodalizio e ne seguono i rituali»; per altro verso non rinviene prove sufficienti in virtù delle quali poter affermare che «costoro abbiano riprodotto in Liguria le caratteristiche operative né, tanto meno, che agiscano nei rapporti con l’ambiente esterno come appartenenti a un’associazione mafiosa».
Un’analoga contrapposizione la troviamo in vicende giudiziarie torinesi. Il tribunale assolve un gruppo di calabresi accusati di associazione mafiosa, ritenendo che – pur essendo emerso chiaramente che gli imputati avevano dato vita a una «locale di ’ndrangheta» –, non v’era prova però di un «concreto inserimento di tale struttura nella realtà del contesto territoriale del basso Piemonte» e quindi di una «esteriorizzazione» del «metodo mafioso», con conseguente assoggettamento e omertà. Fulminante la replica dei giudici di appello, che invece condannano gli stessi imputati «al fine di scongiurare il paradosso di pervenire a una precoce – quanto inutile – diagnosi della patologia cancerosa (costituzione ed esistenza dell’associazione di stampo mafioso), senza poter effettuare alcun valido intervento terapeutico, prima della proliferazione delle metastasi». D’altra parte, aggiungono i giudici riprendendo una metafora difensiva, è ben vero che un sodalizio che non ha «esteriorizzato» il «metodo mafioso» assomiglia a un vulcano privo di attività eruttiva e quindi non minaccioso; e però «molti sono i vulcani attivi in quiescenza (ad esempio il Vesuvio) e, pur apparendo innocui, ad avviso degli esperti nessuno di essi può essere sottovalutato in quanto destinato a tornare certamente in attività, in un futuro più o meno prossimo».
Ma è nelle algide stanze romane della Cassazione che ritroviamo il confronto più ruvido sulla rilevanza giuridico-penale della cosiddetta «mafia silente». Un’espressione, questa, impiegata in alcuni provvedimenti giudiziari proprio per motivare la qualificazione come mafiosi di sodali calabresi insediati in regioni del Nord, per i quali mancava la prova di essersi avvalsi effettivamente della «forza di intimidazione» e dunque di aver determinato «assoggettamento e omertà» nell’ambiente circostante. Più volte la Cassazione, censurando tali decisioni, ha ritenuto «mafia silente» un’espressione meramente «sociologica», fuorviante dal punto di vista giuridico e a contenuto «ossimorico» sul piano logico. Come si fa, dicono infatti i giudici di legittimità, a definire «silente» un’associazione che, al contrario, la legge punisce più severamente proprio a causa del modo con cui si manifesta all’esterno, seminando paura, incutendo soggezione e impiegando violenza se occorre? Poco male, replicano altri colleghi della Suprema Corte: tutto sommato, quei calabresi meritano la condanna per partecipazione mafiosa in quanto, seppure rimasti con le mani in mano, «erano, di certo, ben consapevoli di non aderire ad un circolo ricreativo o ad un’associazione no-profit».
Alla fine i giudici di Cassazione hanno pure provato a mettere una pezza al dissidio, suggerendo di ridefinire la «nozione di mafia silente» in modo da ricondurla esclusivamente a quei casi in cui i criminali si manifestano, eccome, con il loro «metodo mafioso», ma «senza ricorrere a forme eclatanti (come omicidi o stragi)» e «avvalendosi pur sempre di quella forma di intimidazione che deriva dal non detto, dall’accennato, dal sussurrato, dall’evocazione di una potenza criminale cui si ritenga vano resistere».
Tuttavia, una ferita al sacro principio di legalità penale è stata comunque inferta. D’ora in poi, infatti, la locuzione «si avvalgono», impiegata nell’art. 416 bis, rischia di potersi riferire non solo a qualcosa che è già accaduto (e cioè che gli imputati hanno davvero esercitato una «forza di intimidazione» nei confronti di qualcuno rimasto «assoggettato» e «omertoso»), come richiederebbe la lingua italiana, ma anche a qualcosa che si presume possa accadere (e che però non si ha la prova che sia accaduto).
Ora, se abbandoniamo per il momento il dibattito interno alla magistratura, possiamo intravedere sullo sfondo un nodo irrisolto dei nostri tempi, annidato nel cuore dei rapporti tra giustizia penale e «pubblico».
«Mafia silente», a ben vedere, è espressione linguisticamente accattivante, disegna immagini in grado di catturare pezzi di realtà che magari sfuggirebbero alla sintassi ordinaria. Chiamare all’appello una «mafia silente» per punirla in quanto tale ci spinge a esplorare gli angoli più nascosti della nostra voglia di farla finita con questo tipo di criminali. Li vogliamo tutti in galera, questi mafiosi, anche quando non sparano e stanno acquattati senza neanche parlare con la gente. Se, come amano ripetere alcuni, «il Nord è in mano alla ’ndrangheta», perché mai non dovremmo chiudere un occhio per qualche forzatura giuridica? Peraltro suggestivamente argomentata e tutto sommato indolore (salvo per i condannati, che pur sempre calabresi e mafiosi d’indole sono, però)?
A fronte di un simile ragionare, ogni altra considerazione diventa secondaria, il diritto stesso diventa secondario.
Forse non tutti sanno, ad esempio, che per il solo fatto di «far parte» di un’associazione mafiosa in quanto «affiliato» a un sodalizio mediante il rito del giuramento, senza magari aver provato a torcere un capello ad alcuno, si rischia una pena che può arrivare fino a vent’anni di carcere, «duro» per giunta. Raccomandare in tal caso (giuris)prudenza e rispetto di tutte le garanzie richieste, è ...
Indice dei contenuti
- Premessa. Anatomia giuridica di un marchio di successo
- 1. Il Nord è in mano alla ’ndrangheta
- 2. Mafia Capitale?
- 3. Ormai anche gli imprenditori fanno affari con i mafiosi
- 4. I politici sono amici dei mafiosi
- 5. Prima le coppole, ora la «borghesia mafiosa»
- 6. Il concorso esterno come metafora
- Post scriptum
- Bibliografia essenziale