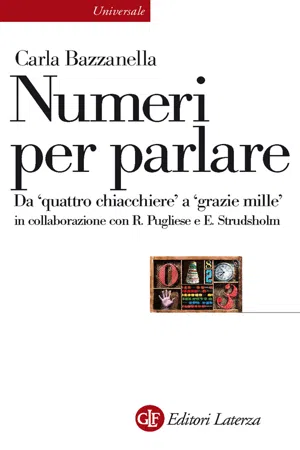
eBook - ePub
Numeri per parlare
Da 'quattro chiacchiere' a 'grazie mille'
- 176 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Numeri per parlare
Da 'quattro chiacchiere' a 'grazie mille'
Informazioni su questo libro
Numeri. Possono essere percentuali, frazioni, equazioni dinanzi alle quali scatta una specie di rispetto, di quasi reverenza, ma possono anche entrare nel narrare quotidiano.
Viviamo in un mondo di numeri, che usiamo in modi e con finalità diverse, parliamo con i numeri e dei numeri. Il loro gioco con le parole crea curiosità, paradossi, espressioni che, anche senza accorgercene, sono il nostro pane quotidiano.
Da zero a un miliardo, il lettore scoprirà, nelle diverse lingue, divertendosi, gli usi dei numerali nelle conversazioni tra amici, nei proverbi, nei giornali, in letteratura e nelle varie forme discorsive delle nuove tecnologie.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Numeri per parlare di Carla Bazzanella,Rosa Pugliese,Erling Strudsholm in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Scienze sociali e Cultura popolare. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
Scienze socialiCategoria
Cultura popolare1. Numeri per contare e per parlare
di Carla Bazzanella
1.1. Contare e raccontare
Raccontare o narrare può essere considerato il centro della comunicazione umana, pur nella molteplicità delle sue forme e funzioni. Quello che caratterizza il raccontare, infatti, è la sostanziale dialogicità, il piacere di fare due chiacchiere; quindi il coinvolgimento, anche emotivo, insieme alla possibilità, proprio tramite il racconto, di dare un senso a quello che è successo, a condividerlo con gli altri, a stringere e mantenere rapporti sociali.
Nei secoli scorsi, in campagna, raccontare in cucina, vicino al fuoco, non era solo stare insieme, ma era il modo di trasmettere conoscenza, cultura in senso ampio, e anche capacità di calcolare quello che riguardava la vita quotidiana (il far di conto).
Contare e raccontare, il bellissimo titolo del libro di Bernardini e De Mauro (2003), condensa proprio le due facce delle capacità simboliche umane che contraddistinguono il genere umano dagli animali e coinvolgono livelli e modi diversi di astrazione e di creatività: per le capacità scientifiche, il contare emblematicamente racchiude gli aspetti del pensiero e della cultura scientifica; per le umanistiche, il raccontare indica una parte per il tutto, ma una parte molto significativa. Per dirla con le parole di Heinrich von Kleist: «Io so calcolare un differenziale e fare una poesia: non sono questi i due estremi della capacità umana?» (lettera a Ernst von Pfuel, 7 gennaio 1805).
Non a caso in molte lingue si usa la stessa parola per calcolare e per parlare, con un intreccio stretto tra pensiero scientifico e linguaggio, in generale tra parole e numeri: «[...] a cominciare dalla solenne e veneranda parola greca lògos giù giù fino al napoletano cunto e contare o al siciliano cuntu e cuntari o [...] al piemontese conté» (Bernardini, De Mauro 2003, 80).
E anche i numeri ‘entrano’ nel narrare quotidiano, nell’interagire con le parole dandosi ad esempio un numero di cellulare per ritrovarsi o chiedendo di aspettare «due minuti», ben sapendo entrambi che potranno essere parecchi di più...
1.2. Il senso dei numeri
Io credo [...] che anche i numeri naturali siano opera degli uomini,
il prodotto del linguaggio e del pensiero umano.
Popper (1972, 216).
L’anno terminava quando la luna aveva compiuto il suo
[decimo giro.
Questo numero allora fu in grande onore:
o perché altrettante sono le dita con le quali contiamo,
o perché la donna partorisce al decimo mese,
o perché nel fare un conteggio crescente si giunge al dieci,
da cui prendono origine nuove serie di numeri.
Ovidio, I Fasti 3, 121-126 (traduzione di Luca Canali).
Il «senso dei numeri» è quella forma elementare di intuizione numerica, presente già nei bambini e in varie specie animali, di cui parlava Tobias Dantzig nel 1954:
L’uomo, anche negli stadi più primitivi della sua evoluzione, possiede una facoltà che, in mancanza di un termine migliore, chiameremo il senso del numero. Questa facoltà gli permette di accorgersi che qualcosa è cambiato in una piccola collezione di oggetti se, a sua insaputa, viene aggiunto o tolto uno di questi.
Abbiamo ereditato il senso dei numeri dalla nostra storia evolutiva e si può definirlo come il germe che favorisce l’emergere delle successive abilità matematiche.
La nozione di evoluzione, in cui giocano fattori biologici e culturali, è essenziale anche per lo sviluppo dei sistemi numerici: «Persino l’impiego dei numeri arabi, così familiare da far pensare che sia sempre esistito, è in realtà il risultato di un lento processo di invenzione» (Dehaene 1997, 4).
Perché, ad esempio, il tipo più diffuso di sistema numerico è a base 10? Perché dieci sono le dita delle mani, lo strumento più semplice, a disposizione di tutti, per memorizzare piccole quantità e compiere semplici operazioni, tanto che in genere si insegna a contare ai bambini proprio usando le mani. Anche se il contare sulle dita è ormai «arte perduta» (Dantzig 1954), nelle società attuali che ricorrono piuttosto alla calcolatrice, le dieci dita della specie umana hanno lasciato un’orma permanente: ad esempio, in alcune lingue i numerali fino a quattro sono uguali ai nomi delle quattro dita. In tutte le lingue indoeuropee, ma anche nel semitico, i numerali fino a dieci sono indipendenti, così come cento e mille; per gli altri, si utilizza un principio di combinazione su base 10.
Altre basi (alcune correlate con quella decimale) sono diffuse nei sistemi di numerazione. Il sistema numerico binario, importante in matematica e usato in informatica, è frequente anche in situazioni quotidiane: contare per due così come dividere e moltiplicare per due sono considerati mezzi fondamentali per manipolare quantità (cfr. Jansen, Pollmann 2001).
Ricordiamo la base 5, suggerita dai filologi per l’indoeuropeo in relazione a varie tracce, e utilizzata nella lingua Api, delle Nuove Ebridi, in cui cinque si dice luna, corrispondente a ‘mano’, e i numeri successivi, da sei a nove, sono: nuovo uno/due/tre/quattro fino a dieci, lualuna = due mani (2×5).
Il sistema a base 12, molto significativo dal punto di vista matematico perché divisibile per 2, 3, 4 e 6, e quindi teoricamente preferibile alla base 10 (numero con soli due divisori, 2 e 5), era usato dai sumeri e dagli assiro-babilonesi per misurare lunghezze, superfici, volumi, dai romani come unità di peso e come moneta (l’asse), dal sistema monetario del Regno Unito fino al passaggio al sistema decimale nel 1971, relativamente allo scellino che valeva 12 pence. Questo sistema è tuttora presente, ad esempio in alcune zone d’Italia, come unità di misura tradizionale (oncia, soldo, pollice, piede, braccio) e ha una persistenza significativa nella frequenza del termine dozzina in varie lingue (cfr. infra, 2.3.2; 4.5).
Per quanto riguarda il sistema vigesimale (che può rimandare al conteggio anche delle dita dei piedi), varie popolazioni, dai maya alle popolazioni celtiche, lo usarono nel passato e tuttora ne rimangono dei residui:
[...] al Sud possiamo ancora oggi imbatterci, a livello popolare, in chi fa ricorso al sistema vigesimale della numerazione. Per indicare l’età, o per contare le uova, la frutta o altro, in Sicilia dicono ancora du vintini, du vintini e ddeci, idem in Lucania e in Salento; in Abruzzo mezza ventina sta per ‘una decina’, una ventina e mezzo per ‘una trentina’, di anni o altro. Tutto ciò è dovuto ai normanni che portarono con sé una tradizione linguistica francese: al loro influsso si deve, se non l’origine, certo la rinnovata circolazione di quest’uso. Se in francese ottanta è quatrevingt, ciò dipende dal fatto che le popolazioni celtiche che abitavano la Francia prima della conquista normanna usavano contare non a decine ma a ventine (Beccaria 2008, 24).
In altre culture si usano anche, per conteggi gestuali, differenti parti del corpo (palmo della mano, spalle, gomiti, oltre che ginocchia ecc.; cfr. Dixon 1989, 108; Hurford 1987, 81), ordinate in una successione convenzionale: ad esempio dal pollice di una mano al mignolo dell’altra. In altre ancora, come alcune australiane, africane e dell’America del Sud, ci si limita a distinguere, come fanno inizialmente i bambini, tra uno, due, tre e molti.
Dehaene nel 1997 ha proposto una distinzione fondamentale tra due sistemi cognitivi relativi al senso dei numeri:
– uno non-simbolico, inerentemente approssimativo, che si basa sulla valutazione di quantità e può includere operazioni elementari di addizione e sottrazione;
– uno simbolico, tipico degli esseri umani adulti, che si basa sul contare, cioè su un sistema numerico e su tutte le operazioni aritmetiche.
La distinzione generale tra i due tipi di uso, simbolico e non-simbolico, dei numeri si correla quindi con la doppia interpretazione, approssimata e precisa. L’uso non-simbolico rimanda alla nozione tecnica di numerosità1, cioè la semplice valutazione percettiva di differenti insiemi di oggetti e la capacità di confrontarla, impressionisticamente, con altre, maggiori o minori; è quindi corrispondente alla cosiddetta interpretazione approssimata (cfr. Krifka 2007; Bazzanella i.c.s).
Questa capacità è presente nei bambini piccoli (che sanno scegliere senza esitazioni tra un contenitore con un maggior numero di oggetti per loro interessanti rispetto a uno che ne contiene meno) e anche negli animali: piccioni, corvi, primati non umani, in vari esperimenti, si sono dimostrati in grado di discriminare quantità diverse in oggetti diversi e di selezionare quello più numeroso. Ma sia bambini piccoli che animali limitano i loro «miracoli matematici» (Dantzig 1954) all’interno di contesti fortemente circoscritti, sia rispetto alla quantità ridotta (fondamentalmente 1, 2, 3; cfr. ad esempio Pannain 1997), sia rispetto a una stima continua e non discreta, cioè senza distinguere tra 49 e 50, o tra 9-10-11, restando all’interno di una matematica ‘approssimata’ e non simbolica.
Così non stupisce che due gemelle che stavano cantando alla zia una canzoncina d’auguri di compleanno appresa alla scuola materna, in cui occorreva inserire l’età, si siano interrotte alla risposta, «48», della zia, una chiedendo conferma ripetendo la cifra: «48?» e l’altra chiedendo esplicitamente specificazioni su questa cifra che non riusciva bene ad afferrare: «Ma quanti sono 48, zia?».
Naturalmente, crescendo, i bambini sviluppano anche l’uso simbolico dei numeri, nelle sue varie forme e in relazione ad altre capacità cognitive, mentre i primati non umani – che pure hanno dimostrato, in situazioni sperimentali, alcune capacità, ridotte, di uso simbolico – rimangono sostanzialmente limitati all’interpretazione approssimata. È interessante notare che i primati non umani, in situazioni sperimentali e di addestramento, riescono a compiere elementari operazioni di calcolo; ad esempio, la scimpanzé Sheba associava non solo vari oggetti (arance, cucchiai, pile ecc.) a dischetti metallici composti da un diverso num...
Indice dei contenuti
- Premessa
- 1. Numeri per contare e per parlare
- 2. Approssimare con i numeri nelle lingue
- 3. Pragmatica dei numerali
- 4. Quando è difficile tradurre i numerali: il caso del danese
- Due parole per concludere
- Bibliografia
- Fonti
- Gli autori