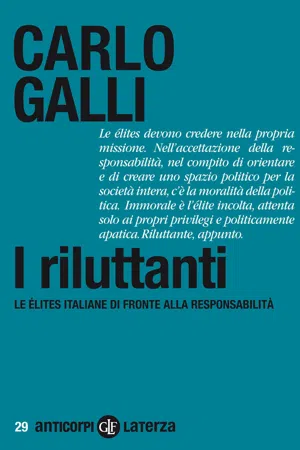capitolo terzo.
Venture e sventure delle élites italiane
Il pensiero di Gramsci e quello dell’elitismo democratico sono due diverse interpretazioni del ruolo delle élites: dialettico ed egemonico il primo, pluralistico e concorrenziale il secondo. In entrambi i casi (che quindi non si equivalgono per nulla) il giudizio negativo dei letterati sulle élites politiche italiane è confermato, ma anche arricchito da analisi che si avvalgono di punti di vista più complessi, benché non sorretti dall’immaginazione e dall’espressività della letteratura. Grazie a queste acquisizioni il discorso sulle élites perde la propria letteraria curvatura morale e trova tre nuovi punti fondamentali: la struttura pluralistica e conflittuale delle élites, la distinzione fra élites sociali ed élites politiche, e la consapevolezza che la storia d’Italia è segnata non solo da caratteristiche fisse, invarianti, delle élites, ma anche da mutevoli forme di rapporto fra le élites sociali e le élites politiche. Se si incrociano fra di loro queste acquisizioni le costanti delle élites italiane – il particolarismo, la riluttanza o l’incapacità davanti ai compiti direttivi ed egemonici, la cultura ineffettuale, l’apatia, l’apoliticismo, l’illegalismo – sono interpretabili in guise più complesse.
1. Lo schema diacronico
I primi decenni unitari dell’Ottocento sono in quest’ottica una fase in cui le élites sociali territoriali si sono trovate costrette – dall’iniziativa di un ristrettissimo gruppo di levatura nazionale, da cui ha preso impulso il Risorgimento – a essere élites politiche; e hanno conservato le mentalità e le prospettive ristrette della ‘roba’, trasformate dall’accelerazione dei tempi (dal progresso) in affarismo arrivista; alla classe politica eletta è stato lasciato il compito di una sintesi evidentemente impossibile, se non a livelli retorici. L’elemento della conflittualità fra le élites, d’altro canto, implica che non si debba restringere lo sguardo alle élites liberali (di Destra e di Sinistra), ma considerare anche le altre, per riconoscerne l’originaria esclusione dalla politica, e anche la marcia (più o meno faticosa) d’avvicinamento al potere: cioè le élites cattoliche (le gerarchie, ma anche tutto il mondo cattolico diffuso nella società) e le élites socialiste (il partito e i suoi gruppi dirigenti, e i livelli più consapevoli delle masse che esso organizza direttamente).
Ma l’invarianza caratteriale e strutturale dispiega presto anche una strategia consapevole, una prassi politica quasi paradossale. Quando il deficit d’egemonia si fa troppo grave, quando nuove élites si fanno minacciose, allora nelle élites borghesi si produce una vera e propria forzatura avventuristica, un’accelerazione febbrile attraverso la figura dell’Eroe, e la cultura che lo legittima. Il nazionalismo e l’eroismo sono il punto in cui la riluttanza pare rovesciarsi in iper-attivismo ultra-elitario; ma in realtà si conserva intatto, dietro lo schermo luminoso della Patria, l’angusto interesse di classe, e l’incapacità di adempiere i doveri di direzione politica del Paese in un contesto democratico. Non solo: il nazionalismo nella sua inadeguatezza politica reale (quanto più realistico era l’antieroico Giolitti del «parecchio»!) prepara un’altra e diversa manifestazione di riluttanza delle élites: una sorta di abdicazione politica (parzialmente) calcolata. Le élites liberali nella loro fase nazionalistica hanno condotto l’Italia a una guerra il cui esito benché vittorioso ha portato al collasso della loro stessa capacità politica; altro non è stato, infatti, il loro darsi in mano al fascismo, invano fronteggiato da Gobetti. Certo, il Duce non è solo l’Eroe; è anche molto più pratico e concreto, e molto più aperto alla dimensione di massa della politica; e proprio per questo il fascismo ha confermato i grandi interessi della nazione (dal punto di vista borghese) ma al prezzo di sottrarre alle élites tradizionali la diretta responsabilità della direzione della cosa pubblica, ovvero spoliticizzandole. Le élites tradizionali conservano i loro ruoli sociali di dominio – al più, devono cedere un po’ di posto alle masse piccolo-borghesi che il fascismo immette nella vita civile –, ma la direzione politica del Paese è diversa, non più liberale e costituzionale. Certo, non per questo più democratica: l’inclusione dei cattolici (iniziata da Giolitti e perfezionata da Mussolini) non esprime ancora il suo potenziale politico; l’esclusione delle sinistre permane, aggravata; l’inclusione delle masse è autoritaria.
Le nuove élites politiche fasciste, dopo avere guidato il Paese mescolando uso dell’eccezione (la lotta all’antifascismo) e sforzi di stabilizzazione non-liberale (lo Stato corporativo), si sono anch’esse dimostrate incapaci di conoscere e controllare le potenze reali del nuovo mondo, e con la loro cultura arretrata e retorica (con forti venature, autenticamente criminali, di anti-semitismo) hanno a loro volta nuovamente forzato la situazione politica verso una nuova guerra, che le ha travolte. Solo a catastrofe già consumata le élites tradizionali hanno tentato di salvare gli interessi essenziali del Regno e di riprendere un ruolo direttamente politico, trascinate da un vincolo esterno fortissimo: l’esposizione dell’Italia a una guerra devastante che ne minacciava l’esistenza sovrana. Sotto la spinta della necessità, nell’arco di tempo che va dal 25 luglio 1943 al 18 aprile 1948, si sono così consumate le decisioni fatali del nostro Paese; le vecchie élites (monarchia, esercito, burocrazia) hanno avuto un ultimo guizzo, per poi darsi alla fuga e abdicare, ma hanno così aperto una finestra di possibilità per il manifestarsi di energie politiche sopite o ignote, di soggetti politici in parte vecchi e in parte nuovi: imprenditori, élites borghesi, ma anche il mondo cattolico organizzato dalla Democrazia Cristiana e sostenuto dal Vaticano e dalle potenze occidentali, e il mondo socialista e comunista. Si sono così generate tre legittimità incrociate: quella anti-fascista della guerra civile da cui è nata la Costituzione democratica; quella anti-monarchica, da cui è nata la repubblica; quella anti-comunista, da cui è nata la costituzione materiale del Paese, che ha visto il Pci escluso dal potere politico nazionale eppure determinante in molti governi locali e nella tenuta complessiva del sistema democratico, di cui è stato socio fondatore a pieno titolo, azionista di robusta minoranza nell’equilibrio fra capitale e lavoro che ha caratterizzato la Prima repubblica (la versione italiana del compromesso socialdemocratico), nonché corresponsabile ufficioso del governo durante la fase dell’unità nazionale anti-terroristica.
Ora, sembra si possa notare un’analogia formale tra il lustro 1943-48 e il triennio 1859-61, almeno quanto a capacità morfogenetica, alla capacità, cioè, di dar vita a una forma politica attraverso decisioni, compromessi, gerarchie, egemonie e configurazioni di dominio poste in essere, in entrambi i casi, da élites – non caste, né conventicole ma uomini e partiti politici – certe di sé; quelle novecentesche, certamente, legittimate dal consenso popolare ma, come quelle ristrettissime risorgimentali, ugualmente conscie del proprio dovere di dare una direzione precisa alla cosa pubblica, di individuare orizzonti comuni. E si può notare anche che la gestione di questa nuova struttura politica democratica, ben più solida e progressiva sotto ogni profilo dell’Italietta dei notabili, si è scontrata con resistenze, vischiosità, arretratezze nei territori, e che, dopo tre decenni di sviluppo, soprattutto dopo la morte di Moro, la politica italiana è degenerata in gestione parassitaria e corrotta del potere, analoga (con caratteristiche sue proprie) alla «faccenderia» tardo-ottocentesca. Allo stesso modo, una nuova forzatura – analoga strutturalmente al nazionalismo – si è poi affermata con l’avventura di Berlusconi, i cui eccessi (in ogni senso e in ogni campo) e la cui ostentata esemplarità, il cui narcisismo trionfalistico, ne fanno un nuovo Eroe nello stile di D’Annunzio, ma (e questa è una variante nello schema) al tempo stesso anche un politico concreto nello stile di Mussolini (dal quale si differenzia, ovviamente, per avere liberamente ottenuto il consenso e per non avere spento con la violenza le libertà costituzionali), abile nel trasferire a livello di massa il romanticismo politico e nel trasformarlo non in fascinazione totalitaria ma in fiction plebiscitaria e demagogica: un Eroe a cui le élites hanno ancora una volta ceduto lo spazio politico purché questo venisse conformato dal Capo in modo tale che esse potessero occuparsi solo dei propri affari, abdicando così al compito sia di produrre egemonia culturale sia di dirigere responsabilmente il Paese.
Ma oltre a questa analogia solo formale tra i due ventenni (quello mussoliniano e quello berlusconiano) ne emerge infine un’altra, fra il 1943 e il 2011: pare cioè che le élites tradizionali, davanti a un vincolo esterno costituito questa volta non dalla guerra ma da un attacco alla sovranità nazionale che viene dalla «tempesta finanziaria», abbiano tardivamente ripreso in mano la situazione, e cercato di neutralizzare Berlusconi, e con lui l’intero debole sistema politico, per far fronte, con il governo Monti, a dure esigenze emergenziali.
Certo, in quest’ultima fase le varianti rispetto alla fase del 1943-48 sono parecchie, ed evidenti, e se ne parlerà più diffusamente in seguito; com’è ovvio, non si può dire per ora se questo tardivo ritorno delle élites apre la strada a una nuova grande decisione egemonica che darà l’avvio a una Terza repubblica, o se ci attende una catastrofe, un lungo impaludamento oppure ancora un ritorno del berlusconismo. Quello che si può dire è che la storia politica d’Italia sembra scandita da un ritmo costante: dapprima una grande decisione egemonica (il Risorgimento, la Resistenza) fonda una legittimità specifica, un regime che si estende per circa mezzo secolo (monarchico-liberale, ciellenistico-democratico), il cui funzionamento è via via degradante, secondo modalità e tempistiche evidentemente diverse; a questo declino si cerca di reagire con forzature (pur nelle loro grandi differenze, il fascismo e il berlusconismo) che generano una nuova egemonia e una nuova instabile forma politica (circa ventennale), che si regge strutturalmente su procedure e su logiche emergenziali, e che è votata al fallimento. Soprattutto, pare evidente che mentre nei regimi ‘cinquantennali’ è presente – almeno alle origini, per poi illanguidire – un certo ruolo attivo delle élites, in quelli ‘ventennali’ queste si tengono molto più defilate rispetto alla politica, e si danno al più aperto particolarismo, per poi tentare in extremis un recupero che, attraverso percorsi tortuosi e imprevedibili, apre lo spazio di un possibile ordine nuovo. Nel complesso, le venture e le sventure delle élites sono un movimento ‘a pendolo’ dei loro rapporti rispetto alla politica: appunto, la loro riluttanza.
Infine un’altra costante da segnalare è che i grandi cambiamenti – sia quelli che consistono in decisioni epocali che danno vita a regimi cinquantennali, sia quelli che mettono fine a un’epoca di degrado e danno vita a un regime ventennale – sono innescati da un fattore esterno: l’appoggio anglo-francese per il Risorgimento; la prima guerra mondiale per il fascismo; il crollo del comunismo internazionale per la fine della Prima repubblica; la crisi finanziaria per la chiusura – provvisoria, fino ad oggi – dell’era berlusconiana.
Questo schema – che si ripete formalmente ma varia, anche moltissimo, quanto ai contenuti, e che ha solo rilievo critico-empirico, senza alcuna pretesa di assurgere a legge o regolarità politologica, o di fatale necessità storica – va messo alla prova attraverso un’analisi un po’ più ravvicinata delle vicende della Prima e della Seconda repubblica, e del ruolo che le élites vi hanno avuto, e possono avervi.
2. La Prima Repubblica
L’Italia che rinasce dalle macerie del 1945; che stenta a riprendersi per un decennio; che si lancia nella modernizzazione industriale, sociale, culturale; che conosce il centrosinistra, il Sessantotto, le stragi e gli anni di piombo; quell’Italia democristiana e partitocratica aveva élites.
Sociali, prima di tutto. Le antiche stratificazioni perdurano, benché in via di erosione man mano che le élites diventano più numerose e più complesse: la democratizzazione della società attenua le antiche deferenze sociali, le tradizionali posizioni di prestigio e d’autorità. Accanto a quelle vecchie emergono élites burocratiche e tecnocratiche, statali o parastatali (dall’Iri alla Banca d’Italia), di alta qualità, e alcune personalità di rilievo strategico, protagonisti della rinascita italiana, da Mattei a Einaudi, da Menichella a Vanoni a Carli. Grandi intellettuali e letterati (Moravia, Pavese, Pasolini, Sciascia, Vittorini, Fortini, Montale, Tomasi, Gadda, Bobbio, Del Noce; ma anche gruppi come quelli legati all’editore Einaudi e alla rivista «Il Mulino»), grandi artisti e registi (Fontana e Guttuso, Aldo Rossi e Gregotti, Fellini, Strehler, Visconti, Monicelli, Risi), grandi industriali e finanzieri (Olivetti, Pirelli, Falck, Agnelli, Ferrari, Mattioli, Cuccia), hanno dato il tono – anzi, molti toni discordanti, ma vivi e vitali – a una società sempre più dinamica, in impetuoso sviluppo economico (il sistema delle piccole e medie imprese, il Made in Italy), in crescita complessiva.
Ma la Prima repubblica conosceva anche le élites politiche. Nuove, principalmente, nonostante la guerra fredda abbia dato adito al recupero in grande stile di élites burocratiche dell’Italia fascista. Le vecchie élites politiche in senso stretto, disonorate dalla compromissione col fascismo e dalla fuga del re l’8 settembre, erano solo riuscite a far cadere, in extremis, il fascismo-regime, a cui avevano dato appoggio subalterno per vent’anni. Le nuove élites politiche furono i partiti democratici di massa, usciti dalla clandestinità, attori principali della Resistenza quando, uniti nel Cln, hanno collaborato in una inedita responsabilità nazionale per mostrare alla stessa Italia, oltre che al mondo, che la Patria non era finita, che il popolo italiano aveva ancora la capacità di autodeterminare il proprio destino: di fare, cioè, politica. Soggetti attivi della grande decisione anti-fascista, anche quando furono aspramente divisi dopo il 1947, i partiti dell’arco costituzionale esercitavano un autentico ruolo di direzione politica; tanto più incisivo quanto più la loro caratteristica di essere élites si coniugava con una dimensione popolare – e con un’attitudine inevitabilmente pedagogica, benché differentemente declinata fra centro e sinistra –: la vicenda politicamente fallimentare (benché indirettamente feconda) del Partito d’Azione mostra che il tempo dell’immediato successo politico delle ultra-élites morali e intellettuali era concluso. Per quanto contrapposti nelle scelte di civiltà fra Est e Ovest, nella forma e nelle priorità dello sviluppo, erano ormai i partiti di massa a mediare fra la società più vasta, le élites sociali e la politica istituzionale, e a trasformare con qualche efficacia i bisogni e gli interessi in ‘politiche’.
Nelle élites politiche erano senz’altro presenti elementi di disegno, di progetto, di egemonia; e c’era anche il conflitto politico e sociale fra diverse visioni del mondo e fra diverse strategie; ed era attivo anche, con forza, l’esercizio dell’esclusione: Dc e Pci erano sullo stesso piano costituzionale, ma non politico, e la conventio ad excludendum funzionava appieno contro i comunisti. Nondimeno, proprio Berlinguer riconosceva che
politica si faceva nel 1945, nel 1948 e ancora negli anni Cinquanta e sin verso la fine degli anni Sessanta. Grandi dibattiti, grandi scontri di idee e, certo, anche di interessi corposi, ma illuminati da prospettive chiare, anche se diverse, e dal proposito di assicurare il bene comune. Che passione c’era allora, quanto entusiasmo, quante rabbie sacrosante! Soprattutto c’era lo sforzo di capire la realtà del Paese e di interpretarla. E tra avversari ci si stimava. De Gasperi stimava Togliatti e Nenni e, al di là delle asprezze polemiche, ne era ricambiato (intervista sulla Questione morale, 1981).
Insomma, le élites politiche fino ai primi anni Settanta condividevano l’idea che debba esserci un rapporto fra la parte e il Tutto, fra la parzialità degli interessi delle posizioni e la generalità della cittadinanza. E ciò rende ex post (cioè per noi oggi, ma già Berlinguer si sente postumo, quando rilascia l’intervista a Scalfari) non del tutto negativo il giudizio sui decenni della Prima repubblica; e non solo perché questa, soprattutto nei momenti di difficoltà nella lotta contro il nazismo, il terrorismo e la mafia, ha con...