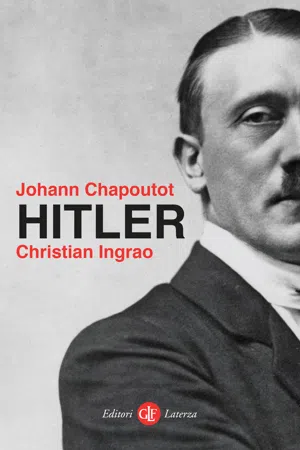1.
Gioventù
Hitler non amava l’Austria, anche se ci era nato, il 20 aprile 1889, a Braunau am Inn, al confine tra Austria-Ungheria e Reich tedesco. A suo parere questo paese era un’entità priva di ragion d’essere. Il luogo da lui più amato nel corso della sua vita, il Berghof, si trovava comunque al confine tra Reich e Austria; gli ricordava i paesaggi alpini e la bellezza della natura del suo paese natale. Ha abitato al Berghof negli anni Venti prima di acquistarvi una casa, e poi di costituirvi una vasta tenuta. Vi passava la maggior parte del tempo, quando non era trattenuto, a partire dal 1939, in lontani quartieri generali per via dei problemi bellici.
Infanzia
Hitler non amava l’Austria perché rappresentava suo padre. Alois Hitler era un funzionario delle dogane dell’Impero austro-ungarico: un impiegato di quella frontiera che agli occhi di Adolf era priva di senso perché l’Austria, tedesca e germanofona, era parte integrante di un grande blocco culturale e linguistico di popoli. Presto parlerà di un grande blocco razziale che ai suoi occhi non conosceva confini. Hitler ha rispettato ma non ha mai amato il padre, uomo freddo, votato alla propria carriera professionale e povero di attenzioni verso la moglie Klara, madre del piccolo Adolf, che l’ha invece adorata e riverita per tutta la vita, subendo un trauma di grandi proporzioni alla sua morte. Terrà sempre con sé il suo ritratto, fino al suicidio nel bunker, alla fine di aprile del 1945, pochi giorni dopo il suo ultimo compleanno.
I genitori di Hitler appartengono a una piccola borghesia che è piuttosto agiata senza potersi definire ricca, segnata dai flagelli dell’epoca, nella fattispecie la mortalità infantile. I primi tre figli muoiono in tenera età, e così, dato che il piccolo Adolf riesce a sopravvivere, diviene presto il figlio carissimo e adorato di Klara, madre con la quale ha un rapporto privilegiato, tanto più che né lei né il bambino provano affetto per Alois. Questo padre più anziano è abitualmente assente e quando non è al lavoro preferisce passare il tempo con gli amici nelle birrerie, propenso più a una sociabilità maschile di paese che al focolare.
La regione natia di Hitler è segnata da un forte cattolicesimo, caratteristico di quest’Austria provinciale, rurale, montanara e remota. Nel 1897, all’età di otto anni, viene mandato in collegio proprio nel monastero benedettino di Lambach, rinomato per la serietà dell’insegnamento. Il piccolo Adolf, infatti, non è esattamente un allievo attento e brillante, almeno non agli occhi del padre, che desidererebbe farne, come lui, un funzionario dello Stato austro-ungarico. Questa monarchia bicipite, che guida e governa il centro dell’Europa dall’inizio dell’Ottocento, accorda un’attenzione tutta particolare alla formazione dei suoi quadri. Questa è la carriera a cui Adolf è indirizzato, e in ciò la frequentazione del monastero benedettino di Lambach dovrebbe essere d’aiuto.
Hitler ricava da questa esperienza sia una certa ammirazione, persino un’attrazione, per la Chiesa cattolica, così presente e così altamente significativa nell’Austria austro-ungarica, sia allo stesso tempo un forte scetticismo nei confronti di quei monaci per i quali non prova nessun particolare affetto.
A undici anni, dopo le scuole elementari, va a studiare a Linz, il capoluogo della regione, dove frequenta la Realschule, un collegio di formazione professionale indirizzato alla funzione pubblica. È significativo il fatto che il giovane Adolf Hitler non ottenga risultati sufficienti a permettergli di frequentare il Gymnasium (“liceo”), ovvero l’istituzione formativa delle élites che prepara alla Matura (l’“esame di maturità”) e apre le porte dell’università. All’epoca solo l’1% di una generazione di alunni frequenta il liceo, consegue la maturità e prosegue negli studi.
Adolf Hitler non fa parte di questa categoria: è votato a una carriera e a una vita da funzionario intermedio. Alla Realschule la formazione è più pratica, nonché più tecnica: niente latino e greco, materie umanistiche poco studiate. Vi si insegna la storia, ma prevalgono le scienze naturali, la tecnologia, la formazione scientifica: in breve, tutti quei saperi che, a giudizio dei pedagoghi e dei funzionari dell’epoca, formano meglio e più adeguatamente a una carriera pratica di uomo inserito nel proprio tempo.
Scuola e ingresso nell’età adulta
I risultati del giovane allievo non sono particolarmente lusinghieri neppure al collegio di Linz. Le sue materie preferite, dirà in seguito, erano la lingua e la letteratura tedesca, nonché la storia. Nel Mein Kampf dedica alcune celebri pagine al dottor Leopold Pötsch, suo professore di storia, che l’ha iniziato alla gloria della storia germanica. Nella fattispecie, pangermanica, perché evidentemente il dottor Pötsch non fa differenza tra l’Austria e il Reich tedesco; sviluppa nel suo corso l’evolversi delle grandi gesta di una razza germanica compiute dall’antichità al presente, a cui l’Austria partecipa malgrado una separazione politica che da allora, sottolinea Hitler nel Mein Kampf – ma si tratta in questo caso di una ricostruzione a posteriori –, inizia a farlo soffrire.
In età scolare, a quattordici anni appena, Hitler vive un evento liberatorio: la morte del padre. Alois lascia alla moglie, al figlio e al resto della prole una somma che consente a Hitler di guardare all’avvenire con una certa serenità, e che potrebbe permettergli di vivere comodamente a Linz e forse anche a Vienna, città di cui inizia a subire il fascino.
La vita con la madre rappresenta un periodo felice per il giovane, che può adesso rifiorire senza più la presenza del padre e godersi alcuni anni che – anche se non lo sa ancora – saranno gli ultimi passati con lei.
Nel 1905 Hitler lascia il collegio professionale senza aver ottenuto alcun diploma né aver superato l’esame finale. Questo non sarebbe stato possibile se Alois fosse stato ancora in vita, ma la scomparsa del padre permette al figlio di emanciparsi completamente dall’istituzione. Dopodiché Hitler attraversa un periodo difficile.
Nel 1907 viene diagnosticato un tumore a Klara. Le cure dell’epoca sono rudimentali e la malattia finisce col prevalere il 21 dicembre di quello stesso anno. La tragedia segna ancor più durevolmente il diciottenne Hitler in quanto la donna è curata e seguita dal buon dottor Blum, un medico ebreo verso cui Hitler non nasconde la propria riconoscenza.
Quest’anno 1907 è segnato, oltre che dal decesso dell’adorata madre, anche dalla bocciatura al concorso per entrare all’Accademia di belle arti di Vienna. Questa sconfitta personale risulta tanto più incomprensibile per Hitler in quanto è stato educato da una madre amorevole nell’idea della propria singolarità, se non eccezionalità. Klara aveva preferito vedere la solitudine e la difficoltà del figlio a comunicare con chiunque come il segno, se non di una predestinazione, almeno di una forma di genio, e anche lui ne era convinto. In questo senso Klara e Adolf sono figli del proprio tempo: un’età post-romantica in cui si ritiene che il genio esista, che sia solitario, asociale ed estraneo al mondo, quel mondo che a Hitler piacerebbe dominare con la sua arte e la sua personalità.
Hitler interpreta queste ore e questi momenti di sofferenza, vissuti nella privazione d’affetto da parte del padre e nell’incapacità di comunicare con i compagni di classe – è prima di tutto un adolescente che non ha amici –, come sintomi del proprio genio. Eppure, cozzare contro un ostacolo istituzionale che smentisce il suo genio non giudicandolo neppure degno di entrare in un’accademia di belle arti rappresenta un vero trauma, raddoppiato dalla perdita incomprensibile, assurda e tragica della madre.
Una fase d’ozio a Vienna
Questa scomparsa, tuttavia, nonostante il rapporto privilegiato che lo univa alla madre, costituisce per Hitler una seconda emancipazione innanzitutto da un punto di vista materiale, perché la piccola eredità che gli tocca gli permette una vita decente, se non agiata, non più a Linz ma ormai a Vienna: fa infatti il grande passo e va a stabilirsi nella capitale dell’Impero austro-ungarico. Qui fa una vita da bohémien – anche in questo è figlio del suo tempo, coltiva il mito di una singolarità artistica apparentata alla marginalità – ma assai mediocre, senza creatività né successo, poiché nell’autunno del 1908 viene di nuovo bocciato al concorso per entrare all’Accademia di belle arti.
Non viene affatto riconosciuto come artista. Si accontenta di condurre una vita senza grossi stimoli, avendo come unico amico il coinquilino August Kubizek, che conosce dai tempi di Linz e che l’ha seguito a Vienna prima di entrare nell’esercito. Kubizek è autore di una testimonianza sul giovane Hitler redatta dopo la seconda guerra mondiale. Il testo va usato con cautela ma offre talvolta indicazioni interessanti quando corroborate da altre fonti; vi si apprende che da giovane Hitler era spesso e volentieri indolente, poco capace di applicarsi a un lavoro o di portare a termine un progetto. Ad esempio, una volta gli viene l’idea di comporre un’opera lirica e si getta a corpo morto in questo compito – che avrebbe certamente avuto un esito sublime –, ma nel giro di qualche giorno, stanco e spossato, lascia perdere.
Hitler è l’uomo dei progetti irrealizzati, di una vita da bohémien, di un’indolenza assolutamente sterile, di una procrastinazione indifferente, infeconda. Quando non dorme, tenta di farsi un po’ di cultura. Si sveglia molto tardi per poi girovagare per le strade di Vienna, comprando qua e là giornali e riviste, impregnandosi dello spirito del tempo, della cultura politica dell’epoca in questa città dell’anteguerra, una Vienna capitale di un impero multietnico e multinazionale, dove la germanità e i germanofoni si sentono in una situazione ossidionale, accerchiati e minacciati.
Il caso particolare dell’Austria-Ungheria
Hitler è fortemente segnato da questa situazione sociale, politica e culturale della germanità austriaca. L’Austria-Ungheria si chiama così dal 1867, quando l’imperatore Francesco Giuseppe ha dovuto fare alle minoranze – e in particolare alla minoranza ungherese, talmente numerosa da essere quasi maggioritaria in alcune regioni – la concessione consistente in un nuovo statuto dell’impero e dell’Ungheria. L’Impero d’Austria diventa Impero austro-ungarico, una monarchia duplice, al contempo imperiale e regia, k. und k., königlich per l’Ungheria e kaiserlich per i domìni della Corona austriaca.
Questo statuto del 1867 è una concessione al nazionalismo ungherese e un tentativo di preservare l’edificio dell’impero. Mette in luce la potenza dei nazionalismi, assai attivi, e la fragilità dell’idea d’impero in quanto costruzione di ancien régime multinazionale e multietnica, minacciata nell’era delle nazioni e delle nazionalità.
A partire dal 1815 l’Austria ha di fatto voluto difendere, nell’Europa delle gestazioni nazionali, una monarchia in cui i sovrani esercitavano un possesso patrimoniale nei confronti dei loro popoli. Questa idea di ancien régime, sempre meno accettata, porta a concessioni giuridiche, militari, culturali ed economiche. Immediatamente dopo la firma del compromesso del 1867 l’Austria tedesca si accorge che forse l’Impero austro-ungarico, composto da germanofoni, polacchi, cechi, ungheresi, croati ed ebrei – che nell’ambito del diritto austro-ungarico costituiscono una nazione a tutti gli effetti – non è destinato a durare. Questo impero multinazionale e multietnico inquieta i Deutsch-Österreichisch (gli austriaci tedeschi e germanofoni), e Hitler è uno di essi.
D’altronde Hitler può constatarlo quotidianamente: Vienna è un concentrato eccezionale di multietnicità e di multiculturalismo. Vi si incrociano ebrei col caffettano, ungheresi, croati... Tutti questi popoli sono peraltro rappresentati in un Consiglio imperiale, che non è democratico, perché non si tratta di una monarchia parlamentare: è un’altra concessione dell’imperatore alle nazionalità. Nella sua inoperosità, Hitler assiste alle sedute.
In tali occasioni osserva che in questa assemblea, invece di parlare tedesco, si parlano tutte le lingue dell’impero, e non ci si capisce. Matura così una forma di scetticismo, se non di rigetto rispetto al parlamentarismo, perché definisce già allora questo consesso in cui si parla senza decidere il «Parla-Parla-Parlamento».
Rifiuto di un’«aberrazione della storia»
Hitler odia questo multietnicismo, questo multiculturalismo, questa sottospecie di parlamentarismo o di rappresentazione multinazionale. Così come detesta il movimento socialdemocratico, che è battagliero ed è fortemente presente nella capitale austriaca, mentre per contrasto lo è poco o niente nel resto del paese. In questi anni si cristallizza in lui anche un rifiuto radicale dell’Austria-Ungheria: di questa popolazione variegata ed eterogenea che è il concentrato di tutte le nazioni dell’impero. Un impero che in fondo simboleggia un padr...