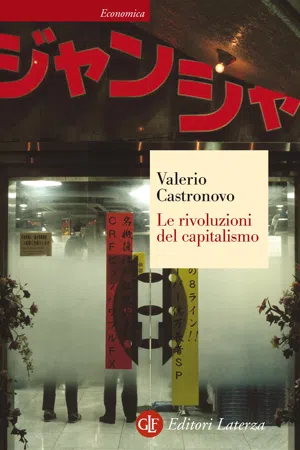
- 176 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Le rivoluzioni del capitalismo
Informazioni su questo libro
Gli esordi di un'economia-mondo, gli sviluppi dell'industrializzazione, il neo-capitalismo e il suo successo, la contesa fra i paesi più avanzati, l'ascesa dell'Asia e la rivalsa della Russia, i problemi del sottosviluppo e quelli di governo del mercato globale, l'avvento dell'informatica, la ricerca di un nuovo modello sociale, uno scenario geo-economico senza più frontiere. Valerio Castronovo traccia, in forma chiara e accessibile, un profilo d'insieme su scala mondiale degli eventi che hanno segnato la storia economica e sociale nel corso del tempo sino ai giorni nostri.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Le rivoluzioni del capitalismo di Valerio Castronovo in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Business e Etica aziendale. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
1.
GLI ESORDI DEL CAPITALISMO
Le teorie. Da Marx a Schumpeter, da Weber a Sombart
È passato un secolo e mezzo da quando Marx sostenne che il capitalismo si sarebbe dissolto, in quanto minato dalla lotta fra borghesia e proletariato e vittima predestinata delle sue intime contraddizioni. E non solo le sue predizioni non si sono avverate. Ma, invece che al crollo del capitalismo, si è assistito alla disfatta del suo antagonista storico, il comunismo. In verità, tanti altri pensatori, dopo il filosofo di Treviri, hanno dato per scontato che il capitalismo non sarebbe sopravvissuto ai conflitti di classe o all’impatto con le trasformazioni da esso stesso generate.
Schumpeter, che nella «violenza innovativa» identificava la ragion d’essere del capitalismo, riteneva che il sistema capitalistico sarebbe stato condannato fatalmente all’estinzione, e alla transizione verso il socialismo, qualora i grandi gruppi d’interesse e l’intervento dello Stato avessero preso il sopravvento sull’iniziativa e sull’impresa individuale. Che era appunto quanto stava avvenendo nel mezzo degli anni Trenta, all’indomani della «grande crisi», allorché egli attendeva alla stesura di un’opera come Business Cycles, con cui si proponeva di dimostrare che non già un processo rivoluzionario avrebbe atterrato il capitalismo, bensì l’esaurimento della sua forza d’urto iniziale, quella impressa dal dinamismo e dalla carica competitiva di una pluralità di soggetti economici.
Sennonché proprio il gigantismo industriale e l’economia programmata, che Schumpeter considerava forieri di altrettanti pericoli mortali per il sistema come la spersonalizzazione e la burocratizzazione, concorsero non solo a tenere in vita il capitalismo, che allora sembrava ridotto alle corde, ma a porre le premesse di nuovi equilibri strutturali e di un più intenso ciclo espansivo. Su un punto fondamentale, tuttavia, egli aveva perfettamente ragione: sul fatto che il capitalismo sarebbe votato al declino se venisse a mancare la capacità del sistema d’impresa di produrre ricchezza e sviluppo.
In effetti, la vocazione creativa, lo stimolo all’innovazione, è stata la leva fondamentale del capitalismo sin dal suo sorgere ed è tuttora il suo tratto distintivo.
C’è voluta peraltro una lunga gestazione perché quel che Max Weber definiva lo «spirito» del capitalismo venisse in luce e poi una fase di incubazione non meno complessa perché si affermasse pienamente. Risale infatti a cinque secoli fa la formazione di quel primo embrione di un’economia di mercato su scala mondiale, in virtù del quale cominciarono ad acquisire maggiore consistenza e più rapide cadenze il movimento delle merci e delle monete, la circolazione dei prodotti e l’accumulazione del danaro.
Molto si è discusso sulla paternità e la data di nascita del capitalismo. Weber attribuiva la genesi dello «spirito d’impresa» all’etica protestante, in particolare a quella espressa dalla componente più radicale della Riforma, che considerava il successo ottenuto con il proprio lavoro, da quanti davano prova di impegno e operosità, come il segno della predilezione divina e dunque della salvezza eterna. Sarebbero così venuti meno quei freni morali nei confronti del profitto imposti dai precetti della Chiesa che condannava alla stregua di un peccato mortale l’arte di far danaro attraverso il tesoreggiamento, il prestito a interesse, o un uso della proprietà a solo scopo di lucro. E dalla teoria della predestinazione avrebbe ricevuto consacrazione anche quel senso vigoroso dell’iniziativa e della responsabilità personale, quello «spirito acquisitivo» destinato a forgiare la condotta di vita e i valori ideologici della borghesia.
Di tutt’altro parere era Werner Sombart. Egli scorgeva nella sottile casistica del tomismo e della tarda Scolastica argomentazioni tali da fornire una giustificazione del guadagno fine a se stesso. Giacché san Tommaso, pur ribadendo che le pratiche mercantili non erano di per sé «né buone né naturali», aveva tuttavia affermato che la questione essenziale stava nel «giusto prezzo» dello scambio. E alcuni suoi discepoli non solo avevano riconosciuto che si sarebbero dovuti conteggiare anche i rischi derivanti dalle fluttuazioni di mercato, ma erano poi giunti ad ammettere, sia pur con cautela, la liceità del prestito in danaro quale corrispettivo di un «lucro cessante».
I fatti. Dai grandi viaggi di scoperta all’espansione degli scambi
In realtà, l’ethos capitalistico non scaturì dal verbo di Calvino o dalle predicazioni di sant’Antonino, quantunque si possano ravvisare nel suo codice genetico, nella formazione di un atteggiamento educato all’iniziativa e alla responsabilità individuale, e perciò consono al perseguimento razionale del profitto, attributi e impulsi provenienti tanto dall’evangelismo protestante quanto dalla tradizione cattolica, nonché da altre esperienze religiose come l’ebraismo.
A dar forma e sostanza al capitalismo fu piuttosto un intreccio di esigenze concrete, di calcoli politici e di motivi ideali variamente convergenti, pur lungo un tracciato non univoco né omogeneo, che indussero gli europei sia a uscir fuori dal guscio di un’economia stagnante, sia a liberarsi dalle ragnatele del tradizionalismo in un’epoca ancora sottomessa ai dogmi della Chiesa ma pervasa dai fermenti della cultura rinascimentale, da un’ansia di nuove conoscenze e di avventura.
Quell’autentica ossessione sempre più intollerabile che era divenuta nel corso del Quattrocento la penuria d’oro e di argento, e la convinzione che in altre contrade ancora inesplorate esistessero grandi quantità di metalli preziosi, giocarono una parte importante nella genesi del capitalismo. Tanto più che alle necessità finanziarie di monarchie e principati s’univa anche il loro interesse a stabilire un contatto diretto con i paesi dell’Estremo Oriente, produttori di spezie e di sete, senza dover sottostare al monopolio esercitato da Venezia lungo le rotte per il Levante, né a quella sorta di «spada di Damocle» sui commerci fra l’Europa e l’Asia rappresentata dall’Impero ottomano.
Sta di fatto che, sebbene quella aperta da Cristoforo Colombo attraverso l’Atlantico non fosse una via diversa per le Indie come si sperava, la scoperta di un nuovo continente emerso dall’ignoto si risolse per gli europei in un ottimo affare. In America essi rinvennero non solo grandi quantità d’argento, ma trovarono anche terre abbondanti e fertili, bestiame e materie prime, e tante braccia (a cui si sarebbero poi aggiunte quelle degli schiavi razziati dall’Africa) da impiegare a loro piacimento nelle miniere e nelle piantagioni. Né fu questa l’unica manna caduta dal cielo. Il trapianto di alcune specie vegetali importate dal Nuovo Mondo (come il mais e la patata) si rivelò nel corso del tempo essenziale per l’alimentazione delle classi più umili e per l’aumento della popolazione prima decimata da periodiche carestie.
Fu questa sequenza di eventi – dai grandi viaggi di scoperta alla diffusione di nuove e più intense forme di scambio e di produzione, che vennero combinandosi con alcuni potenziali fattori di sviluppo sedimentatisi nei secoli precedenti – a tenere a battesimo il capitalismo. E fu lo spostamento del baricentro dei traffici dal Mediterraneo all’Atlantico, all’Oceano Indiano (anche se a tappe più graduali di quanto comunemente si ritenga), a creare quel particolare contesto sociale che rese possibile la fioritura di un’economia di mercato. Un contesto non più segnato dal predominio pressoché assoluto dell’aristocrazia fondiaria ma dall’affermazione di nuovi protagonisti: mercanti, armatori, banchieri, imprenditori.
Furono paesi come l’Inghilterra e l’Olanda, dove esistevano condizioni politiche e istituzionali più favorevoli, e città come quelle fiamminghe e anseatiche, cresciute in un regime di autogoverno o in procinto di conquistarlo, a fornire l’humus necessario per l’acclimatazione di quell’esile pianta che era ancora il capitalismo, e a raccogliere i frutti più copiosi della scoperta del Nuovo Mondo e dell’itinerario per le Indie, alternativo a quello tradizionale, aperto da Vasco de Gama con la circumnavigazione dell’Africa.
Proprio per la mancanza di questi requisiti, che avrebbero fatto della Gran Bretagna e dei Paesi Bassi la culla del capitalismo, la Spagna, che pur aveva dischiuso la via per l’America, accusò da allora un declino irreversibile. La parabola che la portò a diventare nel corso del Cinquecento la maggior potenza della Terra e a sprofondare poi altrettanto rapidamente in una crisi inesorabile, riflette in maniera emblematica quanto abbiano contato, per l’avanzata del capitalismo e per il successo dei paesi che ne furono i precursori, lo spirito d’iniziativa individuale e l’esistenza di determinate componenti civili e culturali, assai più del dominio su un gran numero di terre e di sudditi.
Nuovi scenari e nuovi protagonisti
«La Castiglia ha fatto la Spagna e la Castiglia l’ha distrutta», scriverà Ortega y Gasset. Se da un lato la supremazia della Spagna nel sedicesimo secolo fu dovuta per tanti versi al vigore e al bisogno di rivalsa della gente di una regione arida e scabra, soggetta a un pugno di latifondisti, dall’altro fu infatti il bagaglio di pregiudizi che i castigliani si portarono dietro dalle loro lande desolate, nella colonizzazione del Nuovo Mondo, una delle principali cause dell’eclisse subìta dalla Spagna nel corso del Seicento. Giacché l’arroganza e la sete di potere degli hidalgos, l’ambizione di una borghesia povera e frustrata al possesso di un titolo nobiliare, e il fanatismo religioso e razziale che covava sia negli uni che negli altri, finirono per contagiare di questi stessi morbi il resto della società spagnola e agirono da altrettanti ostacoli a un’efficiente gestione dei territori acquisiti dalla Corona.
L’illusione di poter vivere indefinitamente di rendita, grazie alla spoliazione delle antiche civiltà precolombiane e allo sfruttamento rapace e indiscriminato degli indigeni, non solo infiacchì la tempra dei conquistadores, ma spinse a un livello esorbitante le spese della monarchia e distolse dal commercio e dai mestieri (dagli «esercizi», come osservava Guicciardini) gran parte del ceto medio, attratto dai facili guadagni che si potevano ottenere dall’acquisto di titoli del debito pubblico. Fu così che l’economia spagnola venne presto travolta da un’inflazione irreparabile provocata tanto dalla valanga di metalli preziosi rovesciatasi dalle miniere americane, quanto da un continuo drenaggio di risorse dovuto alla necessità di rifornirsi all’estero a prezzi sempre più elevati dei servizi e dei manufatti di cui essa era carente, quanto ancora dai cospicui impegni finanziari richiesti dalla difesa di un immenso Impero esposto da ogni parte ai colpi e alle mire delle potenze rivali.
Quel che invece mancò al piccolo Portogallo fu una popolazione sufficiente sia per presidiare a dovere tutti i suoi dominî, sia per sfruttare sino in fondo le posizioni commerciali acquisite in Oriente, a scapito degli intermediari arabi, e le vaste regioni di cui s’era impadronito in Brasile e altrove. Per giunta, allo stesso modo che per gli spagnoli, la conquista di nuove terre non indusse la classe dominante portoghese a sperimentare modelli di organizzazione economica diversi da quelli feudali. Anzi, il suo principale obiettivo fu di riprodurre tali e quali (e semmai in termini ancor più rigidi) nelle colonie d’oltreoceano le vetuste forme di produzione e i rapporti di lavoro servili del sistema signorile.
Una lacerante crisi economica, e col tempo anche d’identità (tanto più drammatica per la Spagna quanto pressoché assoluta era stata sino a pochi decenni addietro la sua egemonia), concorse così, fin dal Seicento, ad approfondire il divario tra la penisola iberica e il resto dell’Europa.
Una sorte altrettanto amara toccò all’Italia. Eppure essa era a quel tempo all’avanguardia nelle attività mercantili e nelle tecniche finanziarie.
Nell’ambito delle economie su cui s’irraggiavano i traffici della penisola, c’era innanzitutto Costantinopoli, che era per gli italiani qualcosa di simile a ciò che sarà Shanghai per gli europei nell’Ottocento: le monete d’oro italiane facevano aggio su quelle bizantine, i mercati del grano erano sotto il loro controllo, e così pure le entrate pubbliche. D’altra parte, l’acclimatazione del baco da seta in Italia aveva messo fine al monopolio della seta che un tempo aveva fatto la fortuna di Bisanzio. Nel Levante e nell’Africa del nord, non c’era porto siriano o egiziano, o sbocco sul mare dei principali traffici carovanieri, dove i mercanti italiani, sfruttando anche vecchie franchigie, non avessero messo le mani sul cotone filato e i drappi serici, sul riso e le spezie. Altrettanto rilevante era l’influenza che essi esercitavano nei paesi al centro e al nord dell’Europa. Giacché una manciata di città grandi e piccole, grazie alla posizione strategica della penisola, erano riuscite a turno o contemporaneamente a costruirsi con abilità e pazienza cospicue fonti di guadagno tanto con il commercio di transito e le operazioni di intermediazione finanziaria quanto con l’esportazione di alcuni manufatti di gran qualità.
Le guerre per l’egemonia fra le maggiori potenze, che gli italiani non avevano avuto la forza di schivare, pur producendo devastazioni ed epidemie, non annientarono la preminenza economica della penisola. Ancora a metà del Cinquecento la superiorità delle manifatture fiorentine e veneziane era indiscussa; e continuavano a rendere bene le iniziative impiantate da uomini d’affari italiani a Lisbona, Siviglia e Anversa. Tant’è che i banchieri genovesi non temevano il confronto con i più quotati gestori di danaro di quel tempo come i Fugger e i Welser.
Furono le successive bancarotte di Spagna, Francia e Portogallo, nel terzo quarto del secolo sedicesimo, a infliggere un duro colpo ai finanzieri italiani (e così pure a quelli fiamminghi e tedeschi). Ma la retrocessione della penisola fu dovuta soprattutto alla sua permanente divisione in tanti staterelli, proprio quando altrove stavano imponendosi le grandi monarchie nazionali. Solo Venezia e Genova riusciranno in qualche modo a reggere, non così il resto della penisola sempre più prostrato sotto il peso della dominazione straniera o del malgoverno. È vero che nemmeno allora si esaurì la vitalità della società italiana. Giacché in passato non era stata solo la potenza del denaro ma anche quella della cultura a segnare il suo primato. Ed è un fatto che, pur nella fase del crepuscolo, banchieri e mercanti continuarono a battere un buon numero di piazze europee, mentre non tutta l’agricoltura, in specie quella padana, subì un processo di rifeudalizzazione. Sicché l’Italia non si ridusse a un paese esangue e intorpidito, quasi insignificante.
Ma i grandi giochi si svolgevano ormai all’esterno dello Stivale. Altri paesi l’avevano rimpiazzato alla testa dell’economia europea. E il loro primato sarebbe coinciso, sino a far tutt’uno, con gli sviluppi sempre più impetuosi del capitalismo.
A trarre i maggiori benefici dall’espansione dei traffici furono gli olandesi e gli inglesi. I primi, in quanto divennero, grazie anche all’impiego di navi più grandi e meno costose di quelle dei loro concorrenti, i principali intermediari nel commercio fra l’Europa e l’Asia, dopo aver detenuto, al tempo del dominio di Madrid sui Paesi Bassi, il monopolio della distribuzione delle mercanzie coloniali spagnole. I secondi, in quanto riuscirono a soppiantare – dapprima con la guerra da corsa e il contrabbando, poi con la conquista di intere regioni e di alcuni nodi strategici – l’originaria egemonia degli spagnoli sulle terre del Nuovo Mondo e lungo le rotte dell’Atlantico.
Calati in Asia al seguito della Compagnia delle Indie Orientali, o in ordine sparso, sotto la bandiera della nuova Repubblica delle Province Unite, gli olandesi misero in atto ogni espediente per allungare le mani sulle ricchezze delle isole disseminate tra Giava e le Molucche, e per sottrarre ai portoghesi (spalleggiati dagli spagnoli dopo l’unione nel 1580 delle due corone) le basi più importanti del commercio delle spezie. Ma essi furono abbastanza saggi da non pensare di ...
Indice dei contenuti
- 1. GLI ESORDI DEL CAPITALISMO
- 2. LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
- 3. L’ETÀ DELLA BORGHESIA
- 4. IL NEOCAPITALISMO TRA STATO E MERCATO
- 5. LA MODERNIZZAZIONEPOST-INDUSTRIALE
- 6. UN MERCATO GLOBALE
- 7. Che cosa ci attende
- BIBLIOGRAFIA