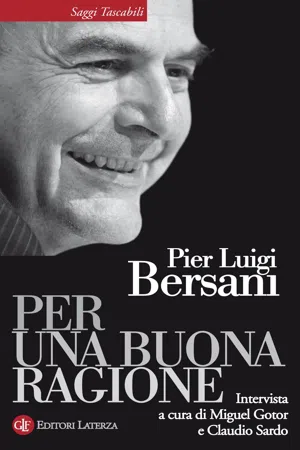
- 208 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Per una buona ragione
Informazioni su questo libro
«La crisi del sistema democratico è oggi il terreno della battaglia politica. La nostra buona ragione risiede in una visione umanistica, capace di tenere insieme il concetto di democrazia con quello di uguaglianza». Pier Luigi Bersani parla per la prima volta in un libro dell'Italia e del Partito Democratico nel tempo della crisi economica e dei grandi mutamenti indotti dal mercato globale. Affronta gli errori del centrosinistra, l'involuzione plebiscitaria della Seconda Repubblica e gli squilibri sociali del Paese. Per promuovere una nuova crescita e un impegno costituente propone l'«unità delle forze della ricostruzione». È il manifesto politico, culturale e civile del leader del Pd.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Per una buona ragione di Miguel Gotor,Pier Luigi Bersani,Claudio Sardo in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Economics e Economic Policy. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
EconomicsCategoria
Economic PolicyIV. L’Europa che vogliamo
D. Il mondo vive rivolgimenti profondi. La globalizzazione sta cambiando le gerarchie del pianeta a sfavore dell’Europa, e dunque anche dell’Italia. La razionalità dovrebbe spingere a rafforzare l’Unione europea, se non altro perché è la sola dimensione che può consentire al vecchio continente di competere e di far sentire la voce della propria civiltà, ma la crisi economica, la più pesante dal crollo di Wall Street del ’29 e dalla Grande depressione, genera paure, chiusure localistiche, pulsioni populiste. È possibile spezzare questa tenaglia e come?
R. Anzitutto bisogna comprendere, definire la globalizzazione. Solo così risulterà evidente quanto grande sia il bisogno di Europa, da parte dei suoi cittadini come del mondo intero. Questa non è la prima impetuosa globalizzazione che la storia conosce. Anche tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento ci fu uno straordinario salto tecnologico: in pochi anni vennero inventati la bicicletta, la ferrovia, l’aereo, l’automobile, il transatlantico, l’energia elettrica, la radio, si fece l’ora di Greenwich e tutto il mondo registrò l’orologio. Pure allora la tecnica moltiplicò e accelerò produzioni e scambi commerciali. Fu una globalizzazione sostenuta da idee positiviste, dove l’aspirazione a una nuova umanità si incrociava con l’ottimismo scientista, dove l’euforia della Belle époque si combinava con la diffusione delle idee socialiste e le prime battaglie per l’emancipazione del mondo del lavoro, ma ciò non impedì meccanismi difensivi e chiusure nazionaliste che precipitarono nella Prima guerra mondiale. Le piazze delle capitali europee divennero spettatrici di manifestazioni di popolo a favore della guerra: il desiderio bellico penetrò nel cuore dell’Europa e con lo sguardo di oggi possiamo dire che ci restò fino al termine della Seconda guerra mondiale. La storia non si ripete mai ma ama le rime e le assonanze. Dobbiamo avere per certo che la faccia oscura dei processi di globalizzazione è sempre e comunque, in qualche forma, un istinto al ripiegamento.
D. Eppure sembra arduo accostare quanto sta avvenendo all’esordio del nuovo millennio con ciò che è accaduto più di un secolo fa. Il salto tecnologico di questi anni ha rimpicciolito il mondo, non solo negli scambi ma anche nella comunicazione, nelle conoscenze, nella cultura, tanto da produrre quasi uno sconvolgimento antropologico.
R. È vero, il mondo si è così rimpicciolito che ora te lo trovi alla porta di casa. Internet sembra aver travolto ogni barriera. E tutti siamo finiti in un frullatore: straordinarie opportunità si mescolano a indebite intrusioni e ingiustizie. Eppure ci sono duri fattori strutturali che delineano la nostra globalizzazione e che spiegano anche le cause della crisi economica e finanziaria. Comprendere similitudini e differenze rispetto al passato è necessario per elaborare una strategia riformista e contrastare ciò che sembrava imporsi come «pensiero unico». Il salto tecnologico del nostro tempo ha prodotto e incrociato un enorme incremento della dinamica produzione-scambi, ma, a differenza di ogni altra epoca precedente, l’aumento degli scambi ha superato di molto quello della produzione. Sono state distribuite inedite chances di crescita, sono cambiate le gerarchie mondiali, ma gli squilibri strutturali sui quali poggiava la globalizzazione hanno avuto come conseguenza la terribile crisi economico-finanziaria dai cui effetti non ci libereremo presto. Oggi molti concordano sull’analisi della crisi: si è creato denaro senza un adeguato sviluppo dei mercati interni; l’economia più forte, quella americana, è cresciuta sul debito, finanziata in larga parte dalla Cina che accumulava risorse con l’export, ma anche dai Paesi produttori di petrolio che investivano in titoli i loro ricavi concentrati in pochissime mani; si è pensato che invece di remunerare il lavoro si potessero garantire con il debito privato i consumi della classe media; l’autonomia della finanza ha inventato moltiplicatori che hanno prodotto una gigantesca bolla speculativa, convincendo i cittadini che persino il debito privato potesse produrre ricchezza; la grande illusione è stata infine completata dalla bassa inflazione, dovuta principalmente a merci confezionate in Asia a costi ridottissimi. Insomma, non c’erano più termometri per misurare la febbre. Ma poi la febbre è esplosa lo stesso.
D. La globalizzazione comunque non è solo la crisi economico-finanziaria. Altrimenti bisognerebbe concludere che la globalizzazione è cattiva e che occorre tentare un’improbabile retromarcia.
R. Non sono certo i progressisti a dire che la globalizzazione è cattiva. Come potremmo farlo? Se rinunciassimo alla speranza che «il mondo diventi una cosa sola», come cantava John Lennon, rinunceremmo anche al seme di un nostro pensiero alternativo. Piuttosto sono le destre populiste a prosperare con le demagogie nazionaliste e localiste. Da noi è l’ampolla di Umberto Bossi il rito anti-globalizzazione per antonomasia. Ma provi Bossi a riempire l’ampolla nel Pacifico e vediamo se riesce a fermare la globalizzazione! In realtà mentre le destre populiste agivano all’interno sulle paure dei ceti popolari, le forze conservatrici al governo dell’Europa hanno dato campo libero al pensiero unico e alla «politica unica». Nel 2001 uscì una bozza Tremonti, ispirata al modello americano dei mutui, la quale muoveva dal presupposto che gli italiani fossero in larga maggioranza proprietari di case cresciute di valore nel tempo: obiettivo del suo progetto era monetizzare quel plusvalore per trasformarlo in consumi individuali. Per fortuna non se ne fece nulla, grazie alle denunce dell’opposizione. Ma la filosofia era la stessa quasi ovunque: nessun investimento sui salari e sull’ammodernamento del welfare, disattenzione rispetto all’economia reale. Il limite dei progressisti, soprattutto negli anni Novanta in cui hanno avuto responsabilità di governo in gran parte dell’Europa, è stato quello di confidare un po’ ingenuamente nelle magnifiche sorti della globalizzazione che allora avanzava. Erano gli anni di Bill Clinton, e l’influenza sulle sinistre europee si è sentita. La comunicazione globale offriva inedite potenzialità di emancipazione, apriva i mercati dell’Asia a beneficio sicuramente della crescita di Cina e India (ma oggi cosa ne sarebbe della nostra industria senza l’aumento della domanda asiatica?), lasciava intravedere un ciclo di espansione anche della democrazia. L’errore è stato far correre la finanza senza regole, non comprendendo la sua propensione egemonica: la finanza ha affinato i propri strumenti esattamente nel punto in cui il ciclo tecnologico dell’informatica ha raggiunto la massima velocità. Con la net economy in quegli anni si è scomposto e ricomposto il capitalismo. La manifattura sembrava non valere più e a dare i più alti rendimenti erano i titoli immateriali. Non si stava formando solo una bolla: era una cultura, una nuova scala di valori, un’evoluzione del mercato che veniva imposta non solo come auspicabile ma come l’unica possibile.
D. Nel libro La paura e la speranza, che diventò nel 2008 una sorta di manifesto elettorale della coalizione Pdl-Lega, Tremonti assegnò alle forze di centrosinistra la responsabilità maggiore di essersi arrese alla cultura «mercatista», mentre invece riservò al centrodestra le principali riserve valoriali per rimettere la persona e la società al centro dell’economia.
R. Non ho negato le responsabilità delle forze progressiste negli anni Novanta. Ma quelli di Tremonti mi sembrano giochi di parole per evitare il confronto con la realtà e tentare semmai di rovesciarla. Il tempo del «mercatismo» è stato soprattutto lo scorso decennio, dominato da un lato dall’amministrazione del repubblicano George W. Bush, dall’altro dai governi conservatori nella maggioranza dei Paesi europei. Queste forze sono riuscite, è vero, a interpretare meglio le paure delle classi medie ma intanto l’Europa ha perso drammaticamente terreno nella competizione globale e la politica si è mostrata incapace di regolare, persino soltanto di contenere lo strapotere di una finanza che si concepiva ormai come la padrona del mercato. Sia chiaro, non mi sfugge la differenza tra i partiti conservatori classici, ancorati ai valori costituzionali e ai fondamenti della cultura europea, e i fenomeni populisti e regressivi che compaiono in varie lande del continente e che mostrano di condizionare in qualche misura le destre costituzionali. Comunque, le politiche conservatrici non hanno graffiato. Il loro vantaggio competitivo è stato fin qui nella risposta alla crisi, tutta interna alla dimensione nazionale, mentre invece risulta sempre più evidente che un progetto riformista non può limitarsi a un Paese solo. I riformisti hanno bisogno di una scala più grande: questo è il nostro problema. La crisi sta dimostrando a tutti che la chiusura nazionale è un’illusione. Purtroppo, tornando a Tremonti, la realtà dei fatti è che la «paura» riguarda i poveri e le classi medie mentre la «speranza» è riservata ai ricchi. E per cambiare queste cose bisogna incidere nelle strutture, immettere dosi di uguale libertà e uguale dignità negli ordinamenti e nello stesso mercato. Solo una crescita equilibrata e regolata, questa è la sfida, può garantire anche una crescita più duratura.
D. La scala più grande, a cui lei fa riferimento, si chiama Europa. Eppure a Bruxelles continua a prevalere la dimensione intergovernativa e l’Unione viene rappresentata dagli stessi governi nazionali più come un vincolo che come una opportunità per tornare a giocare un ruolo da protagonista nel mondo.
R. Il troppo debole investimento sull’Europa rispetto alle esigenze delle nostre società è sicuramente un punto critico. Ma l’Europa comunque esiste. Anzi l’Unione europea è un miracolo vivente, se pensiamo soltanto a cos’era il continente mezzo secolo fa, dopo la fine della Seconda guerra mondiale, o all’indomani della caduta del Muro. Il calabrone vola, anche se noi vogliamo che voli meglio. E proprio perché vola i nostri progetti hanno un fondamento tangibile. Il bisogno di più Europa nasce dalle contraddizioni della globalizzazione di cui abbiamo parlato e dalla profondità strutturale della crisi economica. Le gerarchie del mondo sono cambiate e, guardando indietro, non si può nemmeno dire che la Cina sia emersa all’improvviso dalle retrovie dei Paesi in via di sviluppo: la Cina ha alle spalle una storia millenaria di protagonismo economico, culturale e politico che la relativa marginalità degli ultimi 150 anni non può occultare. In questa nuova realtà geopolitica, seguita alla fine dell’era di Yalta, dove i Paesi emergenti hanno il calibro di Cina e India, è evidente che solo l’Europa dispone della massa critica e della forza politica sufficiente per svolgere una funzione equilibratrice.
D. Cina e India però non sono solo competitori esterni dell’Europa. L’effetto dumping sui prezzi di produzione e sul costo del lavoro li trasforma in concorrenti e in costanti minacce alla nostra stabilità sociale. Come rispondere?
R. La Cina e l’India stanno diventando la «fabbrica del mondo». Ma ciò che è una minaccia per il singolo sistema-Paese può esserlo meno per l’Europa presa nel suo insieme, che ha in sé una grande forza di compensazione, data anzitutto dal suo mercato interno di 550 milioni di cittadini. Il problema è che neppure il mercato interno oggi è liberato da persistenti barriere. Finché le risposte restano nazionali il rischio è che, nella competizione con l’Asia, i Paesi europei continuino a essere schiaffeggiati dalla parte del welfare e dei diritti del lavoro, aprendo altri territori alla precarietà dei giovani e dunque all’instabilità delle nostre società. Invece un’Europa più unita può trasmettere una maggiore fiducia ai suoi cittadini, dando vigore al suo mercato interno e sfruttando meglio le opportunità che l’apertura dei mercati e la crescita del Pil in Asia offrono alle sue aziende, alle sue tecnologie, al suo export. Fino a pochi anni fa gli Stati Uniti guardavano con freddezza, anzi persino con qualche sospetto al processo di integrazione dell’Europa: ora mi pare significativo che pure la Casa Bianca abbia cambiato idea e manifesti un tangibile bisogno di Europa. Come del resto la stessa Cina: è il mondo che chiede al vecchio continente di tornare a essere una locomotiva di sviluppo.
D. Alle porte dell’Europa, nella riva Sud del Mediterraneo, si sta propagando una protesta popolare dalle forme e dalle dimensioni inattese. In Tunisia, in Egitto, in Libia sono stati abbattuti o scossi regimi che sembravano indistruttibili. È un vento di democrazia che l’Europa deve sostenere con fiducia oppure c’è il rischio di aprire la strada al fondamentalismo islamico?
R. L’Europa deve stare con il cambiamento. La stabilità non può venire da autocrazie senescenti: dovremmo essercene finalmente convinti! Bisogna che l’Europa metta a disposizione in modo convergente e unitario risorse politiche, diplomatiche ed economiche per accompagnare un’evoluzione pacifica che consegni a quei popoli nuovi diritti politici, sociali e civili: libertà di espressione e di associazione, pluralismo politico, elezioni vere, ruolo e dignità della donna. Quei popoli devono udire una nostra parola chiara e ferma e percepire una disponibilità e una amicizia vera. L’estremismo islamico prospera solo dove può coltivare sentimenti di risentimento e di rivincita verso l’Occidente. Quel che facciamo oggi accompagnando davvero i desideri delle popolazioni potrà pesare domani. C’è anche da augurarsi che l’Europa finalmente comprenda l’esigenza di spostare il suo baricentro verso i grandi problemi e le straordinarie opportunità del Mediterraneo. Questo fin qui non è avvenuto. L’Italia a sua volta avrebbe dovuto e dovrebbe svolgere in questo senso un ruolo primario e di guida. Purtroppo questo rapido e drammatico passaggio storico ci ha sorpresi nel momento di massima debolezza della nostra immagine internazionale, dopo anni nei quali la diplomazia berlusconiana delle «relazioni speciali» ha rotto delicati ed antichi equilibri della nostra politica estera fino a farci perdere ruolo e perfino dignità.
D. Comunque evolva la situazione in Nord Africa, siamo di nuovo davanti a un problema: è possibile o no l’esportazione del modello occidentale di democrazia?
R. L’Occidente identifica storicamente la democrazia con il pluralismo politico espresso attraverso libere elezioni e questa è la richiesta che viene rivolta alle altre civilizzazioni. Tale evoluzione è stata più volte avviata, ma spesso ha subìto rapide smentite e arretramenti. Anche alla luce della nostra storia di europei dovremmo aver compreso che la costruzione della democrazia presuppone un processo più complesso e profondo che, secondo me, ha il suo autentico punto di partenza nel riconoscimento culturale del concetto di libertà religiosa. La democrazia non può germogliare se la libertà religiosa è limitata o coartata. Forse dovremmo assumere questo criterio su scala internazionale come standard ineludibile per un vero radicamento dei principi democratici.
D. Non si può dire che il processo europeo sia fermo. Il rafforzamento del Patto di stabilità, con norme più rigorose per il controllo del debito pubblico, avrà certamente conseguenze rilevanti nelle politiche di bilancio dei singoli Paesi. Da questo punto di vista, dopo l’introduzione dell’euro, non si può negare una progressiva cessione di sovranità da parte dei singoli Stati. Non le pare che il problema resti l’Europa politica che non va di pari passo con quella economica?
R. La moneta è sempre stata conseguenza di uno Stato sovrano. Nell’Unione invece l’euro è arrivato prima dello Stato europeo. Ovviamente c’è una robusta ragione storica: l’euro nasce dopo la caduta del Muro di Berlino per sancire un nuovo patto tra Germania ed Europa. Il via libera all’allargamento a Est fu scambiato con la rinuncia al marco. Il risultato è stato la stabilizzazione monetaria secondo l’impostazione «tedesca»: un beneficio di cui gli europei oggi godono (e, a ben guardare, i tedeschi in modo particolare dal momento che esportano prevalentemente nell’area euro) e che privilegia rigore dei conti e bassa inflazione su ogni altra scelta di politica economica potenzialmente in grado di intaccar...
Indice dei contenuti
- Prologo. Un sogno con le gambe per camminare
- I. La democrazia è libertà e uguaglianza
- II. Quel tanto di anarchico che è in me
- III. Liberare l’Italia dalla gabbia populista
- IV. L’Europa che vogliamo
- V. Un partito nuovo radicato in una lunga storia
- VI. Ambiente e crescita mai più divisi
- VII. La scommessa industriale Made in Italy
- VIII. Gli insegnanti eroi moderni
- IX. La questione morale al tempo delle cricche
- X. Credenti e non credenti per un umanesimo condiviso
- XI. La scienza, la vita e i limiti della politica
- XII. Il partito democratico e la sfida riformista
- Conclusione. Unire le forze della ricostruzione