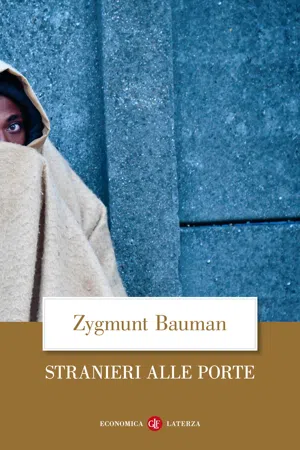
- 110 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Stranieri alle porte
Informazioni su questo libro
Noi siamo un solo pianeta, una sola umanità. Quali che siano gli ostacoli, e quale che sia la loro apparente enormità, la conoscenza reciproca e la fusione di orizzonti rimangono lavia maestra per arrivare alla convivenza pacifica e vantaggiosa per tutti, collaborativa e solidale. Non ci sono alternative praticabili. La 'crisi migratoria' ci rivela l'attuale stato del mondo, il destino che abbiamo in comune.
Abbiamo eletto gli stranieri a causa di tutti i nostri mali. In realtà il nostro senso crescente di precarietà e paura dipende dalla incapacità di governare l'enorme forza dei processi di globalizzazione.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Stranieri alle porte di Zygmunt Bauman, Marco Cupellaro in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Ciencias sociales e Cultura popular. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
1.
Panico da migrazione.
Usi e abusi
Telegiornali, quotidiani, discorsi politici, tweet – avvezzi a offrire temi e sbocchi alle ansie e alle paure pubbliche – non parlano d’altro oggi che della «crisi migratoria» che travolgerebbe l’Europa, preannunciando il collasso e la fine dello stile di vita che conosciamo, conduciamo e amiamo. La crisi è diventata una sorta di nome in codice, politicamente corretto, di questa fase dell’eterna lotta condotta dagli opinion maker per conquistare e soggiogare le menti e i cuori. Le notizie provenienti dal campo di battaglia stanno ormai per scatenare un vero e proprio attacco di «panico morale» (nell’accezione comunemente accettata dell’espressione, definita dall’edizione inglese di Wikipedia come «il timore, diffuso tra moltissime persone, che un qualche male minacci il benessere della società»).
Mentre scrivo queste righe una nuova tragedia – frutto di dura indifferenza e cecità morale – aspetta di colpire. I segnali si moltiplicano: gradualmente ma inesorabilmente la pubblica opinione, complici i media assetati di ascolti, inizia a stancarsi di provare compassione per la tragedia dei profughi. Bambini che annegano, la fretta di erigere muri, il filo spinato, i campi di accoglienza gremiti, i governi che fanno a gara per aggiungere al danno dell’esilio, della salvezza rocambolesca, di un viaggio estenuante e periglioso la beffa di trattare i migranti come patate bollenti: questi abomini morali ormai non sono più una novità, e tanto meno «fanno notizia». Purtroppo il destino dei traumi è di convertirsi nella tediosa routine della normalità, e il destino del panico morale è di consumarsi e sparire dagli occhi e dalle coscienze avvolte nel velo dell’oblio. Chi ricorda più i profughi afghani in cerca d’asilo in Australia che si gettano sul filo spinato a Woomera o vengono relegati nei grandi campi di prigionia creati dal governo australiano a Nauru e sull’isola di Natale «per impedir loro di entrare nelle acque territoriali»? O le decine di esuli sudanesi uccisi dalla polizia nel centro del Cairo «dopo che l’Alto commissariato Onu per i rifugiati li ha privati dei loro diritti»?1
Le migrazioni di massa non sono certo un fenomeno nuovo: hanno accompagnato tutta l’era moderna fin dai suoi albori (pur cambiando spesso direzione, e in qualche caso persino invertendola). In realtà, la produzione di persone «in esubero» (localmente «inutili» – ovvero numericamente in eccesso e inoccupabili – a causa del progresso economico, oppure localmente inaccettabili – ovvero rifiutate – a causa di disordini, conflitti e scontri dovuti alle trasformazioni sociali/politiche e alle lotte di potere che ne derivano) è parte integrante del nostro «stile di vita moderno». E si cumula con le odierne conseguenze della profonda e apparentemente irrisolvibile destabilizzazione della regione mediorientale, seguita agli azzardi politici e militari – malconcepiti, terribilmente miopi e dichiaratamente abortiti – delle potenze occidentali.
Dunque, i fattori che provocano gli attuali movimenti di massa nei luoghi di origine sono di due tipi; ma duplici sono anche le conseguenze nei luoghi d’arrivo e le reazioni dei paesi che li subiscono. Nelle zone «sviluppate» del pianeta – quelle in cui cercano rifugio sia i migranti economici sia i richiedenti asilo – il mondo del business desidera ardentemente e accoglie con favore l’arrivo di manodopera a buon mercato e di capacità che si prospettano redditizie (come ha ben sintetizzato Dominic Casciani, «le imprese britanniche sono ormai molto esperte nel procurarsi lavoratori stranieri a basso costo, e le agenzie di ricerca di personale si danno da fare sul continente europeo per individuare e assumere manodopera straniera»)2; ma per la maggioranza della popolazione, già assillata dalla fragilità della vita e dalla precarietà della posizione sociale presente e futura, quegli stessi fenomeni significano più concorrenza sul mercato del lavoro, più incertezza e meno speranze che le cose migliorino: uno stato d’animo politicamente esplosivo, che costringe i politici a destreggiarsi a fatica tra attese incompatibili al fine di accontentare i propri azionisti di riferimento e sedare le paure degli elettori.
Per come sono le cose in questo momento, e promettono di essere ancora a lungo, è molto improbabile che le migrazioni di massa si arrestino improvvisamente per mancanza di stimoli o perché ci si ingegna sempre più per fermarle. Come ha brillantemente scritto Robert Winder nella prefazione alla seconda edizione della sua storia dell’immigrazione in Gran Bretagna, «per quanto ci affanneremo ad allontanare la sdraio da riva e a inveire contro le onde, la marea non ci ascolterà, le acque non si ritireranno»3. Erigere muri per tenere i migranti a distanza dal nostro «cortile di casa» ricorda comicamente la storia di Diogene, l’antico filosofo che si spostava per le vie della sua città natale, Sinope, facendo rotolare la botte in cui la notte dormiva: e se qualcuno gli chiedeva il perché di questo strano comportamento, rispondeva che mentre i suoi concittadini si preparavano all’arrivo dell’esercito di Alessandro Magno barricando porte e affilando spade, lui pure voleva contribuire alla difesa della città.
Ma quel che è accaduto negli ultimi anni è un enorme aumento del numero dei profughi e richiedenti asilo, e quindi del totale dei migranti che bussano alla porta dell’Europa: aumento dovuto al moltiplicarsi degli Stati «falliti» o in via di fallimento, che in pratica diventano territori senza Stato e senza legge, teatro d’interminabili guerre tribali e settarie, di stragi e delle imprese di banditi che spadroneggiano senza sosta e nel disprezzo di qualsiasi regola. Tutto questo è, in larga misura, il danno collaterale provocato dalle malcalcolate, malaugurate e disastrose spedizioni militari in Afghanistan e in Iraq, che hanno sostituito ai precedenti regimi dittatoriali uno scenario di caos senza fine e un’orgia di violenza spalleggiata e fomentata da un mercato globale delle armi privo di qualsiasi controllo e alimentata da un’industria bellica assetata di profitti, con il sostegno tacito (e a volte persino pubblicamente ostentato con orgoglio nelle fiere internazionali delle armi) di governi disposti a tutto per aumentare il Pil. La marea di profughi, costretti dalla violenza e dall’arbitrio a lasciare le proprie case e tutto ciò cui tengono, e di persone che fuggono dalle deportazioni e dai massacri, si è aggiunta al flusso incessante dei cosiddetti «migranti economici», trainato dal desiderio terribilmente umano di spostarsi da un suolo inaridito a lande dove l’erba è ancora verde, da luoghi impoveriti e senza prospettiva a terre dei sogni traboccanti di opportunità. Su questa corrente interminabile di persone che cercano un’occasione per vivere con dignità (corrente che è sempre esistita, fin dagli albori dell’umanità, e che la moderna industria produttrice di uomini in esubero e vite di scarto ha semplicemente accelerato)4 Paul Collier scrive:
Il primo fatto è che il divario di reddito tra i paesi poveri e quelli ricchi è mostruoso e che il processo di crescita mondiale lo manterrà tale per vari decenni. Il secondo è che la migrazione non potrà ridurre significativamente questo divario perché le sue ricadute sono troppo modeste. Il terzo è che la persistenza dei movimenti migratori favorirà per alcuni decenni la crescita delle diaspore. Pertanto, il divario di reddito è destinato a rimanere tale, mentre aumenterà la spinta a migrare. La conseguenza è che assisteremo all’accelerazione della migrazione dai paesi poveri verso quelli ricchi. Nel prossimo futuro, la migrazione internazionale non raggiungerà il punto di equilibrio: siamo alle prime fasi di uno squilibrio di proporzioni epiche5.
Tra il 1960 e il 2000 (anno oltre cui le stime di Collier non possono andare per mancanza di dati statistici) «la vera impennata si è registrata nella migrazione dai paesi poveri verso quelli ricchi, balzata da meno di venti milioni a più di sessanta. Inoltre, questo aumento ha subìto un’accelerazione da un decennio all’altro. [...] È ragionevole supporre che nel decennio che va dal 2000 al 2010 l’accelerazione sia continuata». Se abbandonata alla propria logica e inerzia, possiamo pensare che la popolazione si distribuirebbe tra paesi poveri e ricchi come il liquido tra vasi comunicanti. Il numero dei migranti sarebbe destinato ad aumentare fino a raggiungere un punto di equilibrio in cui i livelli di benessere tra i settori «sviluppati» e quelli «in via di sviluppo» (?) del pianeta globalizzato si allineano. Per arrivare a un simile risultato molto probabilmente ci vorranno diversi decenni, anche a prescindere dalle svolte impreviste della storia. È dall’inizio della modernità che profughi in fuga dalla bestialità delle guerre e dei dispotismi o dalla ferocia di una vita la cui unica prospettiva è la fame bussano alla porta di altri popoli: e per chi vive dietro quella porta i profughi sono sempre stati (come lo sono oggi) stranieri. Gli stranieri tendono a dare ansia proprio perché «strani» – e dunque spaventosi nella loro imprevedibilità –, a differenza delle persone con cui interagiamo tutti i giorni convinti di sapere che cosa dobbiamo aspettarci da loro; per quel che ne sappiamo, potrebbero essere loro, con la loro massiccia influenza, a distruggere ciò cui teniamo, mutilando o travolgendo lo stile di vita che ci è confortevolmente familiare. Siamo abituati a suddividere tra amici o nemici – i primi bene accetti, gli altri semplicemente tollerati – tutti coloro con cui conviviamo nei nostri quartieri, nelle strade delle nostre città o sul posto di lavoro; ma con queste persone, in qualsiasi categoria le collochiamo, sappiamo bene come comportarci e interagire. Degli stranieri, invece, sappiamo troppo poco per riuscire a interpretarne i gesti e decidere risposte adeguate, comprenderne le intenzioni e indovinare la loro prossima mossa. E non sapere come procedere, come comportarci in una situazione che non siamo stati noi a creare né possiamo controllare, è una delle principali cause di ansia e paura.
Questi problemi, potremmo obiettare, sono universali e atemporali, sono i problemi di qualsiasi epoca in cui ci siano «stranieri tra noi»; e ossessionano allo stesso modo, e con intensità più o meno simile, tutti gli strati della popolazione. Le aree urbane densamente popolate generano inevitabilmente gli impulsi contrastanti della «mixofilia» (ossia l’attrazione per contesti variegati ed eteronimi che promettono esperienze ancora inesplorate, e con esse la gioia dell’avventura e della scoperta) e della «mixofobia» (ovvero la paura di dover affrontare dosi massicce e ingestibili di un ignoto non addomesticabile, repellente e incontrollabile). Il primo impulso è il principale motivo d’attrazione della vita urbana, mentre il secondo è il suo incubo più spaventoso, soprattutto agli occhi dei più sfortunati e sprovveduti, che (a differenza di chi è ricco e privilegiato e può permettersi di far parte di una «comunità recintata» per isolarsi dal caos fragoroso, scomodo, sconcertante e a volte terrificante delle affollate vie cittadine) non hanno modo di uscire dalle infinite trappole e imboscate di cui è costellato un contesto urbano eterogeneo e spesso scostante, diffidente e ostile, e sono condannati a rimanere tutta la vita esposti ai tanti pericoli in agguato. Come ha spiegato Alberto Nardelli nel «Guardian» dell’11 dicembre 2015, «quasi il 40 per cento degli europei indica l’immigrazione come la questione più preoccupante in assoluto tra tutte quelle con cui è alle prese l’Ue: un anno fa lo pensava solo il 25 per cento. E in Gran Bretagna una persona su due cita, tra i principali problemi del paese, l’immigrazione»6.
Eppure, nel nostro mondo sempre più deregolamentato, policentrico e scombussolato, questa costante ambiguità della vita urbana non è l’unica ragione che ci crei disagio e paura alla vista di nuovi venuti senza casa, che ci ispiri inimicizia nei loro confronti, che ci inciti alla violenza verso i migranti – e naturalmente che ci spinga a usare, approfittare e abusare della loro evidente condizione d’indigenza, disgrazia e impotenza. Possiamo individuare altre due spinte nella stessa direzione, innescate dalle peculiari caratteristiche che il nostro modo di vivere e convivere ha assunto a seguito della deregulation: due fattori chiaramente distinti, ciascuno dei quali influenza soprattutto una diversa categoria di persone. Entrambi questi fattori aggravano il risentimento e l’aggressività verso gli immigrati – ma ciascuno di essi lo fa in settori diversi della popolazione autoctona.
Il primo impulso segue, in versione aggiornata, lo schema tracciato nell’antica fiaba di Esopo che ha per protagoniste lepri e ranocchie7. In questa favola le lepri si sentivano a tal punto perseguitate dagli altri animali che non sapevano più cosa fare, e scappavano appena si avvicinava un altro animale. Un giorno videro una mandria di cavalli selvatici al galoppo e, prese dal panico, se la diedero a gambe fino al lago, decise a farla finita: meglio gettarsi in acqua e annegare che vivere nella paura senza fine. Ma appena le lepri si avvicinarono alla riva, un gruppo di ranocchie, allarmate dal loro arrivo, scapparono e saltarono in acqua. Al che una delle lepri commentò: «In fondo le cose non vanno poi così male». Insomma, non si deve per forza scegliere la morte per sfuggire a una vita di paura. La morale della fiaba è semplicissima: la soddisfazione di questa lepre – il gradito sollievo dalla mortificazione delle persecuzioni quotidiane – nasce dalla rivelazione che c’è qualcuno che se la passa peggio di lei.
La nostra società di animali umani è piena di lepri «perseguitate dagli altri animali» che si trovano in una situazione simile a quella delle lepri di Esopo: e negli ultimi decenni il loro numero ha continuato a crescere, in modo apparentemente inarrestabile. Queste lepri vivono nella miseria, nell’umiliazione e nell’ignominia, in una società che, pur potendo vantare agi e opulenza senza precedent...
Indice dei contenuti
- 1. Panico da migrazione. Usi e abusi
- 2. Insicurezza alla deriva in cerca di appigli
- 3. Sulle tracce dell’Uomo (o Donna) forte
- 4. Insieme e accalcati
- 5. Fastidiosi, irritanti, indesiderati: inaccettabili
- 6. Le radici dell’odio: antropologiche o legate al nostro tempo?