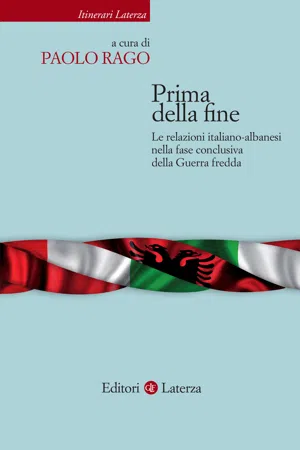
eBook - ePub
Prima della fine
Le relazioni italiano-albanesi nella fase conclusiva della Guerra fredda
- 336 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Affrontando gli anni che intercorrono tra la fine dell'alleanza dell'Albania di Enver Hoxha con la Cina di Mao Tse Tung (1978) e la caduta del muro di Berlino (1989), Prima della fine. Le relazioni italiano-albanesi nella fase conclusiva della Guerra fredda delinea la crescente importanza dell'Italia nei rapporti con l'Albania, assunta anche grazie alla normalizzazione delle relazioni politiche tra i due Paesi, al successivo sviluppo di quelle commerciali, all'avvio di relazioni culturali che contribuirono a dar inizio a una fase di maggiore prossimità tra i governi di Roma e Tirana.Questo libro completa la trilogia di studi storici sulle relazioni tra Italia e Albania durante gli anni della Guerra fredda.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Prima della fine di Paolo Rago in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a History e 21st Century History. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
L’amicizia incompiuta.
Origine, evoluzione ed epilogo
della “seconda primavera” italiano-albanese
di Settimio Stallone
1. Il “terzo scisma”
La nuova dimensione della politica estera di Tirana e i suoi effetti sulle relazioni con l’Italia (1976-1978)
Il regime nazional-comunista albanese aveva sempre scelto il suo principale interlocutore economico facendolo coincidere con la sua collocazione ideologica, affinché fosse anche funzionale a una precisa strategia politica2. Così era stato fino al 1948 con la Jugoslavia, di cui Enver Hoxha si era servito per estendere il suo controllo sul Nord del Paese, quindi con i sovietici, che lo avevano prima protetto da Belgrado, poi aiutato economicamente. Con Mosca il dissidio era stato certamente anche ideologico, ma soprattutto politico, avendo il dittatore compreso nel 1959 – proprio in occasione della storica visita di Nikita Chruščëv in Albania3 – che per l’URSS il valore strategico della RPSSh si era molto ridimensionato4.
L’avvicinamento ai cinesi, che per un decennio – a partire dal 1961 – consentì a Hoxha di far finalmente coincidere l’aspetto ideologico con le direttive politiche dell’azione internazionale dell’Albania, aveva prodotto una straordinaria e molto interessante convergenza in grado di permettere a Pechino di emancipare un dissenso che, all’interno del mondo comunista, era stato fino ad allora esclusivamente asiatico e a Tirana di assumere un ruolo all’interno della comunità mondiale abnorme rispetto alla sue dimensioni geopolitiche. Era logico che con la rappacificazione sino-americana e la successiva normalizzazione dei rapporti fra la RPC e non solo gli Stati Uniti – ma quella parte della struttura istituzionalizzata del sistema internazionale che faceva riferimento a Washington – per un Hoxha disorientato già dalla fine degli anni Sessanta5 l’amicizia con la Cina da utile e – a differenza di quanto accaduto con jugoslavi e sovietici – innocua risorsa diventò del tutto inconciliabile con la necessità di difendere a ogni costo la pretesa ortodossia marxista-leninista su cui era basato il Regime. L’Albania venne progressivamente condotta dalla prima metà degli anni Settanta a un assurdo, autolesionista, isolamento che il leader vide quale unica possibile garanzia per la sopravvivenza prima di tutto del suo potere, quindi della particolarità storica del nazional-comunismo schipetaro6.
La lettera con cui – il 29 luglio 1978, dopo quasi due anni di contrasti e accuse – gli albanesi equipararono la Cina del dopo Mao di Hua Guofeng e, soprattutto, di Deng Xiaoping alla Jugoslavia di Tito e all’URSS di Chruščëv realizzando il “terzo scisma” della loro storia politica internazionale, non colse certo di sorpresa la Farnesina, nonostante che – fra il 1973 e il 1978 – i governi italiani dell’epoca, complice anche l’atteggiamento di chiusura del Regime e differenti priorità della politica estera nazionale, non avessero riservato particolare attenzione all’Albania7. Giovanni Saragat – subentrato nel 1976 alla guida dell’ambasciata italiana a Tirana a Renato Ferrara, la cui sfortunata missione aveva dovuto raccogliere la grande eredità di Roberto Venturini, il quale dal 1969 al 1973 era riuscito a portare le relazioni bilaterali a un livello mai raggiunto prima al punto da poter essere superato solo dieci anni dopo8 – era un diplomatico abile ed esperto, in grado di anticipare quel riposizionamento balcanico e in prospettiva adriatico della politica estera albanese che si sarebbe concretizzato nel tempo come conseguenza della rottura con la RPC, attesa almeno dall’estate del 19779. Era vero che il rifiuto schipetaro verso la teoria cinese “dei tre mondi” – controrivoluzionaria perché basata su di un’opportunistica attesa di una presunta e reciproca futura distruzione del blocco capitalista e di quello comunista sovietico – e la percezione di un tradimento subito dalla Cina avevano provocato un’ulteriore, virulenta, chiusura di un regime che vedeva nemici dappertutto e non sapeva indicare agli oppressi del sistema per giungere a un mutamento degli equilibri internazionali altro che un indefinito volontarismo. Ma, passata la tempesta, si sarebbe aperta una nuova e produttiva fase basata su di una politica di “buon vicinato” con i Paesi limitrofi che Hoxha aveva già impostato nel novembre del 1976 in occasione del VII Congresso del PPSh.
La necessità di sostituire l’assistenza e le forniture, che i cinesi avevano definitivamente interrotto con la nota significativamente consegnata all’ambasciata albanese a Pechino proprio il 7 luglio 197810, aveva da tempo portato a un rafforzamento dei rapporti economici fra l’Albania e la Jugoslavia, le cui prospettive apparivano in quell’anno molto buone, anche in seguito a quanto approvato nella risoluzione finale – il 23 giugno – dell’XI congresso della Lega dei Comunisti della Jugoslavia (SKJ) in cui era stato ribadito il pieno rispetto da parte jugoslava dell’indipendenza albanese. La possibilità che fra Tirana e Belgrado si sviluppasse una stagione di positive relazioni non poteva certo dispiacere Roma, da sempre sostenitrice di una pacificazione della penisola balcanica ma, al tempo stesso, ne riduceva sia i margini d’azione che prospetticamente l’importanza per la leadership albanese11. Alla Farnesina – dove si passò quelle settimane a rassicurare gli alleati, incuriositi ma anche spaventati, che un ravvicinamento fra la RPSSh e l’URSS era da escludersi, almeno nel breve-medio periodo12 – si valutò come opportuna una strategia che, pur astenendosi da manifestazioni pressanti che avrebbero potuto provocare effetti controproducenti sugli albanesi, doveva prevedere una collaborazione pragmatica fra tutti i soggetti interessati – Grecia, Turchia e, logicamente, anche Jugoslavia. L’obbiettivo era di far sì che l’Italia potesse associarsi a un modello in divenire di cooperazione interbalcanica, non caratterizzato ideologicamente e diverso da quello proposto da tempo da Pechino a Tirana13, atto a stabilizzare definitivamente la regione. A Roma sarebbe spettata una funzione di promozione e di moderazione naturalmente derivata dal suo essere la principale fra le potenze contigue ai Balcani.
L’Italia era in ritardo, avendo sofferto maggiormente, rispetto agli altri Paesi cosiddetti vicini, la svolta isolazionista impressa da Hoxha alla politica estera albanese dal 1974. Al di là delle positive aperture espresse dal dittatore nel corso del VII congresso14, Roma si trovava in una posizione politicamente marginale rispetto a greci e turchi, mentre economicamente stava pagando l’inevitabile rafforzamento dei rapporti commerciali fra Belgrado e Tirana, quest’ultima assillata già dalla metà degli anni Settanta dal bisogno di una pronta espansione delle sue esportazioni al fine di affrancarsi dalla tutela cinese15. Ma, in quei mesi, nelle dichiarazioni ufficiali del Regime e nei tanti editoriali che «Zëri i Popullit» dedicò alla fine dell’amicizia con Pechino, gli osservatori più accorti lessero un’apertura che nascondeva una richiesta di aiuto: salvando le apparenze, basandosi su rapporti interstatuali paritari, la RPSSh era pronta a sviluppare una nuova stagione della sua politica estera, in cui al rapporto preferenziale con la Cina sarebbero state preferite intese bilaterali prive di qualsiasi allineamento ideologico16.
Assente nei giorni in cui prima i cinesi poi gli albanesi avevano denunciato gli accordi esistenti fra i due Paesi17, Saragat si apprestava proprio in quell’estate del 1978 a lasciare l’Albania. L’ambasciatore, pur non avendo ricevuto alcun invito a operare per un rafforzamento della cooperazione bilaterale dal ministro degli Esteri Nesti Nase né dal suo vice Ksenofon Nushi18, percepì tuttavia una benevolenza nell’atteggiamento della controparte albanese che si era raramente così esplicitamente manifestata negli anni della sua missione. Lo stesso nuovo ambasciatore italiano, Gian Paolo Tozzoli19 – che presentò le credenziali il 29 settembre – restò positivamente stupito dall’affabilità con cui venne accolto a Tirana, in un clima finalmente prospetticamente produttivo per le relazioni fra i due Paesi che aveva beneficiato anche della recente elezione alla presidenza della Repubblica di Sandro Pertini, di cui gli albanesi stimavano la personalità di antifascista20. Il Regime, sia pure progressivamente, fece intendere a Roma che «sarebbe stato un grave errore» se l’Italia non avesse compreso l’esigenza di Tirana a stabilire dei solidi rapporti, prima di tutto economici e commerciali: la RPSSh non riteneva più in alcun modo la Repubblica Italiana – «nazione prospera, avanzata, forte e democratica», come ebbe a esprimersi forse travolto dall’entusiasmo per la nouvelle vague post-cinese della politica estera albanese l’ambasciatore a Roma Kujtim Myzyri – una minaccia, bensì un’opportunità per il suo futuro21.
D’altra parte il realismo, di cui parlò Hoxha nel lungo discorso con cui – il 20 settembre 197822 – “spiegò” al suo popolo quella che sarebbe stata la politica estera albanese dopo la rottura con la Cina, si articolava in un’opportunistica dissociazione fra l’ambito strettamente politico-ideologico e quello fattua...
Indice dei contenuti
- Prefazione
- Introduzione
- L’amicizia incompiuta. Origine, evoluzione ed epilogo della “seconda primavera” italiano-albanese
- L’economia albanese e i rapporti con l’Italia dal secondo dopoguerra alla fine degli anni Ottanta del Novecento
- La «costante staliniana». La diplomazia italiana e la persecuzione religiosa in Albania dalla Costituzione del 1976 fino agli anni Ottanta
- Il trattamento subito dai cittadini italiani presenti in Albania al termine della seconda guerra mondiale
- Una storia infinita.La questione dell’oro della Banca Nazionale d’Albania nelle fasi Quasi-Final e Final (1957-1998)
- Il contributo dell’Italia all’apertura dell’Albania comunista nella seconda metà degli anni Ottanta del Ventesimo secolo
- Studenti universitari e post-universitari dell’Albania comunista in Italia durante l’ultimo periodo della Guerra fredda (1978-1990)
- Abbreviazioni e sigle
- Gli autori