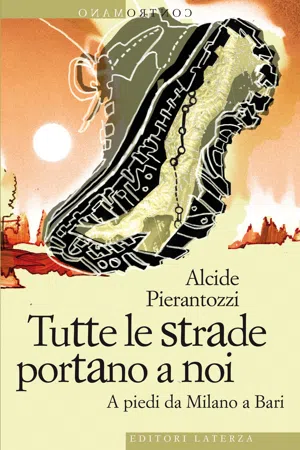Il guado di Sigerico
Durante il camminamento del giorno dopo verso il Po cresce una certa tensione fra Elena e il resto del gruppo. Per raggiungere la banchina del fiume – dove due addetti al traghettamento ci aspettano contando le banconote nei rispettivi portafogli – si passa su una strada qualunque, cinta di campi qualunque.
È quasi impossibile che un libro di viaggio come questo non ricorra all’espediente di immortalare i protagonisti fermi ai posti della partenza mentre guardano, ebbene sì, la radura soleggiata davanti a loro. Questo a patto che qualcuno di loro non abbia trascorso la notte nella cabina di un ascensore, ovvio, ma si suppone che se il tuo viaggio è spirituale poi non ti lamenti delle penitenze divine. Ecco, nel caso di Elena la devozione nell’Onnipotente – molto sentita – è stata inutile, avendo preferito farsela a piedi da sola, con uno stacco di cinquecento metri dal resto del gruppo. Niente cheeese davanti all’obiettivo: Elena, di cui ci è toccato subire il nervosismo, è stata la prima fra noi a mettere in dubbio l’influsso degli dèi o tutt’al più del destino sul nostro viaggio.
E cosa credete, che tutti quelli rimasti chiusi in un ascensore reagiscono allo stesso modo? Bene. Perché non fate un po’ d’attenzione all’aneddoto che sto per raccontarvi? Anzi, è una storia zen, una parabola, qualcosa del genere. Tra parentesi, è successa davvero.
Emanuele Severino, il filosofo che ha fatto di Heidegger uno studente di quarta ginnasio, l’uomo che ha varcato le porte della morte ed è tornato indenne su questa valle di lacrime, ne è il protagonista. Severino. Se qualcuno è convinto di averlo capito davvero, parli ora o taccia per sempre. Di lui si è occupato Gadamer, il filosofo tedesco. E il Vaticano, nella persona di padre Cornelio Fabro, che negli anni ’70 ha avuto l’incarico di inquisire i suoi libri. Durante l’incontro hanno parlato per lo più di Aristotele, come si fa tra veri studiosi di filosofia. Alla fine monsignor Nicoletti, un altro dei giudici presenti, capisce tutto, e sulle ali dell’entusiasmo rinuncia all’abito talare.
Premessa obbligatoria è fare un cenno sulla vita quotidiana del professore – come forse sapete, Severino insegna all’Università San Raffaele. Ormai è piuttosto anziano: a ottantasei anni parlare di «verità assoluta e definitiva» a umanisti troppo giovani per sapere che se non spegni il cellulare davanti a uno così, plausibilmente non lo spegnerai mai, dev’essere parecchio seccante. Ma niente da fare, anche una bomba davanti ai cancelli dell’università sarebbe inutile (bomba significa perfino Berlusconi tratto in salvo nel pronto soccorso dell’istituto dopo aver ricevuto in faccia una statuetta del Duomo, e cento giornalisti entusiasti di ingigantire un taglietto sul labbro). Severino, infischiandosene del pensionamento, non cede a legge umana e presiede un corso di filosofia teoretica ormai ridotto ai minimi termini. Tocca al dottor Cornaredo, un ragazzo con la propulsione alle giacche di pelle, accompagnarlo in macchina da Brescia a Milano. Se proprio dobbiamo dirla tutta, il dottor Cornaredo lo accompagna premurosamente fino all’aula, seguendolo passo dopo passo. Beh, a me fa schifo ironizzare sul mio maestro, ma l’aneddoto è imperdibile. In pratica un giorno che il professore, forse più in forze del solito, ha preso l’ascensore da solo, e nessuno lo ha visto raggiungere il secondo piano per i successivi centoventi minuti, tutti hanno maturato il sospetto che se la fosse squagliata, o che fosse morto, nel caso in cui avesse trascorso tutto quel tempo chiuso nell’ascensore. Centoventi minuti. Chi non ci crede, chieda al mio amico Raphael Ebgi (era presente anche lui, e da quando ha curato per “I Millenni Einaudi” un volume su Pico della Mirandola è molto più credibile di me). Centoventi minuti. Ottantasei anni. Dimenticavo: mese di luglio. Tuttavia, quando due guardie giurate e un elettricista accorsi sul posto riescono a sbloccare l’ascensore – me testimone –, l’uomo che emerge dall’interno sfodera un sorriso interrogativo: «E adesso, per favore, volete dirmi perché vi eravate chiusi fuori?».
Tralasciando Elena e le sue scaramucce, i miei pensieri del primo giorno vanno in un’unica direzione: che diavolo ci faccio qui? Guardi i prati, dove qualche vecchio raschia le erbacce attorno ai fili di grano, e ti dici che a casa tua giù in Abruzzo tuo nonno, tuo zio e affini stanno sarchiando terreni simili a questi: ma ben più rigogliosi. Non so se Elena la pensa come me, e se ad Arzignano (provincia di Vicenza, da dove viene) esistano solo le concerie di pellami o anche i fiori, l’erba e l’aria. Ora, in base alla sua reazione, è lei per prima che improvvisamente mette in discussione la propria origine contadina.
Dopo un’ora di cammino, è norma ufficiale, ci concediamo cinque minuti di riposo. Il che si traduce in una sigaretta prima di tutto. Ebbene, Elena ha giusto il tempo di tirare una boccata e subito le è tornato il buonumore. Ma non perché sta fumando, ha visto un coniglietto. «Laggiùùùùùùùùùùù», urla fracassandomi un timpano.
Danilo Parisi è il nocchiero della Francigena. Ma si rivelerà più bravo come apostolo dell’arcivescovo di Canterbury che non come Caronte. È un omone con il cappellino di maglia sempre calato sulla fronte, e con una predisposizione naturale ad ammettere di essere il migliore, eh già, in ogni campo.
Da tradizione, vi scorterà con uno scafo a motore a Sopravivo, dall’altra parte del Po, e su per una montagnola (questo a piedi). Nascosta nell’ombra dei lauri c’è casa sua, la Caupona Sigerico – una sosta alla quale il buon Danilo tiene molto. Se gliene si offre l’occasione, del suo habitat può raccontare ogni dettaglio: ha quattro stanze al pianterreno, ha cinque stanze di sopra. Un bagno nuovo di pacca dabbasso. Se ho ben capito la casa è annessa a un circolo sportivo con il quale organizza merende sul fiume – a pagamento. Parla anche di opere d’arte. Una scultura di Mario Branca, un poco verosimile nudo di Guttuso e cartoline d’epoca. «E non dite a nessuno che in casa possiedo un frammento autentico della croce», ci avverte, «altrimenti mi daranno l’assillo i giornalisti. Rumiz, soprattutto».
«Quale croce?».
«Di Cristo».
Danilo pare convinto che il sindaco di Orio Litta cospiri contro di lui. Per essere ancora più precisi, gran parte dei cittadini minacciano di togliergli l’incarico di portare i pellegrini di là del fiume. Concentra le sue paranoie su Rumiz perché «lui ne sa una più del diavolo»: quale altra spiegazione dareste del fatto che nel suo reportage In viaggio sul Po, o forse da un’altra parte, abbia scritto che Parisi dice di avere allestito un museo di opere d’arte, ma che nessuno l’ha visto mai?
«Tu non li conosci i giornalisti. Gente che mette i brividi. Tipi molto falsi», sibila sputando per terra.
«Anch’io sto facendo una mezza specie di reportage», ribatto. Vado a sedermi su una sdraio vicino a un tavolo di legno massello, con l’intenzione di vedere meglio il quaderno rilegato che c’è sopra. È enorme. E lo credo, è la lista dei nomi di tutti i pellegrini che negli ultimi venticinque anni sono passati da qui. Anche Herzog e Olmi vi hanno annotato le loro impressioni.
«Posso dare un’occhiata?».
Da parte sua, un no con la testa.
«Perché?».
«Beh, sei un giornalista anche tu, vero? Come hai detto che ti chiami?».
«Alcide Pierantozzi».
«Bella fantasia», è stata la risposta. Rimango perplesso, tardo a replicare qualcosa. Comincio a mostrare segni di scompenso cardiaco: «È il mio nome, ti ho appena dato il documento. È dentro il libretto delle credenziali».
«Non l’ho ancora visto», dice, squadrando con scetticismo i miei pantaloni a righe bianche e marroni. «E sai perché?».
«Sentiamo».
«Perché non vi farò alcun timbro».
«Oh, oh», prorompe Elena. «E perciò noi non pagheremo la tratta?».
E lui: «Tanto l’ho già capito che non pagherete, stronzi».
È un finale che vi piacerebbe, quello di noi quattro con gli zaini in spalla e il documento delle credenziali in mano, che ci allontaniamo come ladri, fischiettando, senza avere sborsato un centesimo. Perché insomma, alla tappa successiva – Piacenza città – ci aspettano sindaco, consiglieri e (stavolta sì) giornalisti. L’impedimento del timbro non ci cambierebbe proprio nulla.
La verità vera è che il mondo pullula di rompicoglioni. Se non ci fossero i rompicoglioni, nessuna istituzione sarebbe possibile. In famiglia come sul luogo di lavoro, sono i rompicoglioni ad essere considerati indispensabili. Così tutti gli insegnanti di scuola degni dell’epiteto anzidetto, sempre estranei alle tentazioni e avendo in orrore che leggi e comandamenti non vengano osservati, incitano i loro studenti a fracassare le pudenda altrui. E a quanto pare godono della loro stima.
È per via dei rompicoglioni se a un certo punto i ragazzi si iscrivono all’università. Durante l’adolescenza hanno servito a qualche tavolo nel weekend, incorrendo nella signora cui è capitata la tazzina sporca. Alla fine si sono messi a studiare di più, e hanno letto un paio di romanzi la settimana. Questo ha consentito all’industria libraia di crescere. Quanto all’industria cinematografica, vale lo stesso presupposto.
Così i rompicoglioni hanno acquistato di giorno in giorno sempre più autorevolezza presso i reparti marketing di molte aziende. Alcuni tra gli studiosi di economia politica fanno derivare il sistema di sviluppo del capitalismo dall’intervento dei rompicoglioni. Non è solo questione di denaro in termini di largo mercato; dalla presenza di un rompicoglioni scaturisce la necessità istintuale di mettere a tacere l’interlocutore. E il modo migliore per farlo non è ricorrere al portafogli?
Infatti: «Su su. Tornate indietro che vi faccio ’sto timbro». Mister Parisi, sputando un’altra volta per terra, ci richiama all’ordine. Anche se fino a un secondo fa sono volate parole grosse.
«Cinquanta euri», vocia.
In altri termini, riesce a spillarci il...