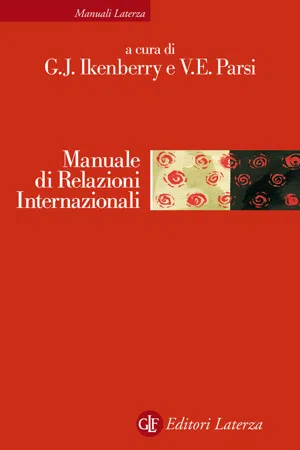
eBook - ePub
Manuale di Relazioni Internazionali
Dal sistema bipolare all'età globale
- 336 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Manuale di Relazioni Internazionali
Dal sistema bipolare all'età globale
Informazioni su questo libro
Come sono cambiate le relazioni internazionali con la fine del bipolarismo? Che cos'è la globalizzazione? Quali nuovi attori affiancano gli Stati nell'arena della politica internazionale? Come confrontarsi con problemi globali come l'inquinamento e il narcotraffico, la pace e la guerra? L'evoluzione della politica internazionale pone interrogativi e problemi sempre più stringenti, la cui comprensione appare ormai irrinunciabile per un numero crescente di persone. Diretto al pubblico degli studenti e di chiunque desideri essere informato, il volume, aggiornato agli ultimi avvenimenti, è frutto della collaborazione di prestigiosi studiosi italiani e americani.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Manuale di Relazioni Internazionali di Vittorio Emanuele Parsi,G. John Ikenberry, Andrea Locatelli, Anna Veronelli, Andrea Locatelli,Anna Veronelli in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Politica e relazioni internazionali e Relazioni internazionali. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
Politica e relazioni internazionaliCategoria
Relazioni internazionaliCapitolo 1. Il mondo degli Stati
di John A. Hall
Parlare del mondo degli Stati significa naturalmente riferirsi al sistema delle relazioni internazionali che si è sviluppato nella storia europea. A prima vista, concentrarsi su di un singolo tipo di ordine internazionale [vedi Box 2, L’ordine internazionale] potrebbe sembrare un grossolano esempio di eurocentrismo. Perché non dedicare altrettanta attenzione, per esempio, alle civilizzazioni imperiali che hanno contrassegnato gran parte della storia della Cina e dell’Islam? Anche se lo studio della stabilità di quei sistemi ha molto da insegnare ai cultori delle Relazioni Internazionali, un giudizio ponderato suggerisce di riservare un’attenzione particolare alla logica di un sistema multipolare, come quello sviluppatosi in Europa: detto in modo rude, il sistema creato in Europa è arrivato a dominare il mondo. Il mondo è privo di un governo e gli Stati devono calcolare come meglio costruire il proprio sistema di sicurezza: è questa la formulazione propria del realismo, il corrispettivo intellettuale del multipolarismo. Esso costituisce il cuore della disciplina delle Relazioni Internazionali – sia quando le sue tesi fondamentali sono messe in discussione o rifiutate, sia quando sono condivise. È importante evidenziare sin d’ora che questa teoria elegante e parsimoniosa propone tanto una visione della pace (o, piuttosto, delle limitazioni del conflitto) quanto una visione della guerra [vedi cap. 9 e cap. 8]. Tutti i realisti credono che nelle questioni geopolitiche il modo migliore per realizzare la limitazione sia attraverso l’equilibrio tra uno Stato con pretese egemoniche e una coalizione, a esso contrapposta, di piccole potenze.
Occorre anche sottolineare immediatamente che l’esatta natura del realismo è stata oggetto di dibattito. Da un lato, è stato contestato lo status ontologico della teoria: alcuni ritengono che la teoria sia, per così dire, neutra e asettica, vale a dire un resoconto descrittivo di un meccanismo sociale naturale; altri, invece, vedono la teoria come normativa e sostengono che in generale l’adozione di politiche statali che favoriscono l’interesse nazionale conduce con maggiore probabilità a un equilibrio stabile negli affari internazionali. Questo gruppo di pensatori ritiene che le crociate morali – cioè i tentativi di liberare il mondo dal conflitto internazionale cercando di stabilire un qualche nuovo ordine sociale – sono sia pericolose sia autodistruttive. Dall’altro lato, è possibile distinguere prospettive abbastanza differenti all’interno del realismo: per dirla in altre parole, quelli che si autodefiniscono realisti non concordano circa i meccanismi cruciali di quello che appare al massimo come un paradigma vagamente condiviso. Doyle (1997) distingue almeno tre scuole all’interno del realismo, sebbene osservi che le tracce di tutte e tre le posizioni possano essere rinvenute in Tucidide, il primo e ancora il più grande teorico delle questioni internazionali. I fondamentalisti come Machiavelli – e ai giorni nostri Henry Kissinger – danno molta importanza alle capacità dei leader politici e affermano che la presenza o l’assenza di abilità sono le variabili chiave necessarie per spiegare i modelli di guerra e pace registrati dalla storia.
Gli strutturalisti optano per una posizione più neutra, nella quale il comportamento degli Stati deriva direttamente dai modelli di potere presenti nell’arena internazionale. Questa posizione fu accennata per la prima volta con eleganza e concisione da Thomas Hobbes, mentre negli anni più recenti la sua logica è stata elaborata compiutamente da Kenneth Waltz.
I costituzionalisti ritengono che sia la natura della società interna a determinare l’incidenza di guerra e pace. Doyle suggerisce, vale la pena sottolinearlo, che quest’ultima prospettiva è espressa con la massima chiarezza da Rousseau. Questo punto pone alcuni problemi: innanzitutto, come si vedrà, l’uso della parola costituzione è fuorviante, dal momento che il termine evoca quasi inevitabilmente le pratiche del liberalismo. In secondo luogo, l’enfasi su Rousseau non è del tutto felice poiché il famoso cittadino di Ginevra era più interessato a creare un mondo che si liberasse dalla modernità che non a trovare i mezzi per viverci. In terzo luogo, Doyle cade in un sottile errore quando suggerisce che Raymond Aron (1962) e Hedley Bull (1977) sono i moderni rappresentanti del ‘costituzionalismo’: si tratta di due pensatori estremamente autorevoli che hanno dato un contributo senz’altro interessante all’analisi delle relazioni interne, ma entrambi hanno sostenuto in modo ancora più esplicito, come vedremo, che la natura della società internazionale – con la quale intendevano, lo si noti immediatamente, qualcosa di più di accordi ‘costituzionali’, per quanto li ritenessero importanti – contribuisse in modo determinante a spiegare le questioni internazionali.
L’analisi del mondo degli Stati tra il 1648 e il 1945 contenuta in questo capitolo chiama in causa necessariamente la differenza tra ‘strutturalisti’ e ‘costituzionalisti’, quantunque affronti queste posizioni con un problema empirico in mente e comunque li caratterizzi – come si è già notato – in termini leggermente differenti. La riflessione che dev’essere fatta equivale a dire che il realismo ‘costituzionale’ ha maggiori meriti del suo rivale ‘strutturalista’. I realisti ‘fondamentalisti’ non sono presi in considerazione direttamente, ma all’inizio del paragrafo finale verrà proposta una nota sul rapporto della loro posizione con il caso qui discusso.
1. Il problema
La caratteristica più ovvia del sistema europeo è la prevalenza della guerra. Gli Stati erano spesso in guerra; anche nei periodi ‘di pace’ la necessità di non essere colti di sorpresa imponeva di continuare a prepararsi senza soste a una simile eventualità. Di più: gli Stati erano macchine per combattere guerre; solo alla fine del XIX secolo la spesa sociale superò per la prima volta i costi delle attività militari. Va sottolineato che questo quadro non era, per così dire, statico: al contrario, varie rivoluzioni nelle questioni militari, dalla dimensione delle armi al costo dei fucili, obbligavano continuamente gli Stati, che temevano lo smembramento – destino ovviamente comune a molti di loro – a estrarre dalla società risorse sempre maggiori. Perché la capacità fiscale dello Stato rifletteva i vantaggi sociali competitivi e questi dovevano essere emulati. In questo spirito la Carta Mercatoria inglese del 1297 offrì vari incentivi ai mercanti per attrarli verso il regno. Più tardi, la consapevolezza delle capacità degli Stati confinanti indusse pensatori francesi del XVIII secolo del calibro di Voltaire e Montesquieu a trascorrere lunghi periodi di soggiorno in Inghilterra, nella speranza di scoprire il segreto della prosperità di quel paese – e il suo conseguente valore in guerra. Ugualmente, la scoperta che i cittadini-soldati combattevano meglio dei mercenari rese necessaria una transizione dagli Stati dinastici agli Stati-nazione, com’è particolarmente evidente nel caso della Prussia che abolì il feudalesimo, bastione del vecchio regime, nel giro di pochi mesi dalla sconfitta subita per mano di Napoleone ad Austerlitz, nel 1805. Anche il maggior impulso verso l’industrializzazione nell’Europa del XIX secolo venne, non a caso, dal bisogno di competere nell’arena geopolitica. Questa considerazione spiega il fatto che ogni Stato cercasse di avere esattamente la medesima dotazione industriale – soprattutto per quanto riguarda le industrie per la produzione di acciaio e ferro – in modo da essere autonomo nella produzione delle armi.
Tutto quello che si è fin qui detto può essere sintetizzato in due semplici formule. Il miglior riassunto dei punti illustrati è la sottolineatura del fatto che l’incessante emulazione competitiva implicava un perenne cambiamento sociale e una continua tensione sociale. Il medesimo concetto è illustrato dalla formula più elegante utilizzata da Trotzkij, secondo il quale la guerra non è altro che la locomotiva della storia europea.
Sarebbe un grave errore accontentarsi di queste osservazioni iniziali quali descrizione corretta e completa del sistema europeo. Ci sono stati, infatti, gradi di intensità ben distinti nei livelli di violenza che hanno contraddistinto la storia europea. La Guerra dei trent’anni che terminò nel 1648 con i Trattati di Osnabrück e Münster – dal momento che protestanti e cattolici stipularono accordi separati, conosciuti genericamente più tardi con il nome di ‘sistema westfaliano’ – fu eccezionalmente brutale. Potenze esterne furono spinte dentro il vortice del conflitto poiché le poste in gioco – la possibile estirpazione del protestantesimo e il tentativo della Spagna di raggiungere l’egemonia continentale – erano davvero molto grandi. Di conseguenza la violenza fu smisurata. Gli orrori della guerra nell’Europa centrale causarono la perdita di almeno un terzo della popolazione; ancora oggi le rappresentazioni artistiche e letterarie di quei disastri conservano la capacità di sconvolgere. In netto contrasto, durante il Settecento si assistette all’imposizione e al mantenimento di veri e propri vincoli nella condotta degli scontri: i conflitti furono frequenti, ma la loro intensità e durata furono limitate, tanto da rendere appropriata la definizione di ‘guerra dei minuetti’. Una figura tipica di questo periodo è quella di Federico il Grande, conosciuto per la sua determinazione nell’evitare qualsiasi morte non necessaria tra le schiere dei suoi amati granatieri. Un’altra esperienza tipica è quella che capitò a David Hume, il grande filosofo dell’empirismo, che venne arruolato nelle fila dell’esercito inglese: all’arrivo in una città fortificata si decise di non combattere perché le perdite umane sarebbero state troppo alte, per scoprire più tardi che i capi della città, ugualmente timorosi di perdere uomini, avrebbero comunque dichiarato la resa la mattina successiva. Il problema empirico che affronteremo in questo capitolo è perché debba verificarsi una variazione del genere, un movimento simile tra l’ascesa agli estremi e la moderazione.
Questo punto può essere illustrato in due modi. Innanzitutto, si può partire considerando il fondamentale cambiamento avvenuto nel pensiero di Carl von Clausewitz, il più grande teorico della guerra. La sua precoce esperienza della sconfitta per mano di Napoleone lo convinse, com’è ben noto, dell’inevitabilità dell’ascesa agli estremi. Clausewitz capì che la violenza nella sua forma più pura poteva non avere limiti. Dal momento che la guerra era un duello, era sensato utilizzare ogni risorsa contro i nemici – fare loro quello che stavano sicuramente progettando di fare a te. Questo punto di vista lo indusse ad adulare Napoleone, il dio moderno della guerra. Questa formulazione iniziale è un esempio di quello che può essere definito realismo duro e ingenuo: l’essenza del comportamento dello Stato è la ricerca del potere senza limite. In altri termini, all’avvio delle sue riflessioni Clausewitz cercò di spiegare nel dettaglio la logica inevitabile del realismo ‘strutturalista’. Non si finirà mai di sottolineare abbastanza che questo studioso arrivò a rigettare la formulazione iniziale nell’ultima revisione di Della guerra (1832-1835) – in modo particolarmente chiaro nel primo libro del suo capolavoro: aveva vissuto abbastanza a lungo da essere testimone della fine delle ambizioni di Napoleone e di conseguenza iniziò a rivalutare la carriera di Federico il Grande. Arrivò a perdere fiducia nell’illimitata aspirazione al potere: minacciare chiunque significava certamente agevolare la formazione di contro-allenze, il che rendeva la strategia di Federico, basata su richieste limitate e incrementali, più razionale rispetto all’alternativa più estrema di Napoleone. La natura di quello che può essere definito ‘realismo sofisticato’ può essere colta nitidamente nella definizione trinitaria finale di guerra proposta da Clausewitz: se la guerra dev’essere razionale è necessario il controllo da parte dello Stato dell’apparato militare e delle passioni popolari.
Ma il contrasto tra l’escalation e la moderazione in politica internazionale può essere visto all’opera altrettanto bene, in secondo luogo, nella condotta della Germania alla fine del XIX secolo e all’inizio del XX. Un elemento assolutamente fondamentale di qualsiasi calcolo realista dev’essere quello di evitare la guerra su due fronti, dal momento che dividere le forze conduce con ogni probabilità alla sconfitta. Bismarck comprese questo principio e si preoccupò di prevenire la formazione di un’alleanza tra Francia e Russia. Ma il realismo sofisticato del «cancelliere di ferro» venne rimpiazzato da un realismo alternativo, aggressivo e a somma zero [vedi Box 7, La teoria dei giochi]. La conseguenza fu, naturalmente, disastrosa: la minaccia proveniente dalla Germania guglielmina garantì non solo l’alleanza formale tra Francia e Russia, ma anche un eventuale coinvolgimento dell’Inghilterra. Più avanti si tornerà su questo punto e sul fatto assolutamente rimarchevole – davvero centrale per la storia del XX secolo – che la Germania commise lo stesso errore geopolitico due volte nella stessa metà del secolo.
Questo ci porta necessariamente al cuore del realismo. La questione teorica, in questo caso, è semplice: il realismo ammette e certo si aspetta il conflitto. Piccoli errori sono sempre possibili: è spesso molto difficile entrare in possesso, per esempio, di buone informazioni circa le forze del proprio avversario, e ancora più duro è dare una risposta a tutte le questioni che hanno a che vedere con la morale. Entrare in guerra può essere dunque il risultato di un sincero errore di calcolo. Ma c’è una grande differenza tra un mondo di guerre premeditate e che possono essere interrotte quando si rivelano disastrose, e gravi incontrollate ascese agli estremi. Il comportamento tenuto dalla Germania – iniziare guerre su due fronti in due occasioni consecutive e ravvicinate – dovrebbe porre sicuramente qualche problema ai sostenitori del realismo. Se si suppone che gli Stati seguano la logica dell’equilibrio di potenza, in modo cioè da mantenere un equilibrio sempre mutevole, questo suggerisce continue piccole manovre più che ampie escursioni tra equilibrio ed escalation, come quelle che abbiamo osservato. Detto altrimenti, alcune volte l’equilibrio fu realizzato, altre volte fu del tutto assente. Questo capitolo offre una spiegazione, di carattere sociologico, dell’ascesa agli estremi e permette, al contempo, di stabilire quali siano le condizioni sociali che hanno consentito al realismo di operare efficacemente in circostanze più normali.
2. Il modello
Il modello di escalation ed equilibrio che dev’essere tenuto a mente è relativamente semplice. Come è stato osservato, agli orrori della Guerra dei trent’anni seguì la relativa stabilità della politica dell’equilibrio di potenza, che caratterizzò il XVIII secolo in Europa. Ma questo periodo fu seguito, come è noto, dalla rapida ascesa agli estremi sperimentata da Clausewitz, in particolare con le guerre rivoluzionarie e napoleoniche. La combinazione di nuovi principi sociali e di nuovi strumenti bellici comportò la lacerazione dell’Europa: le spese militari si impennarono e i bilanci pubblici degli Stati leader, secondo una stima, giunsero a controllare completamente il 40% del prodotto interno lordo – quattro volte tanto la cifra del secolo precedente, un livello mai più raggiunto fino alla prima guerra mondiale (Mann, 1993). Sorprende poco, allora, che gli statisti del XIX secolo abbiano cercato di evitare il ripetersi di un simile disastro. Vi riuscirono, con alterne fortune, per quasi un secolo – tanto che la fede nel progresso, durante l’Ottocento, sembrò giustificata razionalmente. Tra gli indiscutibili risultati di questa epoca occorre annoverare gli accordi che condussero alla nascita del Belgio e quelli che permisero la navigazione del Danubio, anche se il fatto sicuramente più importante fu che le guerre sulla scena europea furono relativamente contenute e di breve durata. La fiducia nel progresso umano fu, ovviamente, distrutta dalla più grande di tutte le escalations della storia europea, vale a dire dai conflitti che iniziarono nel 1914 e terminarono nel 1945. Questo prolungato conflitto provocò moltissime vittime e regalò al XX secolo due regimi rivoluzionari, entrambi davvero efficienti nell’uccidere esseri umani, oltre tutto a cominciare dai propri cittadini. È importante ricordare che il dark continent della modernità (per parafrasare Conrad) è stato proprio l’Europa, luogo d’origine della pulizia etnica, fenomeno tornato tristemente in auge negli ultimi anni.
Questo modello può essere spiegato alla luce di due fattori: l’ideologia e la natura dello Stato. Ciascun fattore, a sua volta, verrà analizzato attraverso esempi, per così dire, negativi e positivi dei loro meccanismi, ricavati da quelle escalations e quegli equilibri dei quali si è appena discusso.
Il primo fattore è chiaro: è molto più semplice calcolare le intenzioni degli altri quando si pensa di sapere in che modo ragionano. Hedley Bull (1977) lo ha compreso bene quando ha affermato che tra Stati in competizione tra loro può esservi o genuina anarchia o una forma di socialità imperfetta. Il punto analitico in questione è stato sicuramente illustrato meglio da Raymond Aron (1962) nei termini del livello di eterogeneità o di omogeneità interno al sistema degli Stati [vedi cap. 2].
Soffermiamoci con maggiore attenzione su questi concetti. Le fonti dell’omogeneità possono variare: fu relativamente facile per l’Inghilterra e gli Stati Uniti cooperare all’inizio del XIX secolo poiché entrambi i paesi condividevano non solo la lingua, ma anche un ampio bagaglio di assunti culturali anglosassoni dati per scontati. Norme estensive possono essere anche quelle legate alla religione, come accadde per la cristianità: i paesi appartenenti a questo credo si diedero regole di comportamento per i propri membri diverse da quelle vigenti nei paesi musulmani. Probabilmente il realismo funzionò al meglio in Europa quando era forte la solidarietà tra le élite: nel Settecento, la Francia fornì uno strumento linguistico comune e le norme del realismo sofisticato, che ricevettero una formulazione classica per mano di David Hume, furono ben comprese e ampiamente accettate; nessuno Stato si sentì offeso dall’amoralità della «Rivoluzione diplomatica» del 1740 (inizio della Guerra di successione austriaca) – quando gli Stati si riallinearono improvvisamente per riflettere i più recenti calcoli dell’equilibrio di potenza. È importante sottolineare il fatto che questi esempi privilegiano l’importanza di un accordo normativo; a volte, del resto, un accordo può consentire, quando non ...
Indice dei contenuti
- Prefazione
- Parte prima. Lo scenario
- Capitolo 1. Il mondo degli Stati
- Capitolo 2. Il sistema bipolare e la lunga Guerra fredda
- Capitolo 3. L’età della globalizzazione
- Parte seconda. Gli attori
- Capitolo 4. Il ruolo internazionale dello Stato
- Capitolo 5. Il ruolo internazionale degli attori economici
- Capitolo 6. Le istituzioni internazionali, le ONG e i regimi
- Capitolo 7. L’Unione Europea nel sistema politico globale
- Parte terza. Le questioni
- Capitolo 8. La guerra
- Capitolo 9. La pace democratica
- Capitolo 10. L’ambiente
- Capitolo 11. Il regionalismo: competizione o cooperazione?
- Capitolo 12. Le mafie: una prospettiva cosmo-politica
- Capitolo 13. La società civile globale
- Capitolo 14. Guerra, terrorismo e ordine internazionale nel momento unipolare
- Glossario
- Gli autori