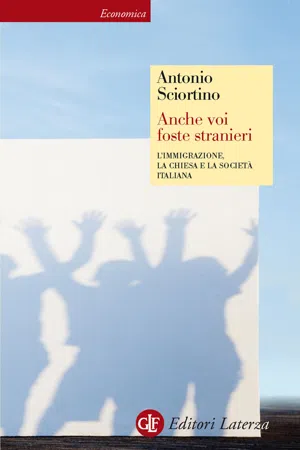Tutta colpa degli immigrati. Vecchi e nuovi diritti di cittadinanza
A Lampedusa, dove finisce l’Europa
«Si incidono sui nostri volti, come stilo sulla creta, i volti dei migranti segnati dal dolore di una violenza che passa dallo stato fisico allo stato psichico: dalla violenza sui corpi alla violenza che svuota i cuori. Volti, quelli dei migranti, che raccontano la paura del passato e della morte sempre in agguato; volti che chiedono libertà; volti che mendicano quella dignità perduta lungo le tracce del tempo presente, che distrattamente li consegna alla storia futura. È così che abbiamo imparato ad ascoltare, capire, conoscere, consolare i volti segnati da storie diverse, ma accomunati dal medesimo dolore».
Sono le parole di don Stefano Nastasi, parroco di San Gerlando a Lampedusa, la maggiore delle isole Pelagie, al centro, in questi ultimi anni, dell’attenzione dei media e della politica nazionale per i ripetuti sbarchi di immigrati dall’Africa.
La storia degli sbarchi a Lampedusa è antica quanto la stessa isola. Ma quel che è avvenuto nell’ultimo decennio, con il crescere dei flussi migratori, richiede una lettura più attenta. Per capire che cosa sta succedendo in quest’isola di seimila abitanti, dal mare più trasparente d’Italia, in mezzo al Mediterraneo: non più continente africano e non ancora terraferma italiana. E quali sono i nuovi bisogni di chi fa la traversata del Mare nostrum, a rischio della vita. Al convegno della Caritas, a fine marzo 2009, don Nastasi ammoniva: «È indubbio che sono anacronistiche le improvvisazioni sentimentali, così come fallimentare si rivelerebbe un volontariato naïf. Alle analisi fondate che rinvengono le cause dei problemi devono corrispondere risposte competenti e inedite».
Intervistato da Alberto Bobbio per «Famiglia Cristiana» (n. 14/2009), don Nastasi racconta la storia degli sbarchi e della sua gente, che non ha mai avuto paura di chi veniva dal mare. «Nessuna coscienza, nessuna pianificazione, nessun interesse. Solo accoglienza fraterna. La gente di Lampedusa aveva capito, anni fa, la richiesta d’aiuto del Continente africano». All’inizio l’emergenza l’ha affrontata solo la Chiesa. «Il primo centro di accoglienza è stato opera della parrocchia, espressione della comunità cristiana. Ma, nell’arco di un tempo breve, siamo stati tagliati completamente fuori da ogni forma di assistenza a chi veniva ospitato nel primo centro istituzionale. L’accoglienza è diventata affare di Stato. E nessuno di noi, da quel momento, ha avuto modo di dare il proprio contributo all’integrazione degli immigrati. Il cerchio s’è chiuso in un contesto istituzionale, che non sempre è stato in grado di cogliere gli elementi di una cultura del rispetto».
E concludeva: «Ci consideriamo in stato d’assedio. Abbiamo l’impressione che lo Stato abbia costruito una frontiera contro di noi. Anziché in uno Stato di diritto, ci sembra di vivere in uno Stato di repressione. E ciò offende la nostra dignità di lampedusani, abituati a essere luogo di incontro di popoli e culture». Dall’isola delle Pelagie parte l’appello per un tavolo di riflessione permanente sul Mediterraneo, come crocevia di popoli che si incontrano e si arricchiscono insieme. E per far sì che il Mare nostrum, da culla di civiltà e incontro tra le religioni, non si trasformi in luogo di scontro e morte. Un campo di battaglia per una guerra tra poveri.
A Lampedusa si vivono storie drammatiche di corpi straziati, giunti sulle onde del mare e sepolti in una zona del cimitero riservato ai derelitti senza nome. Se ne fa carico, con senso di compassione e misericordia, il guardiano del camposanto. A lui si rivolgono i carabinieri ogni qualvolta trovano un corpo sbattuto dalle onde sulle rocce della scogliera. Per questi poveri disgraziati non ci sono lapidi con foto e nomi. Solo una croce di legno, semplice e povera, come le loro storie. Una croce per tutti. Lui, il guardiano, non sa chi è cristiano e chi appartiene ad altra religione. Se li ricorda tutti, però, quei cadaveri consegnati dal mare. Morti di «mare mare», come dice lui, custode di un cimitero, dove il dolore e la pietà giacciono seppelliti dall’indifferenza. Per colpa di politiche disumane.
A poco sono valse le voci che si sono raccolte, a Lampedusa, nel marzo 2008, per ricordare lacrime e sofferenze di chi attraversa il Mediterraneo su vecchi barconi. E per pregare per le vittime del mare. Nel 2008, secondo i calcoli di Fortress Europe, sono state 642.
Su quest’isola, avamposto di un’Italia che fatica ad accogliere chi viene per fame o fugge da guerre, la Caritas nazionale, per tre giorni, s’è interrogata sulla politica per l’immigrazione. E ha visitato il Centro di identificazione ed espulsione (Cie), voluto dal ministro dell’Interno. L’isola, però, non vuole diventare sede stabile dove i disperati aspettano mesi o anni prima d’essere identificati, dichiarati rifugiati o rimpatriati. «Sì all’accoglienza», dicono gli isolani, «no alla permanenza. Non possiamo essere trasformati in una piattaforma in mezzo al Mediterraneo con tanti clandestini e nessun turista». Perché, sull’isola, la vita è sempre di serie B, a parte la bellezza del mare e della natura, perché mancano servizi necessari e si deve ricorrere alla Sicilia. E se è per nave, mare permettendo.
«Bisogna chiedersi tutti, comunità cristiana e Parlamento», ha detto monsignor Giuseppe Merisi, presidente della Caritas, «se queste modalità previste dalla legge uniscano davvero e in modo efficace accoglienza, legalità e rispetto dei diritti umani». Gli ha fatto eco Francesco Marsico, sempre della Caritas: «Ma è la speranza che qui fatica a trovare una via. Molti immigrati ci hanno chiesto di fare qualcosa per ottenere la libertà. Raccontano storie di soprusi e di fame nei loro Paesi. La libertà è un’aspirazione legittima, ma né noi né il nostro Paese, con la legislazione attuale, possiamo garantirla».
Per evitare la fuga di chi è in attesa d’essere rimpatriato, l’isola s’è ritrovata militarizzata. Fino a centoquaranta poliziotti, centosessanta carabinieri, quaranta finanzieri, novantuno soldati, tra aeronautica e bersaglieri. Gli abitanti di Lampedusa temono che l’isola militarizzata rechi gravi danni al turismo. «Prima eravamo un’isola, ora siamo isolati», dicono. «L’emergenza non si risolve soltanto con le forze dell’ordine».
Anche il vescovo di Agrigento, monsignor Francesco Montenegro, denuncia: «Solo una politica miope alza muri e vuole costruire altri centri a Lampedusa». E chiede alle autorità di smetterla di usare la parola «emergenza» per gli sbarchi. «Ormai è la normalità», dice. «Tanto vale accoglierli e farli ripartire per l’Italia».
L’arcivescovo di Palermo, monsignor Paolo Romeo, osserva: «L’unica carità possibile si chiama accoglienza. Non possiamo permettere che centinaia di stranieri restino per mesi in un Centro sapendo che per loro nessuna porta si aprirà mai». Di fronte alla disperazione, chi sa di non aver più nulla da perdere è tentato di fare qualsiasi gesto. Così si alimentano tensione e protesta. Ma cresce anche la ribellione. Nessuno, poi, crede che la detenzione, in attesa dell’espulsione, scoraggi nuovi sbarchi («Famiglia Cristiana», n. 14/2009).
Aiutiamoli, purché stiano a casa loro
Come luogo comune, niente male. A ogni dibattito, c’è sempre chi s’alza a dire: «Gli immigrati, aiutiamoli nei loro Paesi, così non scappano più da fame e miseria. E non vengono da noi». Idea fatta propria dai politici, che si riempiono la bocca di cooperazione e aiuti internazionali. In politica, la coerenza non è mai stata una virtù. E più si va in alto, peggio è. Così, a solenni proclami e promesse, in sedi internazionali, non seguono mai fatti concreti. Col tempo, ci si rimangia quel poco che era stato promesso. Il primo obiettivo del Millennio, solennemente sottoscritto dalle nazioni e dai capi di Stato di tutto il mondo, al vertice Fao nel 1996, si proponeva di dimezzare la fame nel mondo entro il 2015. Allora gli affamati erano ottocento milioni. Oggi hanno superato il miliardo. Oltre duecento milioni in più. Praticamente, un essere umano su sei.
Ogni giorno, nel mondo, c’è una strage: diciassettemila bambini muoiono di fame. Nessuno ne parla. Sembra vada bene così. I potenti della Terra hanno snobbato la Conferenza mondiale della Fao a Roma, nel novembre 2009. Eppure, basterebbero quarantaquattro miliardi di dollari per debellarla. Poco più di niente, per le grandi nazioni. Ma nessuno tira fuori i soldi. Dicono che c’è la crisi. Stessa ragione non vale per le spese in armamenti. Sempre più sofisticati, sempre più costosi. O per aiutare le banche, che hanno ripreso a trafficare con la «finanza creativa».
Alla Fao s’è presentato solo Benedetto XVI. Per dire che nel mondo c’è cibo sufficiente per tutti. Se solo si evitassero speculazioni e «ingiustizie strutturali non più tollerabili». E se il commercio mondiale fosse più equo. Ha ricevuto tanti applausi. Solo applausi.
Anche José Manuel Barroso, presidente della Commissione dell’Unione europea, ha ammesso il fallimento nella lotta contro la fame nel mondo. «Una vergogna sul piano morale», ha detto. I vertici internazionali, sotto le luci delle telecamere, «propongono», ma nessun Paese poi «dispone». Neppure l’Italia che, per la Cooperazione allo sviluppo, dà meno di quanto ha speso per organizzare il G8 all’Aquila, celebrato come grande trionfo internazionale. Sempre il solito lamento, o alibi: «Le risorse sono scarse. Ma stiamo provvedendo». Nessuno sa come e quando, ma basta a tacitare gli importuni. Difficile, però, rassegnarsi o consolarsi.
Non se lo possono permettere quei bambini che vorrebbero evitare di vagare per le strade del mondo, senza cibo né tetto. O gli altri piccoli profughi, senza madre né padre (quattordici milioni e mezzo nel 2008). Solo in Italia sono 7.500. La burocrazia li chiama «minori non accompagnati». Esposti a rischi altissimi di abusi, anche sessuali. Non se ne cura nessuno.
Meno di mezza tazzina di caffè al giorno
«Facciamo appello al suo senso di responsabilità e a quanto da lei affermato, in occasione di importanti summit internazionali, per evitare che l’Italia arrivi al G8 senza credibilità alcuna». Così avevano scritto il 31 ottobre 2008 al presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, associazioni, enti locali e singole persone. Una lunghissima lista di firmatari per scongiurare i pesanti tagli allo Sviluppo, annunciati nella Finanziaria 2009. «Abbiamo assistito», scrivono i firmatari, «all’approvazione di drastici tagli alle iniziative del Ministero degli affari esteri per la cooperazione italiana allo sviluppo, per un ammontare di 170 milioni di euro all’anno a partire dal 2009».
Nonostante la recente crisi finanziaria, fanno notare ancora i promotori dell’appello, diversi Paesi come Francia, Spagna e Germania hanno deciso di rispettare gli accordi presi a livello internazionale. La finanziaria presentata in Parlamento, per il solo 2009, con ulteriori tagli ai fondi per la cooperazione, arriva a una riduzione complessiva delle risorse di 400 milioni di euro. Numeri, questi, che collocano l’Italia all’ultimo posto in Europa per l’Aiuto pubblico e allo Sviluppo dei Paesi più poveri del mondo. Eppure, a conti fatti, centrare gli Obiettivi del Millennio costerebbe meno di mezza tazzina di caffè al giorno per ogni italiano. «Il contributo della cooperazione italiana», si legge ancora nell’appello, «è fondamentale sia alla politica estera del nostro Paese, sia allo sviluppo economico generale».
Appello simile era stato rivolto al nostro ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, dall’arcivescovo anglicano di Città del Capo, in Sudafrica, Desmond Tutu, premio Nobel per la pace nel 1984. Lettera che non ha avuto risposta, pubblicata poi su «Famiglia Cristiana» (n. 44/2008). «Una riduzione degli aiuti può fare la differenza tra la vita e la morte nei Paesi poveri», attacca Desmond Tutu. «Mi rivolgo a lei, nella speranza che possa far sì che l’Italia eviti di far ricadere sui poveri del mondo le conseguenze della crisi finanziaria che i Paesi ricchi stanno vivendo. In passato, l’Italia ha fatto la differenza in molti Paesi, fornendo aiuti che hanno consentito a più bambini di andare a scuola, a meno donne di morire di parto e a molti Paesi poveri di ridurre le cause della propria indigenza».
E, come esempio positivo, Tutu porta quello che il nostro Paese ha fatto per il Mozambico. «Paese al quale l’Italia», scrive, «ha donato più di 20 milioni di euro. Il governo è stato capace di investire quei soldi nel campo della salute e dell’istruzione, sollevando molte persone da una situazione di povertà». Memore dell’esperienza diretta che vive in Sudafrica (villaggi senz’acqua potabile, madri che vedono morire i propri figli, privati delle medicine essenziali, bambini che non possono andare a scuola), l’arcivescovo sudafricano ha fatto di tutto per scuotere il nostro ministro dell’Economia, perché riconsideri i tagli alla cooperazione (pari al 56 per cento). E perché dia una speranza a questi Paesi poveri che non vogliono dipendere dagli aiuti per sempre, ma hanno bisogno di fondi per investirli in cure mediche e nell’istruzione. Nella speranza di interrompere il ciclo della povertà.
Anche nel mondo degli affari e della finanza sta crescendo una sensibilità etica. Lo dimostra Banca Intesa con il «Progetto Malawi». «L’Africa non è già condannata, aiutarla si può», dice l’amministratore delegato Corrado Passera, che spiega all’inviato di «Famiglia Cristiana» (n. 22/2006), Luciano Scalettari, perché la prima banca italiana s’è messa a fare cooperazione in Africa. Il suo intento, in dieci anni, è dare al piccolo Paese africano la prima generazione di bambini liberi dall’Aids.
Banca Intesa, assieme a Fondazione Cariplo, ha già investito più di 9 milioni di euro, mettendo assieme quattro associazioni, Comunità di Sant’Egidio, Save the Children, Cisp (Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli) e Scouts del Malawi, con un progetto che si inserisce negli Obiettivi del Millennio dei Paesi dell’Onu, per ridurre la fame nel mondo.
Perché questa iniziativa di cooperazione in uno dei cinque Paesi più poveri della terra? «Perché è bello, giusto e bisogna farlo», dice Passera. «E perché non deve esistere alcuna zona del mondo che venga considerata perduta. Anche se l’Africa, oggi, in alcuni ambienti viene considerata condannata, io sono convinto che non sia così».
Buonismo di facciata? «Anche nel mondo degli affari», ricorda, «sta crescendo una maggiore sensibilità e attenzione a temi che, fino a qualche anno fa, erano considerati no-global, come la crescita sostenibile, le fonti di energia alternative, la lotta alla povertà. Nessuno può negare una certa miopia dell’attuale capitalismo, quando mira a risultati a breve termine e scoraggia gli investimenti sullo sviluppo sostenibile».
«Non ho certo la soluzione per l’Africa», conclude l’amministratore delegato di Banca Intesa. «Non conosco abbastanza le tante diverse realtà; restando, però, al Malawi, mi sembra condivisa la convinzione che ci si debba concentrare, oltre alla lotta all’Aids, su alcune priorità fondamentali come l’acqua, l’energia e l’istruzione. Soffrono di carestie tremende a causa di ricorrenti siccità, pur avendo terre fertili e un lago enorme: bisogna portare l’acqua dove occorre. Anche per questo serve l’energia, che sta alla base di qualsiasi attività economica. Comunque, nessuno sviluppo è possibile senza istruzione, almeno di base. Se si ferma l’Aids e si spinge su queste tre leve, si potrebbe, in pochi anni, moltiplicare l’attuale reddito medio pro capite, che oggi non arriva a mezzo dollaro al giorno, e fermare il calo dell’aspettativa di vita (meno di 40 anni), che è inferiore a quella che, in Europa, avevamo nel Medio Evo».
Così rifioriscono le dune del deserto
I tunisini lo chiamano, con affetto, l’imam cattolico. È don Pietro Sigurani, parroco della Natività di Roma, amico di un religioso islamico, il vero imam, che ha conosciuto trent’anni fa in Tunisia. «In principio furono Pietro, Alì, Beshir e Bel Gazem. E detta così, sembra proprio l’inizio di una Bibbia un po’ musulmana e un po’ cristiana».
Racconta la storia su «Famiglia Cristiana» (n. 29/2008) l’inviato Guglielmo Nardocci, che ha accompagnato don Pietro nelle dune tunisine per vedere «rifiorire» il deserto di case d’accoglienza.
Siamo a Douz, cittadina a sud della Tunisia, la «porta del deserto» verso le dune del Sahara. Don Pietro vi arrivò nel 1979, e lì incontro Alì, che diventò suo amico e lo fece innamorare delle dune roventi. All’inizio, nessuno gli dava casa. Prevaleva la diffidenza. Fin quando espose i suoi programmi all’imam Bel Gazem («fra religiosi ci si capisce», pensò), che gli assicurò: «Avrai mille case, perché farai del bene ai nostri figli, li aiuterai, li farai lavorare». E così fu che don Pietro poté impiantare case d’accoglienza, centri di formazione al lavoro per giovani tunisini, fabbriche per la lavorazione dei datteri. Ebbe la certezza che la sua opera aveva messo radici tra le dune del deserto solo quando, un giorno, lo chiamò il capo della polizia. «Per cinque anni abbiamo spiato ogni tua mossa», gli disse. «Ma abbiamo notato che, dovunque vai, preghi. E noi non abbiamo paura di chi prega, perché porta la pace».
Da allora, le iniziative sono cresciute. «Non sono semplici abitazioni», spiega don Sigurani. «E, soprattutto, non sono nostre. Tutto quello che realizziamo lo diamo in proprietà ai tunisini, perché serva loro a vivere meglio e a educare i ...