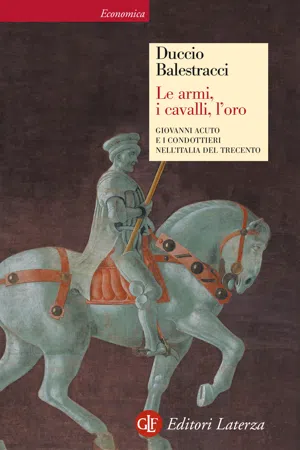
eBook - ePub
Le armi, i cavalli, l'oro
Giovanni Acuto e i condottieri nell'Italia del Trecento
- 320 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
«La mattina del 20 marzo del 1394 Firenze si sveglia con il rintocco delle campane a morto. I fiorentini sanno perfettamente di cosa si tratta e un po' alla volta cominciano a sciamare verso Piazza della Signoria… Alla salma di John Hawkwood –il condottiero inglese ribattezzato Giovanni Acuto– la città tributa l'onore di un vero e proprio funerale di stato. Quello che era stato il più grande e temuto capitano al soldo dei fiorentini, costato uno sproposito da vivo, nemmeno da morto era stato a buon mercato…»
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Le armi, i cavalli, l'oro di Duccio Balestracci in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Storia e Storia dell'Europa medievale. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
StoriaCategoria
Storia dell'Europa medievalecapitolo 1 L’apprendistato
Era nato in Inghilterra, nella contea di Essex nei pressi di Colchester, in un luogo chiamato Sible Hedingham, dove ancora ai giorni nostri esiste una dimora che di medievale non ha ormai assolutamente nulla, ma che porta il nome di Hawkwood Manor. Quando ci nasce Giovanni, in una data sconosciuta ipotizzabile intorno ai primi anni Venti del Trecento, e quindi nel periodo del regno di Edoardo III, la terra è sotto la giurisdizione dei conti di Oxford, signori del castello di Hedingham, a un esponente dei quali la tradizione popolare attribuirà il merito – o la responsabilità – di aver avviato il giovane figlio del conciapelli Gilberto Hawkwood alla carriera di soldato.
È sotto questa signoria, effettivamente, che si inquadrano giuridicamente gli uomini e le terre della zona, fra le quali anche la piccola proprietà degli Hawkwood, in mano alla famiglia – ma a dirlo è ancora la tradizione non suffragata da alcunché di documentabile – fin dall’epoca di Giovanni Senzaterra. Quel che è certo è che il padre del futuro soldato, artigiano, ha messo insieme una qualche fortuna che fa di lui un piccolo borghese benestante.
Dopo che Giovanni avrà fatto carriera non mancheranno genealogisti o eruditi che si cimenteranno nel fare degli Hawkwood degli aristocratici (di sangue reale addirittura discendenti da un re dei frisoni, secondo i più fantasiosi). Il cronista fiorentino Filippo Villani (metà Trecento-inizio Quattrocento) invece darà l’immagine forse più corretta dello status sociale della famiglia, scrivendo che gli Hawkwood non erano «di schiatta di nobili con dignità», cioè aristocratici titolati, ma che il padre era «gentiluomo mercatante e antico borghese» proprio come – aggiunge – «i suoi antenati». I termini – e l’accostamento di essi – come ben si capisce sono presi di peso dalla realtà sociale della Firenze di Filippo, il quale aveva sotto gli occhi lo spettacolo di uomini d’affari che si stavano piano piano trasformando in «gentiluomini», diversificando i loro investimenti fra fondaco, operazioni finanziarie e possedimenti fondiari, magari legandosi con vincoli matrimoniali a schiatte titolate. Forse non sono i termini più rigorosi per descrivere la realtà dell’Inghilterra del primo Trecento, ma la sostanza è tuttavia chiara: gli Hawkwood sono agiati borghesi di campagna, come del resto si deduce senza troppi equivoci dal testamento stilato da Gilberto, che muore nel 1340.
In questa occasione, infatti, il conciapelli lascia al figlio maggiore Giovanni – omonimo del fratello minore – il carro con sei cavalli da tiro, due buoi e la maggior parte dei terreni. Al secondo Giovanni – quello che ci interessa – toccano venti lire e cento soldi, mentre l’altro maschio, Niccolò, eredita un’altra somma di denaro. A entrambi, inoltre, vanno un po’ di terreni e il diritto di mantenimento sui beni familiari per un anno. Poi, nell’asse ereditario di Gilberto, compaiono quattro femmine: due – Agnese e Giovanna – sono sposate e a loro il padre lascia cento soldi per una, mentre a ciascuna delle altre due – Alice e Margherita, entrambe nubili – spettano, oltre ai cento soldi, anche dieci lire (evidentemente per costituire la dote) e il diritto al mantenimento da parte della famiglia per un anno. Gilberto non si dimentica dei suoi servi e, soprattutto, com’è costume generalizzato dei suoi contemporanei in tutta la Christianitas, inserisce nel suo testamento una serie di lasciti pii: all’opera della cattedrale di San Paolo a Londra, ad altri luoghi religiosi e a chiese perché vengano celebrate messe in suffragio della sua anima. Soprattutto destina una certa somma alla parrocchia di Sible Hedingham, dove sceglie di riposare, per il diritto di sepoltura e per far celebrare suffragi per la settima e per il trigesimo della sua morte. Insomma, non lascia un tesoro ma ugualmente una piccola fortuna che va a vantaggio soprattutto del maggiore, ma tale da poterci far attingere, con parsimonia, anche altri.
Se il Villani coglie nel segno per quanto riguarda la collocazione sociale entro la quale nasce Giovanni, non si sottrae alla tentazione di attribuire al futuro capitano della guerra della sua città una nascita all’insegna dello straordinario se non addirittura del premonitore. Ben lungi dal riconoscere in Hawkwood il cognome, il fiorentino ne fa il secondo nome – o meglio, il nomignolo – di Giovanni. La madre, racconta il Villani, in procinto di partorire in un suo castello «e non possendo, si fe’ portare in uno suo boschetto, e quivi lui di presente partorì» dandogli come secondo nome, appunto «Hawkwood che in latino dice Falcone di bosco ovvero in bosco».
Tuttavia, anche l’origine borghese è destinata a trasformarsi in qualche cosa di inusuale per quest’uomo, al quale le testimonianze a lui posteriori non sembrano rassegnarsi ad attribuire una cifra di normalità. Le cronache francesi, per prime, creano confusione tra la figura di John Hawkwood e quella di Jean de l’Aiguille; il cronista fiorentino Matteo Villani († 1363) correttamente distingue le due persone e parla di Gianni della Guglia – inglese – al quale però, complice il nome francese, attribuisce il mestiere originale di sarto. Gianni della Guglia, scrive il Villani, nel 1359 forma una compagnia di soldati al soldo del re d’Inghilterra e con essa mette insieme un bel po’ di denaro. L’Aiguille e lo Hawkwood non possono essere affatto la stessa persona, come si vede, e se non bastasse la testimonianza del Villani risulta definitiva quella del cronista francese Froissart che parla dello Hawkwood, nel 1360, come di un cavaliere di modesta ricchezza e ben lungi dall’aver fatto fortuna.
L’equivoco creatosi in età medievale basta e avanza agli eruditi inglesi del Seicento per costruire dal niente la storia di un Giovanni Hawkwood artigiano, anzi sarto, che aveva saputo elevarsi dalla sua modesta collocazione sociale e dalla piattezza del suo mestiere ai fastigi di protagonista della grande storia militare.
In realtà la sua vocazione alle armi è la più scontata che si possa immaginare per un giovane della sua epoca e della sua condizione. Figlio cadetto, con la maggior parte del patrimonio che va al maggiore, con quattro sorelle e altrettante doti già corrisposte o ancora da corrispondere, le strade più ovvie che gli si aprono davanti sono due: o il chiericato o le armi. La prima è infatti quella più congeniale per il fratello Niccolò che ritroviamo nel 1363 titolare di una cappellania con relativo beneficio. Giovanni probabilmente non è tagliato per il piviale e il salterio e segue la seconda: quella delle armi.
E, tuttavia, anche su questa decisione banale la tradizione erudita volle ricamare, inventando la storia di un Giovanni Hawkwood arruolato a forza contro la sua volontà. Invece no: la carriera militare il giovane e squattrinato cadetto la sceglie volontariamente come tanti altri come lui con pochi soldi e tanta ambizione; i suoi titolati predecessori, nelle sue stesse condizioni di partenza, avevano abbracciato la vocazione della cavalleria cercandosi un maestro, un protettore, un adoubement e, dal giorno dopo, mettendosi in sella a un cavallo in cerca dell’aventure e possibilmente della fortuna, della fama e della ricchezza. Ma in un’epoca che non era più quella dei Guglielmo il Maresciallo, ai molti Giovanni non resta che cercare l’occasione della vita dove si ammazza, dove c’è una guerra in corso. Quelli come lui devono imparare il mestiere di soldato, cominciare magari dalla «gavetta», scudieri, paggi, famigli o comunque soldati di un condottiero o di un signore per apprendere e aspettare che qualche occasione li metta in mostra e induca il loro patronus a crearli «uomini d’arme». Una volta ottenuto questo riconoscimento possono, ovviamente purché abbiano i mezzi per l’equipaggiamento, mettersi sul mercato, arruolare soldati ai loro comandi e affittare la loro spada al miglior offerente.
Per fortuna di Giovanni Hawkwood, quando comincia la sua aventure, di guerre in corso ce n’è una e bella grossa, scoppiata quando lui era un ventenne, nel 1339. Sarebbe durata, fra periodi di belligeranza intervallati a periodi di più o meno lunga provvisoria quiete, in tutto centoquattordici anni: la tradizione l’avrebbe battezzata «guerra dei Cento Anni». A scatenarla, formalmente, è stata la discutibile pretesa di Edoardo III d’Inghilterra, figlio della sorella di Filippo IV il Bello – Isabella – andata in moglie a Edoardo II, di succedere sul trono francese andato invece al cugino Filippo VI. In realtà, nel 1317 gli Stati generali francesi avevano esplicitamente e formalmente escluso la possibilità di successione per via femminile quando gli stessi diritti erano stati accampati da una figlia di Luigi X a sua volta figlio di Filippo IV. Dunque i motivi veri del conflitto erano ben altri.
Era l’insanato contrasto fra Inghilterra e Francia per l’Aquitania, dalla quale gli inglesi erano stati quasi totalmente espulsi se si fa eccezione per una striscia costiera fra Bordeaux e Bayonne. Era la preoccupazione della corona inglese per il movimento di espansione della Francia verso la regione tedesca. Era il paventato riavvicinamento tra la Francia e il conte di Fiandra che metteva a repentaglio il legame di quella terra con l’Inghilterra, saldatosi da quando, all’epoca di Filippo II Augusto, i fiamminghi avevano visto nella corona dirimpettaia una garante della loro autonomia dalle mire di quella francese e avevano offerto in cambio agli inglesi un proficuo sbocco commerciale su uno dei più dinamici mercati della Christianitas. Non a caso, dopo l’intervento di Filippo VI in aiuto al conte contro le masse artigiane in rivolta, numerosi tessitori avevano scelto di abbandonare la Fiandra e di emigrare – con armi, bagagli e, soprattutto, tecnologie – in Inghilterra. A preoccupare l’Inghilterra era l’asse che Filippo VI aveva oculatamente saldato con gli scozzesi accettando di aiutare la fazione «legittimista» e di ospitare in Francia il re David II, ancora minore, con la madre e le sorelle, spodestati dall’invasore Edward Balliol che, fattosi incoronare re, stava attuando una strisciante politica di sottomissione della Scozia all’Inghilterra.
Queste le ragioni che avevano confluito nel far scoppiare il conflitto.
E per i giovani «guerrieri» inglesi il suolo francese era diventato l’occasione per giocarsi le proprie chances di fare fortuna. Fra questi, appunto, c’è Giovanni Hawkwood, avviato a questa carriera da uno zio anch’egli soldato, al seguito del contingente agli ordini del signore delle terre dov’è nato: John de Vere, conte di Oxford. Con lui combatte in Francia dai primi anni Quaranta: forse è a Crécy il 26 agosto 1346 quando gli inglesi in inferiorità numerica battono i francesi, forse è a Poitiers il 19 settembre 1356 quando il Principe Nero – Edoardo principe di Galles – sconfigge l’armata di Giovanni il Buono di Francia. Forse è in questa occasione che, mettendosi particolarmente in mostra per il suo coraggio e la sua capacità, proprio il Principe Nero lo investe cavaliere e lo prende sotto la sua protezione. Non c’è alcuna prova di nessuna di tutte queste cose tramandate dalla tradizione e che potrebbero molto verosimilmente essere un altro frutto della glorificatio ex post dello Hawkwood. Ma se gli episodi non sono veri, sono tuttavia verosimili e soprattutto una cosa è indiscutibile: la guerra in terra francese è il banco di prova del giovane guerriero, che lo supera, probabilmente, in modo molto dignitoso. L’apprendistato si può definire concluso: Giovanni Hawkwood, adesso, non ha che da aspettare l’occasione per dimostrare ciò che sa fare in proprio.
capitolo 2 La pace è una sciagura: Brétigny 1360
Poi succede qualcosa: l’ultima cosa che un uomo d’armi spera che possa succedere e la prima di cui ha terrore. La guerra finisce e inizia la pace. Nel 1360 a Brétigny, vicino a Chartres, viene conclusa la tregua che il 24 ottobre sarà solennemente ratificata a Calais. La Francia ha visto di tutto e ha subìto di tutto: il suo sovrano Giovanni il Buono fatto prigioniero e rimasto per quattro anni in mano agli inglesi; il caos istituzionale; le turbolenze della borghesia parigina capeggiata da Étienne Marcel, manovrato dal re di Navarra Carlo il Malvagio, amico dell’Inghilterra; l’insurrezione della jacquerie che dà voce ai contadini ridotti in miseria dalla guerra e dalle tasse e che dall’Île-de-France dilaga nelle regioni vicine fino a collegarsi con il partito di Étienne Marcel contro la corona; Parigi assediata dal delfino Carlo (poi Carlo V); le porte della città spalancate agli odiati nemici navarrini e inglesi; il Marcel ucciso dai cittadini inferociti per il tradimento e, infine, Parigi di nuovo in mano al principe ereditario.
Con Brétigny l’Inghilterra rinuncia alle pretese sulla corona francese, ma viene indennizzata a peso d’oro (metaforicamente e alla lettera): passano in mano inglese il Poitou, l’Aquitania, la Guascogna e Calais; cambia padrone, dal tesoro della corona francese a quello inglese, un’ingente quantità di oro.
Per il sovrano francese, una dolorosa ma preziosa boccata d’ossigeno; per il re inglese, una vittoria a tutto tondo; per i soldati di professione, una vera disgrazia.
Ora si tratta di riorganizzarsi, se si vuole sopravvivere. E riorganizzarsi sulla base del solo mestiere che essi sanno fare: quello di combattere. Per loro fortuna, di soldati c’è bisogno sempre e se un ingaggio finisce altri se ne aprono con altri scenari.
La crisi dell’esercito quale si era andato strutturando in epoca signorile, basato sui vincoli di fedeltà vassallatica e incentrato sul ruolo della cavalleria, ormai, fra XIII e XIV secolo, è un fenomeno che si tocca con mano. In Inghilterra, nel corso del Duecento, sempre più frequentemente i titolari di un beneficio rifiutano la dignità cavalleresca per non essere obbligati a ottemperare agli obblighi militari che le due cose comportano; magari accettano di combattere in un ruolo subalterno (servientes, scutiferi e così via) che senz’altro è economicamente meno impegnativo dell’altro. Contemporaneamente, sempre in Inghilterra (ma anche altrove succede lo stesso), elementi popolari, socialmente lontanissimi dalla possibilità di essere investiti cavalieri, combattono comunque a cavallo.
In Francia il fenomeno è più o meno lo stesso: il servizio armato che il vassallo deve al signore tende sempre di più a ridursi o a farsi evanescente; quando non si può evitare di combattere per lui, si accetta di farlo, obtorto collo, solo per il tempo strettamente indispensabile previsto dal rapporto di fidelitas. All’inizio del XIV secolo i vassalli acconsentono a seguire il signore, ma entro i limiti del territorio loro concesso: al di là di questo, se il signore vuole il loro servizio, deve rimborsarli delle spese fino all’ultima lira. E non sono nemmeno solo i vassalli a comportarsi così, perché il costume penetra fino alle fasce più basse della popolazione: anche i contadini, infatti, prestano il servizio armato al proprio signore entro i confini del feudo, passati i quali sono loro a decidere autonomamente se continuare a impugnare le armi o se tornare ai loro attrezzi agricoli, e in ogni caso, se decidono di restare, si fanno pagare. I borghesi, per parte loro, non sono da meno: nel 1203 il conte di Bar contratta con i borghesi di una sua città l’impegno ad averli per dieci anni nell’esercito; i cittadini accettano, ma in cambio del loro affrancamento e della garanzia di non dover pagare di tasca propria più di due giorni di trasferta, quando il signore abbia bisogno di loro; tutto il resto delle spese le dovrà affrontare il signore stesso. Alla fine del Duecento, i borghesi di Rouen dichiarano che seguiranno l’esercito del proprio signore solo fin dove sarà loro possibile far ritorno a casa a sera.
Imprese militari che comportino spostamenti su grande distanza o durate lunghe, come si capisce, diventano semplicemente impraticabili.
In Italia la trasformazione è, se possibile, ancora più accelerata: soprattutto nell’area centro-settentrionale e in quelle realtà caratterizzate dalla veloce crescita delle autonomie comunali, il sistema militare basato sulla milizia organizzata per compagnie cittadine mostra ben presto il suo limite. Funziona fin quando la città deve difendersi da quel che le si muove intorno, ma quando i comuni cominciano ad aggredire il territorio e a costruirsi il contado è difficile poter condurre guerre di conquista – anche quando si tratta di un solo modesto castello – con armati che nella vita fanno tutt’altra cosa che combattere; che hanno più dimestichezza con gli strumenti della bottega che con le spade e che quanto più stanno lontani dalla loro attività tanto meno producono e tanto meno creano ricchezza collettiva. Così già nel XIII secolo questa forma di milizia si trova integrata in maniera determinante da soldati di professione. E la tendenza si accentua con il tempo soprattutto quando, con la fine del Duecento, cominciano a manifestarsi i segnali di crisi economiche e sociali. Infine, in quei comuni che vedono nascere dal seno delle loro stesse istituzioni forme di governo signorile, è proprio il s...
Indice dei contenuti
- Premessa
- Le esequie del condottiero
- parte prima Il SOLDATO
- capitolo 1 L’apprendistato
- capitolo 2 La pace è una sciagura: Brétigny 1360
- capitolo 3 Il mestiere delle armi
- capitolo 4 1363-1365L’esordio di Giovanni nelle guerre d’Italia
- capitolo 5 1365-1372Al servizio di Bernabò Visconti
- capitolo 6 1373-1376Al servizio di Santa Romana Chiesa
- capitolo 7 Le foibe di Cesena
- capitolo 8 1377-1379Con Firenze e con Bernabò Visconti
- capitolo 9 1379-1382L’ordine regna a Firenze
- capitolo 10 1382-1386La questione di Napoli
- capitolo 11 1386-1387Al servizio di Padova
- capitolo 12 Firenze: una città per sempre
- capitolo 13 1390-1392L’ultima impresa:la guerra contro Gian Galeazzo Visconti
- parte seconda L’UOMO
- capitolo 14 Vizi pubblici e private virtù
- capitolo 15 Moglie, figli e amici
- parte terza Tra STORIA e MITO
- capitolo 16 Monumenti di marmo, monumenti dipinti
- capitolo 17 La volpe,il brigante,il cavaliere
- Fonti e bibliografia
- Cartine
- Immagini