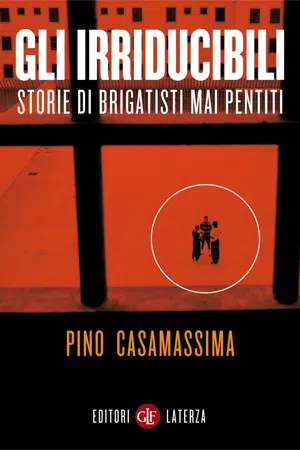1. Genesi e palingenesi della lotta armata
«Rompere il culo ai padroni, ma prima ad alcuni colleghi di lavoro», «ammazzare i capi squadra uno alla volta», «ammazzare i capireparto», «ammazzare i capi officina e tutti i ruffiani», «mettere Agnelli al nostro posto», «lavorare il meno possibile», «far lavorare i padroni». Queste risposte, stralciate da un’inchiesta svolta da PotOp (Potere operaio) tra gli operai di Mirafiori, restituiscono il clima di un’epoca (l’indagine è del novembre 1969) segnata dalla rottura di quegli equilibri industriali stabilitisi disordinatamente nel corso di tutto il decennio “favoloso” e – ormai incancreniti – destinati a metastasizzare gli anni successivi, producendo una conflittualità permanente. Un periodo storicizzato come «stagione dei movimenti» per l’inedita e per certi versi bizzarra unione fra studenti e operai: un meticciato che incendierà una prateria in cui erano germogliate multiformi esigenze non solo in campo operaio e studentesco, ma in tutte le pieghe di una società in selvaggia e incontrollata trasformazione. Sotto questo cielo confuso venivano alla luce effervescenze che spingevano a mobilitazioni differenti per origine e natura, ma convergenti nella contestazione di istituzioni polverose, incapaci di promettere se non prospettive, almeno mediazioni convincenti sul piano politico (e conseguentemente, economico e sociale). Nel conflitto durissimo che il mondo operaio ingaggia col padronato debuttano forme nuove di un agire che per il momento – lungi dal perimetrare contorni di una «società dell’avvenire» tutta da immaginare e fuori da precostituiti schemi similsovietici – si esprime con la determinazione di un «No!» forte e chiaro nel rifiuto dello status quo. Rifiuto che implica l’abbattimento di quello status quo.
Moloch di riferimento, quella Fiat in cui per lunghi anni si era accumulata una rabbia silente che a breve avrebbe fatto esplodere focolai di conflittualità, stimolati dalla progressiva pressione esercitata dai capireparto per incrementare la produzione. Il lavoro nelle fabbriche era cresciuto su ritmi insostenibili con i polpastrelli degli operai del reparto verniciatura perennemente ustionati perché costretti a sfilare dai forni lamiere ancora bollenti, mentre temperature incandescenti asciugavano i polmoni. «Chi entrava in Fiat poteva considerarsi un uomo perduto, perché lavorare alla catena di montaggio toglie ogni possibilità di fare qualunque altra cosa [...]. Il 90% di noi si addormentava sul tram, arrivava a casa e si preparava già per il lavoro del giorno dopo [...] c’era paura [...] c’era il deserto alla Fiat per tutti gli anni Sessanta e tu eri là, solo, abbandonato. O te ne uscivi o eri un uomo perduto, avevi tutti contro». La fabbrica serve per far conto su un salario, la mutua, la pensione: fuori gli operai riparano elettrodomestici, fanno gli idraulici, i meccanici, gli imbianchini per arrotondare una busta paga leggerissima, la più leggera d’Europa. Con le loro lotte gli studenti dimostrano che «si può» (ottenere). Basta picchiare duro. Così, un anno prima della «stagione degli operai» si sviluppano in fabbrica scioperi e iniziative autonome, fuori da qualsiasi controllo sindacale. Capita che le tute blu fermino improvvisamente la produzione, urlando «Venga giù il direttore del personale». Costretto a scendere, il dirigente viene bloccato nei pressi di un tornio, con gli operai che gli sfilano davanti uno ad uno, dicendogli «faccia di m...», «faccia di m...», «faccia di m...». Comportamenti inediti e forse catalogabili come delle jacqueries trasferite dal contado all’industria. Gli attori appartengono a masse giovanili poco scolarizzate, trasferitesi dalla campagna alla città, e imprigionate alla catena di montaggio di una fabbrica di cui non conoscono le dinamiche, diffidando – perché non appartiene alla loro precedente esperienza lavorativa – della «rappresentanza sindacale».
È l’operaio-massa. Per Toni Negri, quell’«operaio sociale» sul quale si può costruire un’ipotesi rivoluzionaria. Gli effetti dell’«operaio in rivolta» si palesano progressivamente, con le ore di sciopero che passano dai 28 milioni del 1967 ai 50 del 1968, fino agli oltre 230 milioni del 1969. È la Fiat a svolgere l’ingrato quanto “naturale” ruolo di apripista di una stagione rivendicativa da resa dei conti, anche se nel “bianco” Veneto di Valdagno, che ospita la Marzotto, gli operai abbattono la statua di Gaetano Marzotto: quasi un metafisico monumento al paternalismo aziendale. La contaminazione studentesca produce anche nella fabbrica la gestione assembleare del confronto (scontro): alla Zoppas di Pordenone i dirigenti sono costretti dagli operai a uscire non solo dai loro uffici, ma dalla fabbrica stessa, per discutere in piazza, fra la gente che interviene nella trattativa. Al Petrolchimico di Porto Marghera, nell’agosto del 1970, al termine di scontri durissimi in cui un agente viene tirato giù da una camionetta e malmenato brutalmente, la polizia spara ferendo due operai. La rabbia operaia monta da Nord a Sud, passando dalla Ducati di Bologna per arrivate all’Italsider di Taranto, dove negli ultimi dieci anni si sono lamentate 200 vittime. Alla Rhodiatoce di Pallanza, la palazzina della direzione viene occupata, mentre altri operai bloccano sedi stradali, ferroviarie e perfino i traghetti sul Lago Maggiore. Alla Piaggio di Pontedera «la violenza – denuncia «Rinascita» – e l’illegalità sono talmente diffuse da rappresentare un Leitmotiv». Alla Siemens sono sospesi o licenziati per atti di violenza diversi operai. Quando tocca anche a un membro della Commissione interna si verificano le prime azioni delle Brigate rosse presenti in fabbrica: Mario Moretti, Corrado Alunni, Pierluigi Zuffada e Paola Besuschio. A essere colpite sono le auto dei dirigenti di cui, nel volantino di rivendicazione, vengono diffusi anche gli indirizzi privati. L’escalation delle azioni brigatiste avverrà da questo momento in avanti col sostanziale beneplacito operaio, come dovrà riconoscere lo stesso Ugo Pecchioli – il dirigente del Pci più impegnato sul fronte della lotta alla sovversione e al terrorismo – dopo il clamoroso attentato contro la Pirelli: «La nostra condanna non fu compresa e condivisa da molti settori non marginali di lavoratori, perché con quella azione le Brigate rosse avevano denunciato in modo clamoroso il clima autoritario di sfruttamento realmente esistente all’interno delle fabbriche. Contava certamente il fatto che le Brigate rosse, fino a quell’anno, non avevano mai ucciso nessuno».
Il segnale di un’autonomia operaia sempre più slegata dai vincoli sindacali arriva forte e chiaro quando nel 1971 un milione e mezzo di lavoratori dell’industria elegge su scheda bianca (cioè in assenza di schede coi nomi segnalati dai sindacati) 60.000 delegati di reparto o di gruppo in circa 6000 consigli di fabbrica. In questo contesto maturerà il sequestro di Ettore Amerio, direttore del personale Fiat, a Torino, anche se per tutta la prima fase del neonato partito armato è Milano il cuore pulsante delle Brigate rosse, come conferma Mario Moretti: «Nel tessuto cittadino di Milano la distinzione tra fabbrica e quartiere non è netta come altrove. Succede di trovare gli stessi compagni nel comitato di base dell’Alfa e al Centro sociale di Quarto Oggiaro, oppure qualcuno alla Marelli in un comitato alla Bovisa, un ragazzo che lavora alla Breda nei Comitati lavoratori-studenti. Prendete l’occupazione delle case che diventa una caratteristica di quegli anni: la guidano gli stessi operai che nel sindacato o altrove tirano le lotte in azienda. Gli operai sono stati protagonisti a Milano, non brontosauri in estinzione. Sono stati soggetti politici forti che dicevano la loro nei processi di trasformazione, che si inventavano la loro organizzazione e praticavano un altro tipo di democrazia. Le Brigate rosse sono state fino al ’72-’73 un fatto esclusivamente milanese e non potevano che nascere qui». Ma la “milanesità” delle neonate Brigate rosse – intesa come modus agendi coerente con un complicato e complesso tessuto connettivo metropolitano – si estenderà presto ad altre città, a cominciare da quella Torino che ospita la più grande concentrazione operaia d’Europa per quella Fiat (e le tante realtà satellitari ad essa collegate), dove non è raro sentire parole che più che a una canzone paiono appartenere a un incubo: «Signor padrone questa volta per te andrà di certo male / siamo stanchi di aspettare / che tu ci faccia ammazzare. / Noi si continua a lavorare e i sindacati vengono a dire che bisogna ragionare e di lottare non si parla mai. / Signor padrone ci siam svegliati e questa volta si dà battaglia e questa volta come lottare lo decidiamo soltanto noi. / Vedi il crumiro che se la squaglia, senti il silenzio nelle officine, forse domani solo il rumore della mitraglia tu sentirai!».
Più esplicita L’ora del fucile di Pino Masi: una canzone che contiene già nel titolo un’indicazione precisa, e il cui ritornello domanda ossessivamente «Cosa vuoi di più compagno per capire che è suonata l’ora del fucile?».
Più tardi, quando inizieranno i valzer degli arresti, riecheggerà Liberare tutti: «Liberare tutti vuol dire lottare ancora, / vuol dire organizzarci senza perdere un’ora. / E tutti i riformisti che fanno i delatori, insieme ai padroni noi li faremo fuori. / Porci padroni voi vi siete illusi / non bastano le galere per tenerci chiusi».
Canzoni “coerenti” con le azioni che avvengono fuori dalla fabbrica ma in netta simbiosi con essa, a cominciare dagli obiettivi individuati, la cui primogenitura vede in prima fila capi e capetti “servi del padrone”. Una situazione estendibile in tutto il Nord, a cominciare da quell’Emilia rossa da cui le Brigate rosse attingeranno molte delle loro risorse in un momento in cui il Partito comunista era terrorizzato dalla possibilità (concreta) di doverli riconoscere nello stato di famiglia.
Oltre alla fabbrica, a fare da collettore, con un’effervescenza che produrrà alcune fughe nella lotta armata, ci sono le numerose occupazioni delle case, come quella drammatica di San Basilio a Roma, dove, nel 1974, si accenderà una battaglia durissima combattuta contro le forze di polizia da centinaia di baraccati sostenuti da Lc (Lotta continua). Alla fine sul selciato resta un ragazzo di 19 anni. Sullo zainetto che aveva con sé, aveva scritto con un pennarello «Brigate rosse» e «Piazzale Loreto». «È drammatica come esperienza, molto drammatica, perché sono tre giorni di scontro [...] è una specie di Londonderry, cioè di battaglie fatte di molotov e sassi per conquistarsi cinque metri di terra, dieci metri di incrocio [...] finché non fu ucciso quel ragazzo del collettivo dei Castelli, e lo uccidono proprio di fronte a me [...]. Mentre facciamo un attacco a una postazione di polizia c’è questa sparatoria da parte della polizia e muore questo ragazzo [...] e poi la notte c’è stata una sparatoria feroce perché quelli della sezione sono ritornati, ma non solo quelli della sezione, ma tutti sono ritornati armati e hanno fatto l’ira di Dio, cioè scontri a fuoco con la polizia [...]. È come se avessi raggiunto il tetto [...] c’erano delle persone che non avevano casa, dovevano avere una casa [...] mi sembrava assurdo, improbabile il discorso di sparare su di noi, cioè di risolvere in termini politici, con la forza delle armi, un problema scottante e grossissimo come quello della casa [...]. Comincio a dire seriamente che a questa cosa va risposto con un’organizzazione non solo sui bisogni, ma generale, clandestina»: questa testimonianza del futuro brigatista Antonio Savasta, presente in Storie di lotta armata di Manconi e Catanzaro, è sintomatica perché proprio tale esperienza determinerà la decisione del giovane Savasta – che militava in Autonomia – di entrare nel partito armato. Non solo percorsi operai, quindi. Significativo è il richiamo a Londonderry, episodio-icona di una lotta di popolo, in questo caso quella irlandese, anche se i maggiori riferimenti in questo senso sono ai palestinesi e ai cileni.
La “nuova sinistra” – termine che oltre a essere identificativo di quella comunemente chiamata sinistra rivoluzionaria (extraparlamentare dai media) rende l’idea della distanza dalla sinistra storica (e parlamentare), in primis dal Pci – intercetta il disagio di orfani di padri non solo reazionari, ma anche progressisti, schierati a sinistra, la cui colpa è quella – paradossalmente, proprio in nome dei figli – d’essersi arresi al benessere. Il loro parricidio lascia tuttavia smarriti, perché provoca il crollo di tutti i ponti fra vecchie e nuove generazioni, soprattutto quello sepolto sotto le macerie della fine della guerra, con quella consegna delle armi non solo effettiva ma anche – e soprattutto – simbolica. Il riconoscimento di un tracciato (dei padri) perdente, genera la ricerca di una via alternativa e lo slogan lanciato da PotOp, «la democrazia è il fucile sulla spalla degli operai», diventa «l’unica pratica possibile».
La polizia – nonostante gli sforzi del Pci di mantenere le situazioni sul piano del confronto, non dello scontro, riconoscendo quindi alle forze dell’ordine il loro compito istituzionale – è sempre più percepita come “nemico” di classe perché al servizio del “nemico di classe”. Una polizia, cioè, che non è affatto “al servizio del cittadino” (di tutti i cittadini) ma di una parte di essi, quelli che detengono il potere economico e politico. Quando scoppia la bomba a Brescia, la polizia è immediatamente emarginata dal servizio d’ordine del sindacato, e lo sarà ancor di più il giorno del funerale, quando a dividersi la piazza saranno la sinistra storica – sindacato compreso – e la sinistra rivoluzionaria, con la televisione costretta, per la prima volta, a irradiare nelle case degli italiani la rabbia popolare contro i papaveri di uno Stato impotente, incapace, complice. Se la bomba di piazza Fontana aveva raggiunto, almeno in parte, l’obiettivo, e cioè spostare a destra la barra della politica italiana, quella di piazza della Loggia ottiene un risultato opposto.
Sul piano della sinistra storica, nelle elezioni amministrative del 1975 il Pci conquista un successo sismico nei confronti di un palazzo ormai fatiscente; su quello della sinistra rivoluzionaria, la mobilitazione si moltiplica, seppur con “desideri” molto diversi, coagulandosi attorno alla (comune) parola d’ordine dell’antifascismo militante, spingendo anche molti giovani della Fgci (Federazione giovanile comunisti italiani) al «gran rifiuto» del compromesso storico, percepito come consegna definitiva dell’idea comunista nelle mani della Democrazia cristiana. Non a caso dall’area bresciana e bergamasca proverranno molti giovani destinati a confluire nelle Brigate rosse. E in Prima linea, quando questa formazione si costituirà. Una collera, quella giovanile, che aumenta dopo il fallimento delle organizzazioni della “nuova sinistra”. «Non abbiamo più niente compagni, siamo orfani – scrive dolorosamente Lotta continua –. Il mondo si è ristretto, l’orizzonte è più piccolo». Lc crollerà anche sotto i colpi dei ferri da maglia delle femministe: «Sputiamo su Hegel – urlano dalle righe di un manifesto –. La dialettica servo-padrone è una regolazione di conti tra collettivi di uomini: essa non prevede la liberazione della donna, il grande oppresso della civiltà patriarcale. [...] L’uomo ha sempre parlato a nome del genere umano, ma metà della popolazione terrestre lo accusa ora di aver sublimato una mutilazione». Dopo la chiusura della “bottega politica”, quella del giornale rimarrà aperta fino al 1982 e nel periodo di sbando più acuto (cioè subito dopo il congresso di Rimini, che sancisce lo scioglimento dell’organizzazione) «Lotta continua» verrà subissata da lettere disperate dei suoi militanti e simpatizzanti. In una di esse la parola “morte” compare ogni dieci righe. In quella, l’ultima, scritta dalla caserma in cui assolveva la leva militare il ventiduenne suicida Marco, si legge: «non è stato il rifiuto della vita ma l’impossibilità di vivere, di vivere la mia vita, la mia realtà a farmi scegliere la morte». Uno sbando che trova presto naturale sfogo nella rabbia. Un furore devastante che travolge anche le liturgie più care del mondo giovanile, quali la musica e la festa. Il Festival del Proletariato giovanile di Parco Lambro dell’estate 1976 naufragherà – come denuncia sul «Corriere della Sera» del 29 giugno 1976 Giulia Borgese – «fra l’odore aspro dei candelotti lacrimogeni, una gran puzza di sudore e immondizie [...]. Viene in mente l’epoca d’oro di simili manifestazioni [...] carni arrostite sul greto, fuochi alla sera, molta musica e un paese che dopo il primo stupore era diventato così bonario da mescolarsi pacificamente agli hippies [...] oggi siamo quasi alla guerra, certo all’ansia e alla nevrosi. Gli hippies non ci sono più da un pezzo. Gli abitanti del quartiere dicono: “ci vorrebbe la mitraglia”. Non ci sono più neanche gli extraparlamentari».
La lotta armata diventa dunque una prospettiva concreta: l’unica per molti giovani. Fra essi, quel Walter Alasia che morirà a 20 anni, dopo aver ucciso due poliziotti. La sua era una famiglia operaia di Sesto San Giovanni: all’epoca, la “Stalingrado d’Italia”. «Walter – racconta suo fratello Oscar – era cambiato di colpo, aveva cambiato di colpo atteggiamento, diventando evasivo, e non frequentando più neppure gli amici di Lotta continua, da cui s’era ormai definitivamente staccato. Non parlava più di politica a casa. Neppure con mia madre. Prima scherzava spesso con lei. La rimproverava. Diceva che era una serva del capitale con la tessera del Pci. Spesso non cenava neppure più con noi, aveva altri orari, poi lavava i piatti e metteva in ordine». Walter era cambiato da quando era diventato un militante delle Briga...