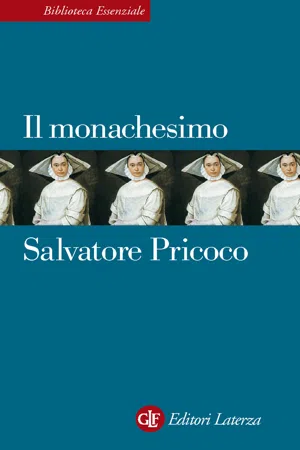
- 164 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Il monachesimo
Informazioni su questo libro
La fuga dal mondo, l'ascesi, il cenobio, le Regole: radici, forme e storia del monachesimo dal rigoglio dell'antico Egitto alla crisi dei nostri giorni.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Argomento
Teologia e religioneCategoria
Storia del cristianesimoSpecie e forme della condizione monastica
1. Le specie monastiche
Eremitismo e cenobitismo sono, come si è già avuto modo di dire, le due forme principali della vita monastica. Forma originaria, e caratteristica primaria del monachesimo universale, da quello indiano, bramanico o buddista a quello cristiano, suole essere considerata la condizione dell’asceta che vuole vivere ‘solo’, celibe e libero da ogni coinvolgimento nella società, fisicamente distaccato da ciò a cui rinuncia. A essa si suole dare il nome di anacoretismo (dal termine greco anachòresis, che propriamente è il trasferirsi da luoghi abitati nella solitudine della chòra, il territorio extra-urbano), o di eremitismo (dai vocaboli greci eremìtes e erèmos, entrati nell’uso monastico solo attraverso l’uso latino). Il cenobitismo (dal greco koinòs bìos, «vita comune») è il genere di vita religiosa di coloro che vivono insieme, raccolti in un medesimo luogo e praticando un analogo regime di vita. L’ascetismo solitario può atteggiarsi in maniera diversa: può essere stanziale o itinerante, può tradursi in solitudine completa, quella dell’eremita che rifugge da ogni compagnia, o parziale, quella dell’asceta al quale si affianca un giovane discepolo o un minuscolo gruppo di seguaci. Il distacco può anche volere essere il più radicale possibile e tradursi in xenitèia, cioè nella scelta di un paese nel quale l’asceta viva da straniero.
La nozione di unità e solitudine originariamente presente nel termine «monaco» (dal greco mònos, «solo», ma anche «uno»; lat. solus e unus) ha dato lo spunto per un’interpretazione delle origini del monachesimo cristiano e della sua prima fenomenologia. Il monaco è colui che impronta la sua vita all’unità, consacrandola interamente al servizio di Dio. È colui che non ha l’anima «doppia», ma ha – come vuole la Bibbia – un unico cuore, poiché non si impegna in più attività. È colui che evita ogni molteplicità e dispersione, poiché tende – secondo una dottrina di origine ellenica, platonica, neoplatonica e largamente sviluppata nella gnosi – a unirsi all’Uno. Dalla ricerca dell’unità deriva il primo e ineludibile requisito della condizione monastica, cioè il celibato, che, affrancando da obblighi verso la famiglia, assicura l’amerimnìa, cioè l’assenza di cure e preoccupazioni quotidiane. Dallo stato celibatario e dall’amerimnìa che ne è il frutto discendono gli altri fondamentali caratteri, l’anachòresis e l’apotaghè o apòtaxis, la «rinunzia», cioè la pratica di quelle forme di vita ascetica che favoriscono la concentrazione e proteggono dalla dispersione delle forze mentali e spirituali.
I primi teorici della vita monastica – in particolare Basilio, il grande vescovo di Cesarea autore, accanto alle opere teologiche, anche di fondamentali scritti monastici, ed Evagrio Pontico, i cui trattati avrebbero avuto grande influenza prima che egli venisse sconfessato per i suoi debiti verso il pensiero di Origene – indicarono le radici di questa dottrina nella Sacra Scrittura, nel Vecchio come nel Nuovo Testamento. Con radicale forzatura Basilio interpreta in senso monastico l’avvertimento rivolto in Geremia (16, 1-4) al profeta a non prendere moglie né generare figli, perché essi periranno di morte straziante e non saranno né compianti né sepolti. San Paolo nella Prima lettera ai Corinzi (7, 32-33), pur concedendo che ricorrano al matrimonio coloro che non riescano a vivere in continenza, esalta il celibato, che mantiene amerìmnoi, sine sollicitudine, «liberi da preoccupazioni» per le cose del mondo e solleciti solo delle cose del Signore. I discepoli di Paolo, coloro che mettendone in pratica gli insegnamenti seppero vivere in castità, solleciti solo delle cose del Signore, avrebbero così messo in pratica un ideale ascetico e monastico, compiutamente e ripetutamente delineato nella Bibbia e congenito dunque alla «essenza del cristianesimo».
Secondo alcuni antichi scrittori cristiani la forma originaria dell’esperienza monastica è quella cenobitica e nasce con il cristianesimo stesso. Essi si rifanno al racconto degli Atti degli Apostoli (4, 32), secondo il quale i primi cristiani raccoltisi a Gerusalemme, dopo la morte di Gesù, misero in comune i loro beni e vissero insieme sotto la guida di san Pietro, realizzando così la prima e perfetta forma di vita monastica. Nell’Occidente questa dottrina fu sostenuta da san Gerolamo e da sant’Agostino, ripetutamente e più riccamente da Cassiano. Questi, muovendo da altri passi degli Atti (15, 1 sgg.: sulle controversie nate a Gerusalemme e ad Antiochia riguardo alla circoncisione e sull’allargamento della Chiesa ai Gentili), volle spiegare l’origine delle varie forme di monachesimo dei suoi tempi, ben lontane dall’originaria perfezione apostolica, e sostenne che, quando la fede aveva preso a declinare e i costumi a decadere, i cristiani più retti e devoti si erano sottratti al contagio della massa, appartandosi in luoghi solitari, lontano dalle città, e dando così vita, a imitazione dell’antica comunità gerosolimitana, al monachesimo cenobita. Da questo poi, assai più tardi, con l’abate Paolo e con Antonio, sarebbero derivate una seconda specie di santi, quella degli anacoreti, come fiori e frutti da una radice fecondissima, ma anche, degenerando, una terza specie di monaci, quella dei sarabaiti, infedele e malvagia, che volge al male la professione monastica e rinverdisce la mala pianta di Anania e Safira, recisa al tempo degli Apostoli dalla severità di Pietro.
L’interpretazione cassianea dell’antica storia monastica come un susseguirsi di fasi degenerative rispetto al modello gerosolimitano e di reazioni volte a recuperare quel modello ebbe immensa fortuna nella tradizione medievale, costantemente segnata dalla nostalgia delle origini, e la sua distinzione di tre tipi di monaci, che già Gerolamo aveva delineato nella celebre lettera 22, a Eustochio, fu accolta dal Maestro e da Benedetto, nel capitolo iniziale delle loro regole. I tipi di monaci diventano quattro, due legittimi, anacoreti e cenobiti, due condannabili e detestabili, girovaghi e sarabaiti. Di fatto i due legislatori predicano senza riserve il primato dei cenobiti, il «fortissimo genere di quelli che vivono nella comunità», che si sostengono e si controllano gli uni con gli altri. Il genere degli anacoreti, «che vivono in solitudine nei deserti», è un genere di vita altissimo, il culmine della ascesi cristiana, ma quasi inattingibile per le difficoltà che presenta e i rischi a cui espone. Gli altri due generi sono fatti di monaci indegni, impostori, insofferenti di qualunque disciplina, sempre in giro a lucrare favori e scroccare elemosine. È lunga e irridente la polemica del Maestro nei confronti di gyrovagi e sarabaitae, cioè di monaci peregrini; è rapida ma non meno perentoria la condanna di Benedetto.
Attraverso una complessa evoluzione istituzionale e ideologica, che da Pacomio conduce a Benedetto, si precisano i modelli della vita monastica e il loro fondamento normativo: la condanna di ogni forma di monachesimo non regolare, l’accettazione teorica del modello eremitico ma la sua reale rimozione, il primato della vita cenobitica, garantita dalla stabilitas, cioè dalla permanenza a vita nel medesimo monastero, e dalla irrevocabilità del voto monastico. Ma prima che si arrivi a un’osservanza generalizzata e ispirata ad analoghe norme di condotta le situazioni permangono per secoli estremamente frazionate e diverse. E sempre, accanto all’istituzione cenobitica o in opposizione a essa, resteranno forme di ascetismo solitario, spontaneo, carismatico, a volte riconosciuto e accettato come forma ‘altra’, più spesso rifiutato e combattuto come eslege, destabilizzante o, addirittura, eretico.
2. L’eremitismo
L’istanza eremitica è una componente perenne del monachesimo, in tutte le religioni. Dialetticamente opposta al bisogno della koinonìa, della vita trascorsa in una struttura comunitaria dalla quale trarre norme e sostegno per il perfezionamento spirituale, nasce dal bisogno di sentirsi liberi e ‘soli’ per realizzare quel perfezionamento. Essa si manifesta tanto più forte e rifiorente quanto più viene avvertita l’esigenza di reagire contro l’irrigidirsi dell’esperienza monastica in forme convenzionali o il suo decadere per la corruzione dei costumi e la perdita dei primitivi ideali. Nella tradizione cristiana sono innumerevoli i sostenitori dell’una forma contro l’altra. I fautori della vita cenobitica sottolineano i rischi della solitudine, gli eccessi dell’orgoglio e del fanatismo ascetico ai quali essa può condurre; gli altri allertano sulla pigrizia spirituale e lo smarrimento di ogni ideale tensione che facilmente si originano dalle troppe comodità e mediocrità della condizione cenobitica. In effetti è accaduto spesso che le effervescenze carismatiche del monachesimo trovassero sbocco in iniziative di tipo anacoretico, e che proprio quei monaci che si sentivano investiti di una speciale missione e perciò bisognosi di libertà e mobilità lasciassero il convento e scegliessero forme di vita solitaria.
Nella storia religiosa dell’Europa ci sono stati momenti nei quali l’inquietudine sociale e l’ansia di rinnovamento spirituale hanno fatto dell’eremitismo una vera e propria alternativa al cenobitismo. Uno di essi è rappresentato dai secoli XI-XII, quando alla crisi dell’economia feudale e al rifiorire di quella cittadina si accompagnò, assieme alle sempre più pressanti istanze di riforme religiose e di ritorno all’evangelismo monastico, la crisi della forma cenobitica. L’esistenza di solitari che si sono allontanati dalla famiglia o dal cenobio, talvolta dal clero secolare, per vivere nei boschi viene segnalata in tutto l’alto Medioevo. All’inizio del V secolo nel nascente cenobio di Lérins, come testimonia Eucherio nel suo Elogio dell’eremo, abitavano in disparte dalla comunità i solitari che volevano vivere secondo i costumi degli Aegyptii patres. Nel secolo successivo la comunità fondata da Cassiodoro a Squillace prevedeva nella parte più alta del colle sul quale sorgeva il cenobio un sito riservato agli eremiti. Nel secolo XI e, più ancora, nel XII, il fenomeno dilaga. Nelle Fiandre e nella Francia le masse popolari sono infiammate dalla predicazione degli ‘uomini santi’, che indossano tuniche di pelle, si nutrono di erbe e di radici, e predicano la fuga dal mondo come unico rimedio all’oppressione dei poteri politici e alla corruzione di quelli ecclesiastici.
L’Italia ha avuto grandi figure di eremiti, come il ravennate san Romualdo (m. 1027), il quale, dopo anni passati in convento, a Ravenna e a Cuxá, sui Pirenei, deluso dell’allentata disciplina cenobitica, rinunziò alla carica di abate e andò peregrinando per l’Italia centrale, nelle Marche e in Romagna. O come Bruno, nato a Colonia e per anni maestro nella scuola di Reims, il quale nel 1084 fondò un eremo destinato a grande sviluppo nella valle della Chartreuse, vicino Grenoble, e pochi anni dopo, nel 1091, si ritirò sulle Serre calabresi, nelle estreme propaggini meridionali dell’Appennino, a cavallo tra Ionio e Tirreno. Anche san Francesco previde per i suoi confratelli la possibilità di condurre vita eremitica e compilò per loro una rapida raccolta di norme, De religiosa habitatione in eremo.
I modelli orientali, mai dimenticati, esercitano attrazione crescente. Come al tempo degli antichi eroi del deserto, anche ora gli eremiti più venerati sono quelli nei quali appaiono più marcate la spiritualità del penitente e le rinunzie dell’asceta. Più ancora dell’antico, questo nuovo eremitismo è contrassegnato da forme radicali di deprezzamento delle realtà terrestri, da una visione teocentrica del mondo che si traduce in escatologismo apocalittico, da un ascetismo spinto fino alla sordidezza e alla mortificazione umiliante. Tuttavia, assai spesso accade che questi convintissimi zelatori della vita ascetica e contemplativa si preoccupino dell’altrui oltre che della propria salvezza, conducano vita di attivo apostolato soccorrendo i viaggiatori, i poveri, i reclusi, si spostino in paesi anche lontani per predicare: sarà un eremita, è noto a tutti, a bandire la prima Crociata.
Per queste ragioni non raramente nell’esperienza eremitica il momento individuale ha breve durata. Quanto più appare santo e venerabile, tanto più l’asceta solitario attira devoti e aspiranti, li riunisce attorno a sé, dà vita a una nuova fondazione monastica, riconduce, cioè, a forme di vita cenobitica. Fondazioni eremitiche come quelle di Camaldoli e di Vallombrosa associano forme di eremitismo e cenobitismo e nuovamente, come a Lérins o a Squillace, prevedono la compresenza di monaci che dimorano e lavorano insieme e di solitari che vivono in una completa segregazione, interrotta solo dall’obbligo di consumare i pasti in comune. Camaldoli, nei pressi di Arezzo, fu installata da san Romualdo, che fondò o riformò numerose altre comunità, nelle quali volle che fosse prevalente su quella cenobitica la struttura eremitica, al punto da stabilire che l’unico superiore della comunità risiedesse fra gli eremiti, non nel cenobio. Vallombrosa, nel comune di Reggello presso Firenze, fu fondata dal fiorentino Giovanni Gualberto (m. 1073), anch’egli pellegrino dopo anni di deludente vita cenobitica e anch’egli fattosi fondatore di nuove comunità con il progetto di ritornare alla spiritualità e ai costumi degli antichi solitari.
Una fondazione eremitica che si è tramutata in un vero e proprio Ordine monastico, quello dei Certosini, e che ha segnato per secoli la storia del monachesimo europeo, fu la Chartreuse fondata da san Bruno, nella quale sia il fondatore sia i suoi successori cercarono di tutelare le esigenze di solitudine e libertà spirituale proprie dell’opzione eremitica, pur mantenendo i princìpi fondamentali della koinonìa cenobitica, cioè la stabilità del monaco e la sua piena sottomissione all’autorità del priore. Il monaco certosino dispone di una cella individuale, nella quale resta chiuso l’intera giornata; in essa legge, prega, medita, e non ne esce neppure ai pasti, ma solo per l’ufficio divino. Non era soltanto una modificazione delle strutture abitative del cenobio, volta a realizzare il passaggio dal dormitorio comune e dal grande refettorio alla celletta singola, ma una grande riforma del costume monastico, orientata alla riconquista di una religiosità personale e fondata sul concetto che importanti fossero, nella via della salvezza, non l’osservanza delle liturgie e la pratica rituale, ma il colloquio e il contatto spirituale con il divino.
Anche nei secoli successivi, nel XIV e nell’età rinascimentale, l’eremitismo si mantenne vivace in tutto l’Occidente, dove si moltiplicarono i piccoli eremi, disseminati nelle foreste, sulle montagne, nelle isole. Fiorirono numerosi in Spagna, nella Navarra, nella Catalogna a Montserrat, dove si ritirerà ai tempi della conversione Ignazio di Loyola. Scompariranno, invece, a partire dal secolo XVI nelle regioni passate al protestantesimo. Ma anche altrove contro la vocazione eremitica congiureranno le istanze proprie della società moderna e della civiltà industriale, il razionalismo e il pragmatismo, il legalismo giuridico, i nuovi assetti del territorio. Senza dimenticare la sfiducia della stessa Chiesa, che all’eremitismo ha guardato sempre con sospetto. Fin dall’antichità i concili provinciali intervennero per limitare e controllare la libertà degli eremiti e, quando non la vietarono, le opposero cautele e impedimenti vari. Ai monaci non fu permesso di ritirarsi in un eremo se non dopo avere vissuto per anni nella comunità; il permesso fu in genere accordato solo ai monaci di provata virtù e di età avanzata («giovane monaco, vecchio diavolo», recitava un adagio popolare); anche gli eremiti restavano sotto la giurisdizione dell’abate. Quando l’aspirante alla vita solitaria era un laico, la legislazione canonica gli imponeva di chiedere l’autorizzazione al vescovo della diocesi, la quale gli conferiva una sorta di tutela ecclesiastica. Senza di essa l’eremita restava sottomesso alla giurisdizione civile, tendente a considerarlo uno sbandato e un asociale. Non raramente i vescovi si rifiutavano di ammettere eremiti nelle loro diocesi. Più volte, nei momenti di più vivace efflorescenza, sono intervenuti i papi. Nel 1256 Alessandro VI riunì un gran numero di piccoli gruppi di carattere eremitico nell’Ordine degli Eremiti di sant’Agostino, che si diffuse in tutta l’Europa ma andò cancellando rapidamente gli originari caratteri eremitici dei gruppi. Nel 1748 il papa Benedetto XIV dedicava agli eremiti un capitolo del rinnovato trattato di diritto canonico, riorganizzando sotto il controllo rigoroso dell’autorità ecclesiastica i gruppi esistenti, ma senza prevedere l’eventualità di nuove aggregazioni. Il Corpus canonico del 1917 considera e regolamenta solo le forme comunitarie della vita religiosa, mentre vi sono ignorati ed esclusi gli eremiti.
Anche per questo, per anni l’eremitismo è sembrato definitivamente scomparso dalla scena religiosa dell’Occidente, e solo negli ultimi tempi, dopo il concilio Vaticano II, ha dato segni di risveglio. I canonisti gli hanno ridato attenzione, ma il riconoscimento ecclesiastico si è risolto solo in una particolare forma di esclaustrazione, ad nutum Sanctae Sedis, cioè nel permesso, accordato dall’autorità ecclesiastica per un tempo limitato, di lasciare il cenobio e vivere in segregazione.
3. Il cenobitismo
Interrotta, come abbiamo visto, da periodi di forti rinascenze anacoretiche, è costante nella storia del monachesimo la tendenza ad accentuare le forme comunitarie a spese degli spazi di libertà individuale. La compressione ...
Indice dei contenuti
- Introduzione
- A grandi linee
- I caratteri generali
- Specie e forme della condizione monastica
- Il monachesimo femminile
- I codici del cenobio
- Spazio e tempo
- I segni dell’appartenenza
- Nota bibliografica
- L’autore
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a Il monachesimo di Salvatore Pricoco in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Teologia e religione e Storia del cristianesimo. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.