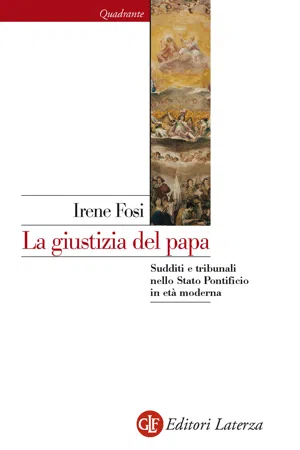
eBook - ePub
La giustizia del papa
Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio in età moderna
- 244 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Tra Sette e Ottocento si crea e si rafforza una sorta di leggenda nera sulla giustizia del papa, espressione della generale decadenza italiana. Ma quale era veramente il rapporto con i tribunali laici ed ecclesiastici di uomini e donne comuni, di nobili, di religiosi e di intere comunità soggette al potere papale? Scavando nel ricco materiale inedito degli archivi giudiziari, negli atti dei processi e in numerosi carteggi dell'epoca, Irene Fosi ricostruisce le sfaccettature del governo della giustizia, percorsi individuali e vicende esemplari. Si disegna così un quadro sfumato e complesso, dove trovano spazio violenza e repressione, moderazione e clemenza.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a La giustizia del papa di Irene Fosi in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Teologia e religione e Storia moderna. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
Teologia e religioneCategoria
Storia modernaCapitolo IX. Disciplinare il clero
«Questi giorni passati una notte [Monsignore] menò seco da Rapolano con alcuni giovani senesi doi donne giovani con la sua madre in Siena et pose in un Monastero della città la minore. L’altra giovane è vedova e se dice de certo ch’è gravida del detto Monsignore».
Il 4 febbraio 1568 così il Capitano di giustizia di Siena forniva sommarie, ma sufficienti notizie sul sospetto rapimento perpetrato dal cardinale Ippolito Del Monte, dissoluto nipote adottivo di Giulio III1. Qualche decennio più tardi sarebbero stati solo un ricordo comportamenti scandalosi come quelli del cardinal Del Monte? Forse erano meno eclatanti, più nascosti, relegati spesso in zone marginali, nelle campagne, nelle montagne. Infatti, come si è visto in precedenza, ricordando solo alcuni esempi, il controllo degli apparati giudiziari, laici ed ecclesiastici, lascia intravedere, anche nello Stato Pontificio, significative differenze fra centro e periferia e fra città e campagna. Anche intorno a Roma – nel deserto della campagna romana e sulle pendici collinari e montuose dei territori circostanti – la cura delle anime era lasciata, ancora nel Seicento e nel Settecento, in mano a personaggi ben lontani dal modello tridentino. Il problema della moralità, della ignoranza del clero era avvertito nella curia romana in tutta la sua gravità. Non erano mancati gli interventi, anche molto duri, di pontefici come Pio IV e Pio V contro chierici delinquenti in particolare contro sodomiti, simoniaci, concubini2. Differente era poi la percezione di questi comportamenti irregolari, addirittura criminosi, da parte dei fedeli3. Per le congregazioni romane, il crimine commesso da ecclesiastici, il loro comportamento scandaloso veniva infatti a ledere il progetto di controllo delle anime affidato alla figura sacerdotale, comprometteva l’armonizzazione della vita comunitaria, la regolata scansione delle tappe dell’esistenza individuale e collettiva affidata al parroco. Il controllo sul clero attivò tutte le possibili energie delle congregazioni romane, come quella dei Vescovi e Regolari, e coinvolse in un’azione comune, anche se non priva di attriti, la giustizia laica ed ecclesiastica4.
Dalla fine del Cinquecento e per tutto il secolo successivo, l’opera del Sant’Uffizio intervenne pesantemente per correggere il comportamento deviante del clero regolare e secolare. Il sacro tribunale, però, non era solo in questo compito fondamentale di estirpare alla radice una condotta non più conforme ai dettami tridentini, cancellare una religiosità intrecciata a forme di superstizione e magia, sanare un’ignoranza dogmatica che poteva anche dare adito a fondati sospetti di eresia. Le numerose congregazioni istituite o riformate da Sisto V nel 1588 avevano come scopo quello di rendere idonei gli ecclesiastici a svolgere le loro funzioni di governo spirituale. Ma nei domini temporali pontifici ciò significava anche essere capaci di realizzare il buon governo. La preparazione alla carriera ecclesiastica serviva infatti per ottenere buoni «ministri», per inviare nelle diverse parti dello Stato degni rappresentanti del potere romano, per creare consenso in periferia. Tribunali «laici» ed ecclesiastici facevano convergere i loro sforzi in questa direzione per correggere, punire, educare il clero, destinato, nello Stato Pontificio, non solo al governo delle anime.
1. «Con grave scandalo del Populo»
Un esame dei decreti, ma anche dei processi conservati, mostra inequivocabilmente come la condotta del clero, e in particolare di alcuni ordini religiosi, come ad esempio i cappuccini, fosse al centro delle preoccupazioni e degli sforzi del Sant’Uffizio sia nello Stato Pontificio sia negli Stati italiani. Se Roma poteva essere meglio controllata, sebbene non mancassero scoraggianti descrizioni dei costumi del clero, della disciplina nei monasteri, dei disordini che si registravano quotidianamente e che avevano per protagonisti ecclesiastici secolari e regolari, il controllo nelle province, nelle campagne, nelle zone marginali, invece, si era presentato, fin dall’inizio, estremamente problematico. Tuttavia, alla fine del Cinquecento, le preoccupazioni per l’ondata di banditismo che stava travolgendo molte zone dello Stato Pontificio crearono condizioni favorevoli anche per poter intervenire nel disciplinamento del clero, accusato troppo spesso di connivenza e di favoreggiamento dei fuorilegge. Così non erano rare le accuse di «ricettazione e pratica di banditi» rivolte a religiosi, parroci di comunità di campagna, ma anche a esponenti di ordini mendicanti, che portavano poi gli accusati davanti al Sant’Uffizio per altri crimini. Nel 1591, fra’ Felice da Mogliano, nella diocesi di Fermo, era stato condotto al Sant’Uffizio per aver predicato «et sfacciatamente havuto ardire sopra quelle parole di San Paolo» che Cristo, asceso in cielo, «avrebbe preso forma fantastica senza altra dichiaratione»; ma soprattutto si faceva notare, in una lettera ai cardinali della congregazione, che era stato messo in prigione perché era stato «secondariamente fautore grandemente di banditi et che sia il vero è stato esiliato dallo stato di Nostro Signore senza haver havuto punto di penitenza»5. Anche il parroco Angelo Nardino di Capradosso venne imprigionato nel 1592 con l’accusa di «ricettazione e pratica di banditi». Durante la perquisizione, in casa furono trovati, nei vasi per la cresima, «un pezzo di osso abbruciato, due pezzetti di pietra bianca che dicono esser calamita, et un’altra pietruccia involta in una carta che non si conosce che sia. Nella detta sacchetta erano involte diverse chiavi e grimaldelli». L’inquisito negò di conoscere la natura e la funzione di tali reperti, come da Ascoli scriveva perplesso il vescovo di Cervia alla congregazione, in attesa di ricevere indicazioni su come procedere nei confronti del parroco6. Le numerose lettere che giungevano alla congregazione romana riguardavano soprattutto i Regolari. Da Anguillara, nel 1610, era giunta la denuncia contro i frati zoccolanti del luogo che «danno la lavatura delli loro piedi alle persone et dicono che è cosa buona per guarir il bestiame dal male»7. Nelle lettere dei vescovi frequenti sono i richiami alle denunce degli abitanti contro ecclesiastici scandalosi. Gli ordinari diventano latori di un malcontento che può degenerare, turbare l’ordine e, sicuramente, mettere in pericolo la loro stessa reputazione e l’autorità che rappresentano. Agiscono però con prudenza, talvolta con eccessiva lentezza. In altri casi, come abbiamo visto, le indagini della congregazione sono avviate da denunce di giusdicenti, governatori, rappresentanti degli organismi di governo delle comunità locali: la delinquenza di chierici, la vita scandalosa viene sempre più avvertita come un elemento di disturbo dell’ordine. Ma questo non portò, come immediata conseguenza, una generalizzata moralizzazione, un adeguamento alle direttive e ai modelli tridentini. Rimanevano evidenti profonde difficoltà – soprattutto nelle campagne, nelle province più lontane, nei conventi come nelle parrocchie –, che da Roma si cercava, invano, di superare.
Non era però solo il Sant’Uffizio a preoccuparsi della scarsa moralità degli ecclesiastici. La «vita scelerata et pessima con grave scandalo del Populo» condotta da qualche parroco costringeva, talvolta, i rappresentanti di comunità locali a rivolgersi direttamente ad autorità romane, centrali, diverse dall’ordinario diocesano, ritenuto colluso o incapace di provvedere energicamente a eliminare in maniera definitiva i perniciosi esempi. Un caso turbò, alla fine del Cinquecento, la comunità di Trevignano, feudo di Virginio Orsini, signore di Bracciano. Il parroco, Antonio Benedetto Antino, macchiatosi di diversi crimini, era già stato condannato nel 1596 dal vescovo di Sutri e Nepi, Orazio Moroni. Le pene comminate non erano riuscite a redimere l’uomo che, tornato a Trevignano, aveva cominciato di nuovo a dare scandalo. Nel 1598 il duca Virginio Orsini aveva permesso ai priori della comunità di rivolgersi direttamente al Tribunale del governatore di Roma «non essendo [il parroco] sottoposto al tribunale di Sua Eccellenza per essere chierico». Così i Priori vergarono un dettagliato memoriale al Governatore nel quale si ripercorreva «tanta mala et pessima vita». Il chierico delinquente
che per molti suoi enormi delitti è stato più volte processato dal vicario del Vescovo di Sutri ad instantia de’ particolari della Terra et mai gastigato per mantenersi sempre amici detti Vicarii con presenti et corteggiamenti et al fine la Comunità, non potendo più sopportare la sua pessima vita, ricorse in Roma et ottenne che in Trevignano andasse un commissario contro detto chierico contro il quale furono sporte molte querele et massime un abhorto, latrocinii, impedimenti di matrimonii et altri scandali.
Una donna, complice dei suoi crimini, condotta in prigione a Sutri, poi «mediante un poco di tortura fu liberata», mentre al chierico fu dato il confino a Roma con l’obbligo di servire negli ospedali di San Giovanni in Laterano e della Consolazione, obbligo per altro mai osservato perché, come ricordavano i Priori,
è stato sempre in Trevignano dove peggio che prima ha tenuto et tiene vita scelerata et pessima con grave scandalo del popolo continuamente con risse hor con l’uno hor con l’altro, et commetter furti, batter publicamente donne che non voglion consentire alle sue voglie8.
Aveva inoltre rubato le rendite dei luoghi pii e «bravato» gli stessi uomini dell’Orsini. Era stato proprio Virginio Orsini che, forse, per timore di compromettere l’immagine del suo potere colpito dalle conseguenze dello scandalo e di essere accusato di connivenza, aveva permesso alla comunità di rivolgersi all’autorità del Governatore di Roma. Era un atto significativo che schierava il barone romano a sostegno dell’azione moralizzatrice di Clemente VIII, attento a reprimere comportamenti nobiliari trasgressivi, come testimoniano le note vicende di Beatrice Cenci o di Troilo Savelli, ma impegnato anche a controllare più da vicino le comunità e i territori in mano ai feudatari. Le sinergie pontificie e baronali dovevano sanare le carenze di un potere vescovile incerto, condizionato da legami con il territorio, con giusdicenti laici ed ecclesiastici corrotti o incapaci, ben lontani, comunque, dai modelli tridentini che si cercava di imporre.
2. «Vinti dalla passione et accecati dal Demonio»
Delicato, valutato con cautela, ma punito con durezza, era il caso di religiosi sui quali pesava l’accusa, o semplicemente il sospetto, de attentata sodomia cum pluribus pueris. La presenza dei chierici, secolari e regolari, fra chi commetteva crimini nefandi e abusi sessuali non è sporadica fra le carte processuali, non solo dell’Inquisizione, e certo rappresenta il difficile problema del disciplinamento del clero verso il quale la Chiesa post tridentina diresse tutti i suoi sforzi. Veniva infatti a deludere le attese dei fedeli verso figure fondamentali dell’ordine, come quella del parroco, ma anche degli insegnanti, cui era affidata l’educazione dei giovani. La comune sensibilità verso comportamenti illeciti tenuti da ecclesiastici non si presenta uniforme nel corso dei primi secoli dell’età moderna, poiché si modula anche a seconda dei luoghi e, ovviamente, della gravità degli atti stessi. I sommari dei processi esaminati dalla congregazione romana si collocano in un arco temporale limitato: tardo Seicento e inizio Settecento. Carattere, questo, che non può indurre a sostenere che tali crimini fossero più denunziati o più perseguiti rispetto al passato. La disomogeneità e la frammentarietà ascrivibili alle tormentate vicende documentarie dell’archivio del Sant’Uffizio e, ancora una volta, la natura della fonte «criminale» devono poi mettere in guardia da facili generalizzazioni, da improvvide attualizzazioni, o semplificazioni di un problema con il quale si confrontò e scontrò la volontà disciplinante della Chiesa tridentina, costretta a tener conto delle condizioni di vita, di miseria materiale, intellettuale e spirituale di quanti intraprendevano la carriera ecclesiastica. Certamente non si può affermare, sulla base delle denunzie, degli atti processuali, di tutto ciò che gli organi di giustizia ci hanno lasciato, che questo come altri comportamenti illecit...
Indice dei contenuti
- Premessa. Governare il disordine
- Capitolo I. Una complessa geografia
- Capitolo II. I tribunali romani in età moderna
- Capitolo III. La «nuova» Inquisizione e la città del papa
- Capitolo IV. Il «teatro» della giustizia
- Capitolo V. Nobiltà inquieta
- Capitolo VI. Collaborazione e conflitti: governatori, vescovi, inquisitori
- Capitolo VII. Peccati e reati
- Capitolo VIII. Dentro la famiglia
- Capitolo IX. Disciplinare il clero
- Capitolo X. Il «buon governo» fra utopia e realtà
- Capitolo XI. «Piccole patrie»: identità locale e potere centrale
- Capitolo XII. Fiumi di inchiostro: suppliche, memoriali, lettere
- Capitolo XIII. Giustizia rappresentata, giustizia raccontata
- Elenco cronologico dei papi (1492-1758)