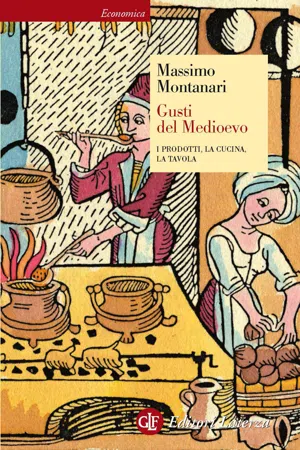Capitolo 1. Medioevo vicino, Medioevo lontano
La cucina «medievale» oggi è di moda. Ma come si può presumere di ricostruire il gusto alimentare di sei, sette o magari dieci secoli fa?
La domanda, e di conseguenza la risposta, in realtà si pongono su due piani diversi. Il primo è quello del gusto inteso come sapore, come sensazione individuale della lingua e del palato: esperienza per definizione soggettiva, sfuggente, incomunicabile. Da questo punto di vista l’esperienza storica del cibo è inevitabilmente, irrimediabilmente perduta.
Ma il gusto è anche sapere, valutazione sensoriale di ciò che è buono o cattivo, di ciò che piace o dispiace. Valutazione che viene dalla mente prima che dalla lingua – il cervello, non la lingua è l’organo del piacere gastronomico – perché bisogna che qualcuno ci abbia insegnato a distinguere e classificare in quel modo i sapori: buono/cattivo, piacevole/spiacevole, gustoso/disgustoso. Da questo punto di vista il gusto non è affatto una realtà soggettiva e incomunicabile, bensì collettiva e comunicata. È un’esperienza di cultura che ci viene trasmessa fin dalla nascita, legata a tutte le altre variabili che concorrono a costituire i “valori” di una società. Un grande storico della cucina, Jean-Louis Flandrin, ha coniato l’espressione «strutture del gusto» proprio per sottolineare il carattere collettivo e condiviso di tale esperienza. Ed è chiaro che questa seconda dimensione, che non coincide con la prima, ma in larga misura la condiziona, si può indagare anche storicamente, esaminando i reperti, le tracce, le «fonti» (come le chiamano gli storici) che ogni società del passato ha lasciato dietro di sé.
Quali reperti? Quali tracce? Quali «fonti»?
In primo luogo i ricettari di cucina: testi di modesto valore letterario, ai quali gli studiosi, troppo occupati a indagare gli aspetti “alti” della storia, per lungo tempo hanno prestato poca o nessuna considerazione. Solo negli ultimi decenni la storia dell’alimentazione e della gastronomia è stata annessa, non senza tenaci resistenze, nel pantheon della problematica storica, e un pugno di ricercatori si è lanciato, meno timidamente che in passato, a esaminare questi testi e a ricercarne di nuovi negli archivi e nelle biblioteche di mezzo mondo. Con risultati sorprendenti: molte decine di ricettari sono emersi fra i codici manoscritti, completi o frammentari, soli o mescolati ad altri testi (per lo più di medicina e di dietetica), rivelando, almeno per gli ultimi secoli del Medioevo, il XIV e il XV, in qualche caso già il XIII, una mole di materiale documentario di cui neppure si sospettava l’esistenza. Questo fiorire di ricettari, in Italia come in altri paesi europei, da un lato costituisce il punto d’arrivo di una plurisecolare esperienza di cucina, dall’altro il punto di partenza per le successive elaborazioni della cosiddetta cucina rinascimentale, fase ultima e maggiormente elaborata della tradizione medievale.
Ma non possiamo fermarci ai ricettari. La cultura gastronomica medievale emerge da molti altri testi: i trattati di medicina e di igiene (ai quali, come già accennato, i libri di cucina sono spesso mescolati nei manoscritti) dedicano largo spazio alle questioni dietetiche e al buon uso degli alimenti in funzione della salute; i trattati di agricoltura si soffermano volentieri sull’uso alimentare delle piante e degli animali; i trattati di «buone maniere» non mancano di informarci sull’estetica del cibo, della mensa e dell’apparato conviviale; i testi letterari e poetici rivelano anch’essi una grande attenzione al tema del cibo, strategicamente centrale in una società che non solo vive intensamente il problema della sopravvivenza quotidiana, ma, anche, e proprio per questo, affida al cibo la funzione di individuare e distinguere le persone e i gruppi, segnalarne lo status, il grado di ricchezza e di potere. Del resto, tutti i documenti in qualche modo riflettono le necessità e le scelte alimentari di una società: sapere che cosa, come, quando si produce o si acquista, da parte di chi (cosa che è possibile verificare grazie a documenti quali gli atti di compravendita, i patti colonici, gli inventari, gli statuti cittadini e rurali) è evidentemente significativo dei consumi e dei costumi alimentari. Si aggiungono le ricche indicazioni fornite dall’archeologia – resti di cibo, reperti ossei umani e animali, vasellame e suppellettile domestica – e dall’iconografia, spesso decisiva sotto l’aspetto funzionale e descrittivo: sistemi e tecniche di cottura, forme e dimensioni degli strumenti, modi di comportamento e rituali di tavola possono emergere da uno scavo o da una miniatura con una chiarezza e una concretezza talora maggiori che dalle fonti scritte.
Insomma, le informazioni non mancano. Che cosa possiamo dedurne circa i modi di consumo e i “gusti” del tempo? Il Medioevo è vicino o lontano?
Nel campo alimentare e gastronomico, la distanza fra il Medioevo e noi è segnata da due eventi maggiori. Il primo è la conquista dell’America da parte degli europei, episodio a dir poco sconvolgente per quanto concerne la storia dei prodotti alimentari. Nel giro di alcuni secoli il panorama delle risorse disponibili cambiò in tutti i continenti, con la rapida e spesso forzata diffusione dei prodotti americani, che si insediarono in Europa, in Africa, in Asia modificando le abitudini alimentari di milioni di persone. Per non fermarci che all’Europa, pensiamo all’impatto del pomodoro nelle cucine mediterranee, della patata in quelle continentali, per non dire del mais che assunse un ruolo di primo piano nella dieta delle popolazioni contadine, o di piante come il peperoncino che in alcune regioni europee (in particolare l’Ungheria e, da noi, la Calabria) fu adottato con tale convinzione da diventare col tempo un segno distintivo dell’identità gastronomica locale. Tuttavia, non insisterei troppo su queste nuove presenze (o assenze, se vogliamo considerarle dal punto di vista del Medioevo: sarebbe un po’ come enfatizzare l’assenza della televisione dalle case del cosiddetto uomo medievale). Noterei, invece, che questa rivoluzione dei prodotti non influenzò più di tanto i sistemi di cucina. Piuttosto li rafforzò, nel senso che servì a ribadire, più che a ribaltare, tradizioni millenarie. La patata, più produttiva, andò a sostituire prodotti tradizionali come la rapa e il navone, e servì a usi culinari anch’essi tradizionali come quello degli gnocchi, una tipica ghiottoneria medievale, che per tanto tempo si era fatta solamente con acqua e farina; addirittura, con le patate si provò a fare il pane. Analogo procedimento interpretativo nel solco della tradizione – psicologicamente e culturalmente si definirebbe una «riduzione dell’ignoto al noto» – si mise in moto per il mais, che andò a sostituire altri cereali inferiori (soprattutto il miglio) impiegati da secoli per fare la polenta, sconosciuta in America. Quanto al pomodoro, si affermò soprattutto sotto forma di salsa, essendo le salse uno dei fondamenti (un vero e proprio must) del modo di cucinare medievale. Tutto ciò non per negare l’importanza alimentare dei nuovi prodotti, ma per dire che, sul piano tecnico, essi non modificarono in profondità la cultura gastronomica europea, anzi servirono a ribadirne alcune linee portanti. La stessa America fu sfruttata in lungo e in largo per produrre alimenti prima ignoti oltre oceano, destinati ai consumatori del vecchio continente: grano, vino, olio, carne di maiale e di manzo – i fondamenti del modello alimentare europeo – comparvero allora per la prima volta in America, così come lo zucchero e il caffè, che gli europei trapiantarono assieme alle squadre di schiavi africani adibiti alla loro coltivazione. Tutti questi movimenti, se sconvolsero l’economia mondiale e la vita dei popoli, in qualche modo servirono ad assestare (più che a modificare) i gusti alimentari degli europei, così come si erano definiti a iniziare dal Medioevo.
Meno importante sul piano economico e sociale, ma più incisiva sul piano del gusto, fu una seconda rivoluzione avvenuta tra il secolo XVII e il XVIII. A un’indagine retrospettiva, che muova dall’oggi alla ricerca del Medioevo, appare subito chiaro che la nostra idea di cucina, il sistema di sapori che a noi sembra così “naturalmente” preferibile, è assai diverso da quello che per molto tempo – non solo nel Medioevo, ma ancora un paio di secoli fa – gli uomini giudicavano buono e ricercavano nei cibi. La cucina contemporanea (italiana ed europea) ha oggi un carattere prevalentemente analitico, tende cioè a distinguere i sapori – dolce, salato, amaro, agro, piccante... – riservando a ciascuno di essi uno spazio autonomo, sia nelle singole vivande che nell’ordine del pasto. A tale pratica si collega l’idea che la cucina debba rispettare, nei limiti del possibile, il sapore naturale di ciascun alimento: sapore di volta in volta diverso e particolare, da tenere, appunto, distinto dagli altri. Ma queste semplici regole non costituiscono un archetipo universale di cucina, sempre esistito e sempre uguale a se stesso: sono il frutto di una piccola rivoluzione avvenuta in Francia fra Sei e Settecento.
«La zuppa di cavolo deve sapere di cavolo, il porro di porro, la rapa di rapa», raccomandava Nicolas de Bonnefons nella sua «lettera ai maestri di casa», a metà del secolo XVII. Affermazione dall’apparenza innocente, che in realtà rovesciava modi di pensare e di mangiare consolidati da secoli. La cucina rinascimentale, quella medievale e, retrodatando ancora, quella romana antica avevano infatti elaborato un modello di cucina basato principalmente sull’idea dell’artificio e sulla mescolanza dei sapori. Sia la preparazione delle singole vivande, sia la loro dislocazione all’interno del pasto rispondevano a una logica sintetica più che analitica: tenere insieme più che separare. Ciò rispondeva ai dettami della scienza dietetica, che riteneva “equilibrato” un cibo che contenesse in sé tutte le qualità nutrizionali, a loro volta manifestate, rese sensibili dai diversi sapori: la vivanda perfetta era ritenuta quella in cui tutti i sapori (e perciò tutte le virtù) erano simultaneamente presenti. Pertanto il cuoco era tenuto a intervenire sui prodotti, ad alterarne i caratteri in modo talora radicale. La cucina era percepita come un’arte combinatoria volta a modificare, a trasformare il gusto “naturale” dei cibi in qualcosa di diverso, di “artificiale”.
Un tipico esempio di questa cultura è il gusto per l’agrodolce, che ama mescolare lo zucchero agli agrumi (reinterpretando e ingentilendo, grazie all’apporto di questi due prodotti di origine medio-orientale, portati in Europa dagli arabi, la mescolanza di miele e aceto che caratterizzava la cucina romana antica). È un gusto non totalmente scomparso, che ancora oggi si ritrova nelle cucine europee più conservative, come quella tedesca e, più in generale, quelle dell’Est. Si pensi alle confetture di mirtilli, alle marmellate di pere usate a guarnizione della carne e, in particolare, della cacciagione: questa è cucina medievale. O si pensi, per restare all’Italia, a prodotti come la mostarda cremonese, che uniscono il piccante delle spezie al dolce dello zucchero: questa è cucina medievale. O si pensi al pepe e allo zucchero del panpepato e di altri dolci natalizi. Per andare più lontano, si pensi all’agrodolce della cucina cinese, o al piccione in crosta di miele della tradizione marocchina: questa è cucina medievale. La cucina del contrasto che in realtà è ricerca dell’equilibrio, del punto zero in cui le distanze fra i sapori si annullano. Questa «struttura del gusto», fortemente correlata con la scienza dietetica e in qualche modo anche con la filosofia e la visione del mondo, in Europa – cominciando dalla Francia e poi dall’Italia – si è totalmente modificata negli ultimi due secoli, e sicuramente costituisce la maggiore barriera alla comprensione di una realtà diversa come quella del Medioevo. Piccolo personale consiglio: un viaggio nello spazio, alla ricerca della tradizione gastronomica maghrebina, può essere un buon viatico al viaggio nel tempo verso il nostro Medioevo.
Altro carattere di base della gastronomia medievale, che la tiene distante da noi, è l’estrema parsimonia nell’uso dei grassi. Quella medievale è una cucina fondamentalmente magra, che per elaborare le salse, accompagnamento inevitabile di carni e pesci, utilizza soprattutto ingredienti acidi: vino, aceto, succo di agrumi, agresto (succo di uva acerba), miscelati con spezie e ispessite tenuti insieme con mollica di pane, fegato, mandorle, noci, tuorlo d’uova. Le salse grasse, a base di olio o di burro, che al nostro gusto risultano maggiormente familiari – parlo della maionese, della besciamella e di tutti gli intingoli tipici della cucina borghese otto-novecentesca – sono invenzioni moderne, che a iniziare dal secolo XVII hanno modificato profondamente il gusto e l’aspetto dei cibi. Se dovessi proporre un parallelo con l’oggi, suggerirei di pensare alle salse (magre, appunto, totalmente sprovviste di latticini o di olio) della cucina giapponese o del Sud-Est asiatico.
La tendenza a sovrapporre e ad amalgamare i sapori, anziché distinguerli e scomporli, nel Medioevo trovava un suo corrispettivo nelle tecniche di cottura, anch’esse non rigidamente distinte fra loro, ma sovrapposte e per così dire “accumulate”. Lessare, arrostire, friggere, stufare, brasare erano – ovviamente – modi diversi di cuocere, ma anche, in molti casi, momenti diversi di un medesimo processo di cottura, che li prevedeva uno dopo l’altro come fasi successive della preparazione. Talvolta ciò poteva rispondere a esigenze di natura pratica: per esempio, la lessatura preliminare delle carni – una pratica rimasta largamente diffusa almeno fino al Settecento – serviva anche a conservarle, in attesa di ulteriori elaborazioni e rifiniture. Poteva anche essere un modo per renderle più tenere. Ma, come per ogni altra scelta di cucina, era anche e soprattutto una questione di gusto: incrociando tecniche diverse si ottenevano particolari sapori e particolari consistenze del cibo. Elemento, quest’ultimo, molto avvertito dalla sensibilità medievale, abituata a un rapporto tattile con gli alimen...