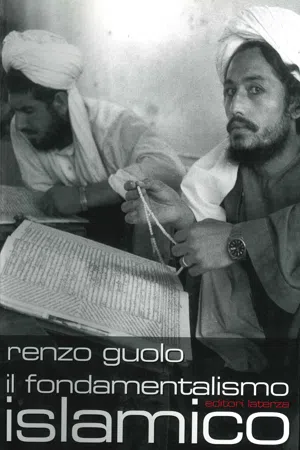
- 234 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Il fondamentalismo islamico
Informazioni su questo libro
Quale è l'origine e quale è la natura del movimento islamista che condiziona lo scenario mondiale? In questo libro uno dei maggiori studiosi del fondamentalismo islamico descrive con grande chiarezza quale modello di società e di Stato vogliono costruire i giovani che impugnano la bandiera della fede militante, in Palestina come in Algeria, in Iran come in Arabia Saudita, nella rete globale di Al-Qa'ida come nello stesso Occidente. E ci offre gli strumenti per rispondere alla domanda cruciale: l'attacco alle Twin Towers è l'inizio di una escalation politica e militare o l'ultimo colpo di coda di un movimento in crisi?
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Il fondamentalismo islamico di Renzo Guolo in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Economia e Politica economica. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
EconomiaCategoria
Politica economica1. Alle origini del conflitto: l’islamismo contro l’islam
La rivolta contro la tradizione
L’islamismo è un movimento di rivolta contro la «Tradizione lunga» dell’islam. Tradizione che ha giustificato la relativa separazione tra politica e religione che ha caratterizzato il mondo musulmano sin dall’ascesa della dinastia ommayade, nel 661. Saliti al potere con la spada, gli Ommayadi guideranno la comunità senza esserne i leader religiosi, separando quello che era unito nella comunità del Profeta: leadership politica e religiosa. In assenza di una figura carismatica che riunisce insieme capacità politiche e qualità religiose, il principe si trasforma da khalifa, «delegato del Profeta», titolo dalla connotazione religiosa, in mero governante.
Questa frattura origina una relativa autonomia del politico. Ma è proprio l’autonomia del politico che gli islamisti mettono in discussione, negando quattordici secoli di storia del mondo musulmano. Quell’autonomia significa la fine del patto di «sottomissione» a Dio della umma, la comunità dei credenti. La separazione tra politica e religione nega il messaggio coranico e l’esperienza della comunità profetica; spezza la relazione tra «legittimità» e «giustizia», indispensabile per l’accesso al potere. Governante «giusto» è colui che esercita il potere in nome della Legge religiosa. Egli è legittimo in quanto «giusto» e non viceversa. Nella storia, invece, il governante giusto cede il passo a quello che trae legittimità dal solo fatto di detenere il potere.
Per porre fine alla disputa su «legittimità» e «giustizia», che ne metteva in discussione l’unità, il mondo musulmano ha elaborato una teoria del potere che costituisce il nucleo portante della «Tradizione lunga» dell’islam: il quietismo. Teoria dell’obbedienza dovuta al principe da parte della comunità, il quietismo legittima il governante che conquista e conserva il potere. Unica condizione è che egli difenda la comunità musulmana dai nemici esterni e che consenta l’assolvimento degli obblighi di fede. Il requisito della giustizia del governante è attenuato, sino a scomparire.
Tesi quietiste emergono già nell’impero ommayade. Il pensiero dominante, astenendosi dal giudicare il principe, rimanda a Dio la capacità di distinguere tra credenti e non all’interno della comunità. Questo rinvio alla trascendenza legittima di fatto il potere comunque costituito. Ma è il filosofo e teologo Abu Hamid Ghazali (1058-1111) che elabora compiutamente la posizione quietista. Di fronte al dilemma: denunciare i nuovi sovrani selgiukidi, tiepidi osservanti della Legge religiosa, o difendere l’istituzione califfale, sceglie la seconda opzione. Interpretando il versetto coranico «La fitna è peggio dell’uccidere», egli traduce il polisemico termine fitna come sedizione, ribellione, disordine. Ghazali ritiene che l’ordine sia preferibile al conflitto, anche quando quest’ultimo sia provocato dal bisogno di «giustizia». La «sedizione» minaccia di distruggere la comunità e le sue istituzioni. L’ordine ingiusto è un male minore rispetto a un conflitto che può distruggere la società e mettere in discussione la fede. Ghazali giustifica così l’idea secondo cui il potere può essere illegittimo ma necessario.
La teoria ghazaliana si basa sull’interpretazione di un versetto coranico che, nella «Tradizione lunga», fonda il politico islamico: «Oh voi che credete, obbedite a Dio e al suo Messaggero e a coloro di voi che hanno l’autorità» (Corano IV, 59). Ma il «pensiero della fitna» definisce il politico in funzione di una gerarchia d’illegittimità. Esso presuppone la rinuncia al diritto di resistenza al principe che si discosta dalla Legge religiosa in nome della tutela dell’ordine sociale esistente.
La tradizione quietista diventerà ortodossia politica nell’islam. Non solo in campo sunnita: per ragioni e in forme diverse, s’imporrà anche tra gli sciiti. Nel mondo musulmano non mancheranno però interpretazioni diverse. Il giurista medievale Ibn Taimiyya (1263-1328) si oppone alla decisione dei mongoli, invasori convertiti all’islam, di adottare quale legge il loro diritto consuetudinario, la yasa. Dovere del sovrano è, infatti, rendere legittima la propria autorità attraverso l’osservanza della shari’a, la Legge religiosa. Contro il potere mongolo che ignora la shari’a è consentito, dunque, lo jihad, il «combattimento sulla via di Dio». Ibn Taimiyya mette così in evidenza il legame tra negazione della Legge e jihad contro il governante solo formalmente musulmano. La teoria dello jihad contro il «principe empio» riemergerà ai nostri giorni, evocata dall’islamismo contemporaneo.
Sulla questione della legittimità del potere si sono consumati in passato piccoli e grandi scismi dell’islam: da quello degli «uscenti», i kharigiti, a quello degli sciiti, i seguaci del partito di Alì. La deviazione dal modello originario del rapporto tra politica e religione ha permesso, infatti, alle «minoranze intense» religiose, ciclicamente emerse nella storia dell’islam, di rivendicare il senso «integrale» del messaggio e di farsi portavoce dell’«ossessione dell’autenticità». Proclamatesi custodi della «fede autentica», queste minoranze hanno condotto aspre battaglie contro la nascita di uno spazio politico relativamente autonomo dal religioso. Nell’ultimo secolo la «grande discordia» è stata provocata dall’affermarsi un’ideologia totale di matrice religiosa, l’islamismo, divenuta teologia politica. Essa si batte per affermare il primato del potere divino su quello umano e costruire uno «stato islamico».
Obiettivo dell’islamismo, che si auto-rappresenta come movimento di ritorno alla fede degli antichi compagni di Muhammad (salaf) e al modello politico della comunità del Profeta, è quello di «reislamizzare l’islam». Al centro del discorso islamista è il fondamento etico-religioso della comunità e dello stato, imperniato sull’opposizione tra il concetto di potere-potenza dell’uomo e quello di potere-autorità di Dio. Fondamento che essi cercano di rivitalizzare attraverso la politica, elemento che differenzia l’islamismo dal tradizionalismo. Quest’ultimo non esprime alcuna volontà di riforma politica della società e si manifesta, generalmente, come conservatorismo religioso.
L’islam politico: al-Banna e i Fratelli Musulmani
Hasan al-Banna (1906-1949), egiziano, è il fondatore nel 1928 degli Ikhwan al Muslimun, Associazione dei Fratelli Musulmani, il gruppo storico dell’islamismo contemporaneo che per primo pone il tema dell’islam politico. Al-Banna rappresenta l’anello di congiunzione tra la islah, la riforma, un movimento che, tra fine Ottocento e inizio Novecento, cerca una via d’uscita dalla decadenza in cui versa l’islam ottomano, e il fondamentalismo contemporaneo. La continuità con la «riforma» riguarda, innanzitutto, il ritorno alle fonti, Corano e Sunna, come testi ispiratori dell’agire politico e sociale, oltre che la richiesta di applicazione della shari’a, la Legge religiosa, come strumento di regolazione sociale. Comuni alle due correnti sono anche la critica ai chierici «ufficiali» dell’islam, ulama e faqih, esperti della Legge e giurisperiti, accusati di una lettura statica dei testi, e la concezione della legittimità del politico. Ma il riformismo rimarrà sempre una corrente intellettuale, elitaria, mentre i Fratelli Musulmani saranno presto un movimento di massa.
La fondazione del gruppo avviene a pochi anni dalla scomparsa del califfato ottomano, ridotto a un simulacro dalle potenze occidentali dopo il primo conflitto mondiale. Il califfato è abolito da Kemal Atatürk, fondatore della repubblica laica e nazionalista turca, nel 1924. Lo smarrimento del mondo musulmano di fronte a quest’evento è enorme, nonostante le dure critiche rivolte in passato, in particolare dal mondo arabo, ai turchi, accusati di avere ridotto l’islam a una tradizione sclerotizzata.
La nascita dei Fratelli Musulmani offre uno sbocco politico a quel disagio. Lo slogan della Fratellanza: «Dio è il nostro programma; il Corano è la nostra costituzione; il Profeta il nostro leader; il combattimento sulla via di Dio la nostra strada; la morte per la gloria di Dio la più grande delle nostre aspirazioni», sintetizza gli obiettivi e la natura del movimento. Per al-Banna, l’islam è un’ideologia totale e comprende tutto quanto concerne l’uomo in questo mondo e nell’altro. «L’islam è fede e culto, patria e nazionalità, religione e stato, spiritualità e azione, Libro e spada». L’islam è una
concezione totale, di portata universale che dovrà governare tutti gli aspetti della vita; questi devono esserne impregnati, sottomettersi al suo potere, seguire i suoi precetti e i suoi insegnamenti, prendendoli come riferimento, se la nazione vuole essere autenticamente musulmana. Ma se essa è musulmana solo nel culto, imitando per il resto altri modelli, questa nazione si colloca fuori dall’islam.
Dalle parole di al-Banna emerge la cruciale distinzione tra essere musulmani ed essere islamici. Il termine «islamico» si differenzia da quello, più neutro religiosamente, di «musulmano» poiché il primo assume un valore aggiunto religioso che il secondo non possiede. Nel discorso di al-Banna, è chiaro anche il rifiuto dei modelli occidentali e delle ideologie, come il nazionalismo, che ne derivano.
I Fratelli Musulmani ritengono che non sia possibile alcun ordine islamico, né tanto meno uno stato islamico, senza una profonda trasformazione della coscienza di ciascun individuo. Lo stato ideale dei Fratelli coincide con la «comunità perfetta dei perfetti credenti». È, dunque, all’«appello all’islam» (da’wa), alla reislamizzazione della società, resa necessaria dal fallimento dell’esperienza storica dell’islam e dalla penetrazione di costumi occidentali, che essi indirizzano la propria missione. La Fratellanza intende ricostruire l’identità islamica a partire dalla società, con l’obiettivo di farla crescere sino al punto in cui il potere politico non potrà che essere espressione di questa società profondamente trasformata.
L’islam dei Fratelli Musulmani non si esaurisce nel culto e nel pietismo, ma contrappone ai fautori della «modernizzazione dell’islam» la «reislamizzazione della modernità». L’idea della «modernità islamica» consente all’Associazione di unificare sotto la propria guida gruppi sociali dagli interessi differenziati, ma sostenitori di un modello di civilizzazione fondato sulla matrice islamica. Nell’arco di un decennio dalla fondazione il movimento si diffonde dai ceti popolari alla piccola borghesia urbana di recente alfabetizzazione, sino agli strati sociali medio-alti, dove penetra tra le professioni liberali, i docenti universitari, gli alti gradi militari. La Fratellanza propone, infatti, un messaggio che permette la rimozione degli interessi di classe. In una società frammentata e destrutturata dalla penetrazione occidentale come quella egiziana essi indicano una via per il superamento delle contraddizioni sociali. Un modello in cui la coesione della umma e la solidarietà tra credenti prevalgono sulle divisioni sociali. I conflitti di classe sono esorcizzati in quanto minacciano l’ordine sociale unitario cui la umma aspira e la indeboliscono nella sfida contro i «nemici dell’islam»: i colonizzatori europei e gli strati sociali che hanno assorbito la loro cultura «corrotta». Questa sorta di interclassismo confessionale permette al gruppo di fare sintesi dei diversi interessi sociali, tanto che esso riunisce insieme ceti rurali, masse urbane, studenti, professionisti.
Al-Banna traccia per il suo gruppo un programma in tre fasi: la prima caratterizzata dalla da’wa, il messaggio; la seconda dedicata al reclutamento e alla strutturazione del movimento; la terza interamente proiettata sull’azione per la realizzazione di un nuovo ordine sociale. «Fede e azione» è un altro slogan del movimento. Per al-Banna, i Fratelli non sono un vero e proprio partito politico, sebbene la politica sia al centro della loro azione, quanto un gruppo di pressione. Egli afferma che la Fratellanza non vuole per sé il potere politico, ma intende supportare i governanti che adottino il «metodo coranico». La rinuncia alla gestione diretta del potere è legata più alle circostanze storiche in cui il movimento si trova ad agire che a una posizione di principio. Le dinamiche del sistema politico coloniale e postcoloniale impediscono ai Fratelli di darsi, almeno ufficialmente, la forma del partito politico. Al-Banna pensa così alla Fratellanza come un gruppo, ramificato nella società, in grado di esercitare il controllo ideologico sull’orientamento politico dei governanti sino a quando le condizioni permettano la nascita di un autentico «ordine islamico».
L’ambiguo accento sul concetto di «ordine islamico» anziché su quello di «stato islamico» permette al gruppo una certa libertà d’azione. Ma determinerà anche l’oscillante condotta dei diversi regimi politici verso la Fratellanza, incerti tra inclusione nel sistema politico e repressione violenta, repressione incoraggiata dalla rapida espansione dell’Associazione, che si diffonde anche in Siria, Transgiordania, Palestina, Sudan, Iraq. A vent’anni dalla sua fondazione la Fratellanza conta circa 2 milioni di aderenti ed è temuta dai regimi al potere. Anche perché dispone di una branca paramilitare, la cosiddetta «Organizzazione speciale». Nata inizialmente come strumento di autodifesa, che recluta e addestra militarmente i propri quadri, l’Organizzazione si autonomizza presto dall’Associazione, assumendo il ruolo di contropotere interno. Il suo leader, ’Abd al-Rahman al-Sindi, disattende spesso le indicazioni della leadership, organizzando azioni che, talvolta, sfociano in atti di terrorismo politico. La pratica armata non è mai stata del tutto estranea all’Associazione, ma è generalmente condotta contro i «nemici esterni» della comunità musulmana. Volontari dei Fratelli Musulmani partecipano alla rivolta palestinese degli anni 1936-39 contro lo Yishuv, l’insediamento ebraico in Palestina. Al-Banna definisce jihad lo scontro con i coloni ebrei e gli inglesi nella Palestina mandataria. Nel 1948 i gruppi scelti Jawala e Kata’ib, sorta di «camicie verdi» della Fratellanza, combattono nel primo conflitto arabo-israeliano.
La nascita di Israele, uno shock per il mondo arabo, è imputata dai Fratelli al tradimento dei governanti, che si sono allontanati dalla fede e sono diventati complici delle potenze mondiali occidentali e cristiane che proteggono gli ebrei. La monarchia di Faruk si sente minacciata. Al ritorno della prima «falange» combattente dal fronte palestinese, i Fratelli Musulmani subiscono una forte repressione da parte del governo egiziano, timoroso di dover fronteggiare un’opposizione politica che ne delegittima il ruolo e dispone di una struttura armata. In questa situazione di tensione, la Fratellanza è accusata dell’assassinio del primo ministro egiziano, evento che porta allo scioglimento del gruppo nel dicembre 1948 e, successivamente, alla morte di al-Banna, ucciso in uno scontro con la polizia segreta del regime nel febbraio 1949.
Dopo la crisi seguita alla morte del fondatore e leader carismatico, la Fratellanza torna sulla scena politica nel 1952 con la «rivoluzione del 23 luglio», nel corso della quale gli «Ufficiali liberi», guidati da Neguib, Nasser e Sadat, rovesciano la monarchia. Nella «rivoluzione di luglio» i Fratelli vedono l’occasione per costruire l’agognato ordine islamico. Ma i rapporti tra i due gruppi si deteriorano presto. La Fratellanza rifiuta la riforma fondiaria proposta dai nazionalisti di sinistra, che colpirebbe parte della base sociale della Fratellanza; insiste invece perché vengano introdotte misure relative ai costumi islamici: obbligatorietà del velo per le donne e chiusura di cinema e teatri. La Fratellanza chiede inoltre che siano sciolti i partiti politici, compreso il Rally, fondato nel 1953 dagli Ufficiali liberi. L’idea che dalla rivoluzione possano sorgere partiti, fattori di divisione e contrapposizione politica e sociale, contrasta con la visione unitarista del movimento.
La frattura tra gli Ufficiali liberi e i Fratelli Musulmani è causata innanzitutto dal diverso progetto di società di cui sono portatori. I primi intendono costruire un regime nazionalista; i secondi uno stato islamico. La rottura definitiva avviene nell’ottobre 1954, dopo il fallito attentato di Alessandria a Nasser da parte di un membro dell’Organizzazione. L’episodio provoca l’arresto di migliaia di militanti e l’esecuzione di numerosi membri della Fratellanza. Il 1954 segna l’inizio ...
Indice dei contenuti
- Introduzione
- 1. Alle origini del conflitto: l’islamismo contro l’islam
- 2. Radicali e neotradizionalisti
- 3. Nel regno del faraone: l’Egitto dopo il 1967
- 4. Il dio del politico: l’Iran e lo stato parallelo
- 5. Tra wahhabismo e petroislam: l’Arabia Saudita
- 6. Il paese dei puri: il Pakistan
- 7. Guerra al popolo idolatra e violenza del sacro: l’Algeria
- 8. Fervore e martirio: morire per Dio in Palestina
- 9. La terra dello «jihad»: l’Afghanistan
- 10. Al Qa’ida e lo «jihad» globale
- 11. Declino dell’islamismo?
- Bibliografia