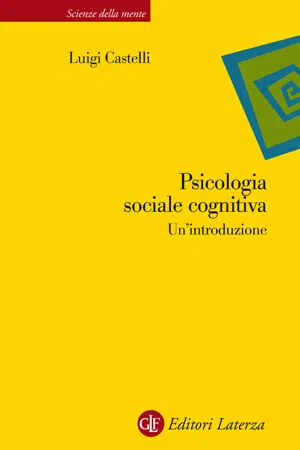
- 148 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
La psicologia sociale studia i comportamenti e la formazione dei giudizi degli individui alla luce del funzionamento del nostro sistema cognitivo. Il volume è un'introduzione, ricca di esempi concreti, ai principali modelli teorici che affrontano le tematiche della percezione dei singoli e dei gruppi e dell'autopercezione.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Psicologia sociale cognitiva di Luigi Castelli in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Psicologia e Psicologia sociale. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
PsicologiaCategoria
Psicologia sociale1. La cognizione sociale
1.1. Una definizione preliminare
L’ambito di studi che verrà affrontato in questo volume viene denominato cognizione sociale. Come avremo modo di vedere, sotto questa etichetta si cela un universo di teorie, modelli, paradigmi ed interessi di ricerca molti diversificati tra loro. Ciò che li accomuna sono però degli assunti di fondo rispetto al modo in cui funziona la mente umana. L’obiettivo finale è quello di individuare i processi che caratterizzano il funzionamento del nostro sistema cognitivo e che guidano i giudizi che emettiamo nella nostra vita quotidiana, così come i comportamenti che realizziamo all’interno del nostro ambiente sociale. L’elemento centrale di questo approccio è quindi l’individuazione dei processi cognitivi sottostanti, ossia l’esame dei percorsi di elaborazione delle informazioni grazie ai quali ci si predispone alla vita sociale. Questo obiettivo di conoscenza si realizza principalmente attraverso due differenti modalità. Da un lato, è possibile chiedere alle persone di verbalizzare i loro pensieri, impressioni e ragionamenti. Questo metodo, che trova le radici nell’approccio fenomenologico (cfr. per es., Koehler, 1929), permette di individuare quali siano le teorie ingenue che le persone utilizzano nel momento in cui interpretano e danno significato al proprio comportamento e a quello altrui. Dall’altro, la psicologia sociale cognitiva ha fatto propri i modelli e le metodologie di ricerca tipiche della psicologia cognitiva in generale. È nato così un avvincente tentativo di integrazione tra le conquiste ottenute nello studio dei processi di memoria, di apprendimento e di pensiero, e le ambizioni della psicologia sociale di spiegare fenomeni complessi quali la formazione di impressioni, le relazioni intergruppi o l’autopercezione. In questo percorso di esplorazione della psicologia sociale cognitiva, partiamo da un tentativo di definizione di cosa si intende per cognizione sociale:
la cognizione sociale si occupa dello studio scientifico dei processi attraverso cui le persone acquisiscono informazioni dall’ambiente, le interpretano, le immagazzinano in memoria e le recuperano da essa, al fine di comprendere sia il proprio mondo sociale che loro stesse ed organizzare di conseguenza i propri comportamenti.
All’interno di questa definizione sono molti i punti che debbono essere sottolineati. Innanzitutto, vi è la natura scientifica di questo approccio di studio. Ogni ipotesi viene sottoposta a rigide verifiche sperimentali secondo criteri condivisi all’interno della comunità scientifica. Ciò significa che anche le più brillanti intuizioni debbono necessariamente trovare dei riscontri empirici, replicabili attraverso studi indipendenti, prima di poter essere accettate come dotate di fondamento (si veda Leone, 2003). Lo sforzo è quello di isolare processi di tipo generale che, date specifiche condizioni ambientali, si ripresentino con sufficiente regolarità. Ovviamente, i processi oggetto di studio possono variare a seconda del loro grado di specificità. Alcuni processi sono infatti estremamente pervasivi tanto da essere pressoché universali, mentre altri sono assai più legati alle specificità del contesto. L’attuale psicologia cross-culturale sta fornendo importantissime indicazioni in questo senso, permettendo di comprendere le potenzialità esplicative ed i limiti di applicabilità dei risultati ottenuti da studi condotti in un dato ambiente culturale.
Un secondo importante aspetto da sottolineare è la natura attiva del processo di acquisizione di informazioni dall’ambiente. Le persone esplorano il proprio ambiente e si interrogano sulle sue caratteristiche. Ad esempio, in continuazione si cerca di cogliere indizi rispetto ai tratti di personalità che contraddistinguono le persone che ci circondano, rispetto a cosa gli altri pensino di noi e così via. Data l’estrema varietà di informazioni potenzialmente a disposizione occorre però operare dei processi di selezione: alcuni elementi verranno percepiti dall’osservatore mentre molte altre informazioni passeranno semplicemente inosservate senza lasciare alcuna traccia (Neisser, 1976). Un’ulteriore caratteristica della cognizione sociale, che costituisce il cuore pulsante di questo approccio di ricerca, è l’idea che le informazioni acquisite dall’ambiente non abbiano un valore di per se stesse, ma che su di esse l’individuo lavori attivamente attribuendo significati e valori personali. Tutto ciò che proviene dall’ambiente è soggetto a processi di interpretazione sulla base delle conoscenze possedute, delle proprie esperienze passate e del proprio stato attuale. Ciò significa che uno stesso evento potrà essere vissuto e spiegato in maniera profondamente diversa da due individui che abbiano strutture di conoscenza differenti e che siano guidati da differenti motivazioni. Ad esempio, è esperienza comune constatare come gli episodi che si verificano nel corso di un evento sportivo vengano percepiti ed interpretati in modo differenziato a seconda della fede sportiva dell’osservatore. In tal modo, i tifosi di differenti squadre «vedono» cose profondamente diverse (Hastorf, Cantril, 1954). Per comprendere come verrà interpretata una situazione da uno specifico individuo è spesso più importante una conoscenza approfondita dell’individuo percepente piuttosto che della situazione stessa. Le attribuzioni di significato sono infatti in larga misura il frutto della soggettività dell’individuo percepente. Infine, i risultati di questi processi di raccolta di informazioni e di elaborazione vengono depositati in memoria e vanno ad arricchire quel bagaglio di conoscenze ed esperienze che a sua volta è pronto per guidare sia i nuovi processi di acquisizione di informazioni dall’ambiente, influenzando cosa sarà notato e cosa no, sia le operazioni di interpretazione.
1.2. Alcuni princìpi generali
Nel paragrafo precedente si è accennato alle differenze individuali nel modo in cui gli stimoli ambientali vengano filtrati ed interpretati. Al di là di queste differenze vi sono però alcuni princìpi generali che contraddistinguono i processi di elaborazione delle informazioni sociali. Su di essi ci soffermeremo ora.
1.2.1. Il bisogno di risparmiare risorse cognitive
L’immagine di uomo che viene proposta, e che trova ampi riscontri nella moderna psicologia cognitiva, prevede che le persone abbiano limitate abilità e capacità di elaborazione delle informazioni (Fiske, Taylor, 1991). Ciò implica due importanti conseguenze. La prima è che occorre intervenire col selezionare le informazioni in ingresso, cercando modalità di sintesi che permettano di riassumere la massima quantità di informazioni con il minimo sforzo. La soluzione primaria che viene adottata risiede nel processo di categorizzazione. Ciò significa che vari esemplari vengono inseriti in un medesimo insieme significativo sulla base degli elementi di similarità che li accomunano. In seguito, sarà possibile trattare tali esemplari in modo sostanzialmente analogo, facendo riferimento alle conoscenze generali già possedute circa la categoria. Ad esempio, incontrando un ragazzo con la testa rasata e degli anfibi ai piedi sarà possibile categorizzarlo come membro del gruppo «skinhead» ed inferire con rapidità altre sue possibili caratteristiche personali prima ancora di avere a disposizione dettagliate e oggettive informazioni su di lui. In continuazione, categorizziamo ed utilizziamo le conoscenze pregresse circa i membri della categoria per giungere ad una approssimativa ma rapida definizione dell’ambiente in cui ci stiamo muovendo.
La seconda conseguenza legata alla necessità di formulare giudizi risparmiando risorse cognitive è data dal ricorso a ragionamenti di tipo euristico. Con il termine euristiche si denotano delle scorciatoie di pensiero che utilizziamo per formulare giudizi sulla base di informazioni limitate. Ad esempio, dovendo acquistare una automobile o dovendo decidere dove trascorrere le prossime vacanze, con estrema difficoltà le persone si impegnano in un’analisi sistematica di tutti i possibili dettagli utili per giungere alla migliore scelta possibile. Questi tentativi condurrebbero inevitabilmente a situazioni di stallo in cui ogni decisione assorbirebbe l’individuo al punto tale da rendere impossibile ogni altra attività. Di conseguenza, non si ricerca la soluzione ottimale bensì una soluzione accettabile (Simon, 1983). Quindi, le euristiche possono costituire delle efficaci scorciatoie che permettono di ridurre il tempo e gli sforzi necessari per giungere ad una conclusione soddisfacente, anche se non necessariamente la migliore in assoluto (Tversky, Kahneman, 1974). Tutto ciò ha però i suoi costi: se in generale il ricorso a ragionamenti di tipo euristico offre indubbi vantaggi, esso può talvolta condurre ad una serie di errori di giudizio che verranno discussi più diffusamente in seguito.
1.2.2. Processi consapevoli e inconsapevoli
Nella gestione delle informazioni provenienti dall’ambiente è ovviamente possibile operare in modo consapevole attraverso un loro attento e deliberato esame. In queste situazioni, si opera come degli scienziati ingenui che razionalmente analizzano i dati a disposizione per giungere a delle plausibili conclusioni. Parliamo quindi di processi consapevoli, o controllati, ogniqualvolta un processo mentale abbia luogo a partire da un iniziale atto di volontà, possa essere controllato nel corso del suo sviluppo, e rispetto al quale l’individuo è in larga misura in grado di riportare verbalmente i vari passaggi compiuti (Bargh, 1994). Quindi, le sue caratteristiche peculiari sono l’intenzionalità, la possibilità di controllo e la consapevolezza, almeno parziale, sia delle fasi intermedie del processo che del suo esito finale. In aggiunta, un requisito di fondo affinché un processo consapevole o controllato possa aver luogo è la disponibilità di sufficienti risorse cognitive, in quanto simili processi mentali sono altamente dispendiosi e «consumano» le risorse attentive dell’individuo (Bargh, 1989). Ciò significa che mentre si è impegnati in un compito, quale, ad esempio, la comprensione di un testo scritto, con estrema difficoltà si riuscirà ad eseguire simultaneamente un altro compito controllato che richieda anch’esso risorse attentive, come ad esempio ripercorrere mentalmente le tappe e i luoghi delle ultime vacanze. I processi consapevoli sono quindi tipicamente seriali, nel senso che possono essere eseguiti in successione, e nel momento in cui si tenta di portarli avanti simultaneamente (in parallelo) si ostacolano vicendevolmente.
D’altro canto, quando un’attività viene ripetuta nel tempo va incontro a modificazioni nel modo in cui viene eseguita. Pensiamo all’apprendimento delle abilità per suonare la chitarra. Inizialmente è necessario prestare molta attenzione alla posizione delle dita e ad ogni minima azione che viene realizzata sulle corde dello strumento. In seguito, con l’esperienza e la pratica, questi movimenti diventano automatici e possono essere eseguiti anche senza una continua attenzione (Shiffrin, Schneider, 1977). L’azione fluisce pertanto senza un necessario controllo consapevole. In questi casi parliamo di processi inconsapevoli o automatici (Bargh, 1994). Questi processi, poiché prevedono un carico attentivo alquanto limitato, permettono l’esecuzione contemporanea di altre operazioni. Ecco allora che il guidatore esperto sarebbe in grado di compiere complesse manovre anche mentre discute animatamente con il partner, laddove il principiante che volesse effettuare un parcheggio decente dovrebbe sospendere la discussione e concentrarsi sui dettagli della manovra.
I processi automatici sono estremamente importanti anche nell’àmbito della cognizione sociale. Anche in questo caso, infatti, le persone utilizzano ripetutamente modalità tipiche di percezione degli altri individui. Ad esempio, si è accennato in precedenza al processo di categorizzazione quale strumento privilegiato per risparmiare risorse cognitive. Se questo processo diventa routinario si pongono le basi affinché ogni situazione sociale abbia luogo in modo automatico (Brewer, 1988; Fiske, Neuberg, 1990). In effetti, come vedremo dettagliatamente in seguito, una delle prime operazioni che vengono condotte in modo spontaneo e non necessariamente intenzionale ad ogni incontro sociale è quella di identificare le categorie sociali più rilevanti a cui la persona percepita appartiene.
In aggiunta, le persone sono frequentemente inconsapevoli dei propri processi mentali anche in un modo più sottile. Infatti, non solo si possono eseguire processi in forma automatica, ma anche quando si portano avanti processi controllati noi siamo consapevoli solo della punta dell’iceberg. La capacità di introspezione rispetto ai propri processi mentali è alquanto ridotta (Nisbett, Wilson, 1977) e così anche quando ragioniamo consapevolmente su un argomento non siamo pienamente a conoscenza di tutti i fattori che stanno influenzando questi nostri processi. Ad esempio, dovendo scegliere tra due candidati per un posto di lavoro, possiamo tentare di operare una scelta razionale basata sulle competenze dei due candidati, ma non riusciremo mai attraverso uno sforzo introspettivo a quantificare con accuratezza l’influenza che altri fattori, quali la somiglianza fisica con una persona importante del nostro passato, una certa tonalità del vestito indossato o il nostro umore in quel momento, possono aver avuto sulla scelta finale (Lewicki, 1985; Nisbett, Wilson, 1977). È ormai opinione condivisa che non esistano processi controllati «puri» e che sempre si verifichi una compresenza, in proporzioni variabili, di componenti controllate ed automatiche (Bargh, 1997).
1.2.3. L’egocentrismo dei processi di pensiero
Ogni individuo ha una propria prospettiva privilegiata attraverso la quale osserva il mondo. Risulta però difficile relativizzare questa prospettiva e la tendenza che si riscontra, di conseguenza, è quella di ritenerla valida in assoluto. È curioso rilevare come spesso gli individui rimangano stupefatti o profondamente contrariati dal fatto che gli altri non notino un qualcosa che a loro invece appare lampante, o che a fronte di una serie di premesse altri giungano a conclusioni differenti dalle proprie. Ad esempio, gli spettatori dei quiz televisivi ritengono spesso impossibile che il concorrente non conosca la risposta ad una domanda alla quale loro saprebbero invece rispondere con facilità, non tenendo conto del fatto che ognuno ha una propria ed unica storia, così come un bagaglio personale di esperienze e conoscenze. Un ulteriore interessante esempio di pensiero egocentrico è costituito dalla cosiddetta illusione di trasparenza (Gilovich, Savitsky, Medvec, 1998), ovvero la credenza erronea che gli altri capiscano immediatamente e con relativa facilità i nostri stati interni. Se si è felici o tristi, sovrastima la facilità con cui gli altri sono in grado di capire lo specifico stato emotivo in cui ci troviamo. Quindi, se qualcuno esegue un comportamento che ci pone in uno stato di disagio siamo indotti a pensare che tale persona non possa non capire questa nostra situazione, modificando la sua condotta futura. I rapporti di coppia sono costellati da simili distorsioni di giudizio, con tutte le inevitabili conseguenze negative, laddove all’origine di tutto vi è solo l’errata convinzione che poiché noi sappiamo di essere a disagio anche il partner debba necessariamente capire che siamo a disagio (Gilovich, Kruger, Savitsky, 1999). Queste forme di egocentrismo, che sono eclatanti nei bambini (Piaget, 1947), si ripresentano sotto altre vesti anche in età adulta influenzando i giudizi ed i rapporti interpersonali.
Non solo l’individuo tende a porsi al centro del mondo, ma in aggiunta – almeno in situazioni di «funzionamento normale» – tende a farlo mettendosi in una luce positiva ai propri occhi e a quelli altrui. Una fondamentale motivazione che guida le percezioni, i giudizi ed i comportamenti è infatti quella di raggiungere o mantenere una elevata autostima, ovvero un’immagine positiva di se stessi (Silverman, 1964; Tesser, 1988). Quindi, i processi di elaborazione che vengono posti in essere tendono in modo sistematico a configurare la realtà in modo tale da ottenere una autorappresentazione caratterizzata da attributi positivi, anche quando gli effettivi eventi sembrerebbero suggerire l’opposto (Taylor, 1989; Zuckerman, 1979).
1.2.4. La resistenza al cambiamento
In generale, sia i processi che i contenuti di pensiero tendono ad essere alquanto impermeabili rispetto ad ogni tentativo di modificazione. Certe modalità tipiche di rappresentazione del mondo e di interazione con gli altri si cristallizzano e, quindi, con estrema difficoltà e lentezza vanno incontro a cambiamenti. Questa resistenza al cambiamento è tanto più evidente là dove le credenze dell’individuo permangono stabili nonostante vi siano indicazioni oggettive circa la loro erroneità o quantomeno rispetto alla necessità di operare delle revisioni.
Inoltre, è caratteristica peculiare dei processi di pensiero quella di esplorare il mondo alla ricerca di elementi in grado di confermare le proprie aspettative. Questo è un aspetto che verrà ampiamente trattato nel corso di tutto il volume. Il risultato finale di questa tendenza sarà nuovamente una rigidità nel modo di rappresentarsi gli eventi, al fine di privilegiare tutto ciò che permetta di mantenere una relativa stabilità piuttosto che quelle informazioni che possano essere di stimolo al cambiamento.
1.2.5. L’accessibilità cronica
Il concetto di accessibilità è fondamentale per la comprensione dei processi mentali. L’accessibilità può essere definita come la facilità con cui determinati contenuti di pensiero si presentano alla nostra mente (Arcuri, Castelli, 2000): in altre parole, dato l’insieme di conoscenze depositate in memoria, alcune di queste risultano più semplici da recuperare. La conseguenza importante è che queste conoscenze facilmente recuperabili diventeranno in modo cronico, anche al variare dei contesti, la chiave privilegiata di interpretazione. Ad esempio, persone fortemente interessate ai temi della politica, o addirittura impegnate attivamente in politica, tenderanno sistematicamente a cercare di individuare l’affiliazione politica dei propri interlocutori e i risvolti politici di ogni accadimento. Allo stesso modo, dopo mesi trascorsi a studiare testi di psicopatologia, è fenomeno tipico degli studenti di psicologia quello di decodificare i comportamenti altrui nei termini di categorie diagnostiche. In generale, quindi, i contenuti più accessibili formeranno il quadro di riferimento utilizzato per dare senso a ciò che di nuovo incontriamo così come alle nostre esperienze. Un ulteriore esempio particolarmente rilevante per le sue drammatiche conseguenze è dato dalla situazione in cui si trovano le persone depresse: in questi soggetti di...
Indice dei contenuti
- 1. La cognizione sociale
- 2. La percezione sociale. La formazione di impressioni, l’utilizzo di euristiche di giudizio e la spiegazione dei comportamenti
- 3. I processi di categorizzazione e gli schemi nella percezione sociale
- 4. Percepire, comprendere e giudicare se stessi
- Riferimenti bibliografici