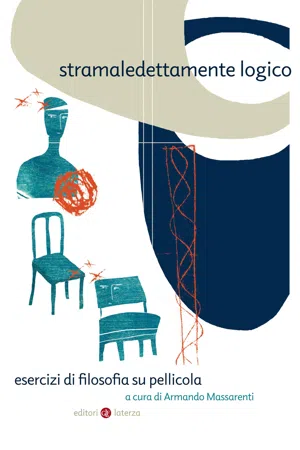Come fai a saperlo?
di Nicla Vassallo
«Authority has every reason to fear the skeptic, for authority can rarely survive in the face of doubt».
Vita Sackville-West
Quaid: «I just had a terrible thought. What if it is a dream?»
Melina: «Then kiss me before you wake up».
Atto di forza
Agent Smith: «Did you know that the first Matrix was designed to be a perfect human world?
Where none suffered, where everyone would be happy. It was a disaster. No one would accept the program».
Matrix
Come fai a sapere quanto credi di sapere? Che non stai sognando, che non sei ingannato da un demone, che non sei un cervello in una vasca. Insomma, come fai a sapere che non sei dentro la Matrice? Puoi saperlo? Forse non puoi. Se non puoi saperlo, quando credi di conoscere, ma in effetti non conosci, cosa accade? E cosa accade quando in alcuni contesti non puoi conoscere quasi nulla di quanto credi di conoscere, mentre in altri puoi conoscere quanto lo scettico nega che tu possa conoscere? Se ti domando: come fai a sapere che stai sorseggiando un Dry Martini, o che lo hai sorseggiato, cosa rispondi? Magari ami Trinity e, nonostante la tua riservatezza, vorresti dirle che sai parecchie cose, non per spavalderia, ma per farti conoscere da lei, tra cui quella (banale, ma solo in apparenza) di aver sorseggiato un Dry Martini. Qui di seguito tenterò di offrire una breve risposta a queste domande, prendendo spunto dal primo episodio della saga Matrix – senza accennare agli altri, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions. Il taglio sarà evidentemente e (quasi) esclusivamente epistemologico1.
Wake up
Sebbene in Matrix i rimandi filosofici espliciti non siano molti (la copertina del volume Simulacres et simulation di Jean Baudrillard; cenni a episodi del capolavoro logico-metafisico di Lewis Carroll, Alice in Wonderland; l’ammonimento socratico «Conosci te stesso»), le numerose interpretazioni del film chiamano in causa parecchi pensatori (si sono citati, oltre a Socrate e a Platone, Berkeley, Cartesio, Heidegger, Husserl, Kant, Leibniz, Merleau-Ponty, Sartre) e altrettante discipline: dall’ontologia all’epistemologia, dall’etica alle scienze cognitive, dalla filosofia politica alla filosofia della mente, dal post-modernismo alla filosofia della religione2. In seguito Cartesio ci condurrà a menzionare Dio, ma per ora è bene accennare, tra i tanti, ad alcuni temi filosofico-religiosi: Neo (Keanu Reeves) viene considerato l’«eletto» e il suo nome rappresenta l’anagramma di ‘One’, cioè di ‘Uno’; ‘Trinity’ (Carrie-Anne Moss) rimanda alla Trinità; e in una delle scene iniziali sullo schermo del computer appare il messaggio «Wake up, Neo». Svegliati dall’ignoranza, Neo, per incamminarti sulla via della conoscenza, via che in alcune religioni si concretizza in un’illuminazione riservata a un manipolo di iniziati: gli iniziati conoscono (non è solo Neo, una volta liberato, che può considerarsi un iniziato, ma ovviamente anche Morpheus – Laurence Fishburne –, Trinity, e così via), mentre la situazione epistemica degli altri esseri umani rimane fragile e precaria, esigua in alcuni casi. Nel nostro mondo contemporaneo gli iniziati sono gli esperti, esperti in diverse materie, o discipline, a cui i non esperti si affidano per acquisire conoscenze; gli esperti trasmettono le loro conoscenze testimoniandole ai non esperti3, e Neo deve alla testimonianza di Morpheus sia la conoscenza di essere vissuto in un mondo fittizio, sia molta della conoscenza del mondo reale.
Prima di procedere oltre, è utile aver presente qualche elemento della trama del film. Nel corso di una guerra tra esseri umani e macchine, i primi tentano di eliminare le seconde bloccandone il sostentamento essenziale, i raggi solari – le macchine necessitano di energia per sopravvivere. La ritorsione delle macchine non si fa attendere: gli esseri umani vengono costretti a fluttuare in vasche per essere trasformati nella fonte di energia delle macchine stesse. Di questa condizione la gran parte degli esseri umani è però inconsapevole, dato che vengono loro assicurate le medesime credenze che avrebbero avuto prima della guerra, o, in altre parole, una sorta di esistenza fittizia che non discorda da quella precedente. Il film si erge sulla contrapposizione tra le circostanze epistemiche dei tanti che sognano un sogno in grado di simulare la realtà e le circostanze dei pochi che, al corrente di come stanno effettivamente le cose, lottano per liberare gli esseri umani inconsapevoli. Tra i pochi consapevoli, Morpheus contatta Neo e, dopo avergli illustrato la situazione – Matrix «è un mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità» –, gli offre la possibilità di ingerire due pillole: la pillola blu garantisce a Neo di dimenticare quanto gli è stato rivelato, per proseguire senza problemi nella sua esistenza fittizia, mentre la pillola rossa gli assicura di conoscere come stanno le cose, per iniziare a condurre un’esistenza reale. Neo opta per la pillola rossa, ma, a dispetto del supporto assiduo di Morpheus, spesso affiancato nel compito da Trinity, sarà arduo il suo cammino sulla via della conoscenza e lenta la sua presa di consapevolezza. L’ammonimento «conosci te stesso», inciso sopra la porta dell’oracolo, risulterà d’aiuto.
La caverna
Che senso ha ingerire la pillola rossa quando essa, invece di promettere paradisi di felicità, è, nelle parole di Morpheus, un malinconico «welcome to the desert of the real»? Aristotele risponderebbe che «tutti gli uomini aspirano per natura al sapere» (Metafisica, libro I)4: gli esseri umani sono tali in quanto conoscono; se non conoscono, la loro esistenza si riduce a mero vegetare. In termini socratici, la virtù risiede nella conoscenza, mentre il vizio nell’ignoranza: gli esseri umani sono la loro psyché e la prima conoscenza che devono conseguire è la conoscenza di se stessi; conoscere diventa allora virtuoso perché nel conoscere se stessi si comprendono anche i propri limiti e le proprie possibilità. È quello che accade a Neo, dopo aver ingerito la pillola rossa.
Tra i problemi epistemologici di rilievo, con cui Neo deve confrontarsi, ve n’è uno che Platone coglie bene, mettendo in bocca a Socrate le seguenti parole:
Capisco che cosa intendi dire, o Menone. Guarda che argomento eristico adduci: che non è possibile per l’uomo ricercare né ciò che sa né ciò che non sa; infatti, né potrebbe cercare ciò che sa – perché lo sa già, e intorno a ciò non occorre ricercare –, né ciò che non sa – infatti, in tal caso, non sa cosa ricercare5.
La conoscenza è possibile, o, come pretende lo scettico, impossibile? La reazione antiscettica di Platone conduce a giocare su due piani: sul piano epistemologico, al fine di precisare qual è la fonte conoscitiva per eccellenza, e sul piano ontologico/metafisico, al fine di specificare quali sono gli oggetti di conoscenza.
Stando alla dottrina dell’anamnesi, che si fa interprete del «conosci te stesso», la conoscenza si deve alla memoria di quanto è presente da sempre nella mente: l’Iperuranio contiene idee che l’essere umano ricorda e che costituiscono il modello di ciascuna cosa del mondo sensibile. Incapaci di fornirci conoscenze perfette, o in ogni caso le idee stesse, i dati dell’esperienza si limitano a risvegliarle in noi. Il problema è che non sussiste corrispondenza tra idee e dati: per esempio, nessun oggetto del mondo esterno è esattamente circolare e non è pertanto in grado di generare in noi l’idea di «cerchio perfetto». Occorre concluderne che, visto che possediamo la nozione di «cerchio perfetto», la conoscenza non proviene dai sensi, per quanto stimolata da questi, bensì dalla nostra interiorità che «rintraccia» le idee tramite l’anamnesi.
Il percorso dall’ignoranza alla conoscenza trova una degna narrazione nel mito della caverna, in cui si evidenzia efficacemente il disaccordo tra apparenza e realtà, insieme all’aspetto scettico insito nel carattere problematico della conoscenza: chi rimane prigioniero non conosce nulla, o quasi nulla di quanto crede di conoscere6. Si ipotizzi che gli esseri umani siano da sempre imprigionati in una caverna, ove è loro concesso di vedere solo ombre: non avendo mai visto altro, se non per l’appunto ombre, credono che esse costituiscano la realtà. Uno di loro però (potrebbe essere Neo, che Morpheus ci descrive in almeno un’occasione come uno schiavo tenuto in una prigione) riesce a fuggire per accorgersi, mentre si appresta a uscire dalla caverna, che le ombre sono prodotte da statue e che le statue sono ben più reali delle ombre; una volta uscito dalla caverna, egli vede gli oggetti del mondo esterno e infine il sole, conseguendo una conoscenza effettiva.
Dunque, il fuggitivo potrebbe essere Neo, mentre il lento, graduale cammino che lo porta a conoscere il mondo reale verrebbe a evocare i diversi stadi epistemici ipotizzati da Platone7. È d’altronde innegabile che l’ammonimento «conosci te stesso», a cui Neo cerca di tener fede, è ben presente nell’epistemologia platonica, oltre che in quella socratica, e che l’identificazione della virtù con la conoscenza può costituire il motivo conduttore dell’intero film. Ciononostante, la scissione platonica tra il mondo delle idee e quello sensibile non corrisponde alla bipartizione di Matrix tra il mondo reale e quello fittizio. Per Platone il mondo sensibile non è fittizio: se il mondo delle idee costituisce la realtà vera e perfetta, il mondo sensibile ne è un riflesso, che esiste in quanto imitazione del primo. In Matrix le cose stanno diversamente.
Sogni, demoni, cervelli
Morpheus chiede: «Hai mai fatto un sogno tanto realistico da sembrarti vero? E, se da un sogno così non ti dovessi più svegliare, come potresti distinguere il mondo dei sogni dal mondo della realtà?». Benché, se da un sogno così non dovessi più svegliarmi, non mi porrei il problema di distinguere tra sogno e veglia, e non ce ne sarebbe (verosimilmente) alcuna ragione cogente, le domande sollevate da Morpheus rievocano l’ipotesi cartesiana del sogno:
Quante volte m’è accaduto di sogna...