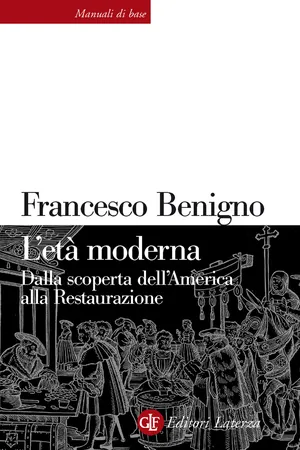
eBook - ePub
L'età moderna
Dalla scoperta dell'America alla Restaurazione
- 392 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
L'età moderna
Dalla scoperta dell'America alla Restaurazione
Informazioni su questo libro
I caratteri principali del volume rispondono alle necessità di chiarezza, sinteticità, completezza indispensabili a un testo che si rivolge in primo luogo agli studenti universitari dei corsi di base. L'obiettivo è quello di fornire uno strumento di studio concettualmente chiaro, conciso e aggiornato con uno stile scorrevole e un uso rigoroso dei termini storiografici.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a L'età moderna di Francesco Benigno,Massimo Carlo Giannini,Nicoletta Bazzano in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Storia e Storia moderna. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
StoriaCategoria
Storia moderna1. Il sogno dell’impero, la realtà di monarchie e repubbliche
L’analisi delle vicende storiche dell’Europa agli inizi di quella che si usa chiamare prima età moderna non può prescindere da un’attenta valutazione dei principali attori politici e dei quadri di riferimento ideali in cui essi si muovono. Ecco perché occorre anzitutto partire dal ruolo dell’impero e dall’idea di monarchia universale ad esso sottesa per comprendere una situazione politica e territoriale quanto mai complessa.
All’inizio del XVI secolo un solo sovrano, Carlo d’Asburgo, riunisce sotto il proprio scettro un enorme e straordinario insieme di possedimenti. Dal padre Filippo, detto il Bello, egli ha ereditato i tradizionali domini della casa d’Asburgo, concentrati nell’attuale Austria, e l’eredità borgognona della nonna, formata dalla Franca Contea e dai Paesi Bassi. Dalla madre, Giovanna, detta la Pazza, Carlo ha ricevuto le corone di Castiglia e di Aragona, che includono i regni di Sardegna, Sicilia e Napoli, nonché le nuove colonie americane. Per giunta, nel 1519, Carlo succede al nonno Massimiliano I d’Asburgo nel titolo elettivo di imperatore del Sacro romano impero della nazione germanica. In pratica, nelle sue mani si concentra il governo di un grande ed eterogeneo conglomerato di territori di cui è il naturale sovrano. Inoltre, in teoria, nella sua qualità di imperatore, Carlo V controlla indirettamente gran parte dell’attuale Germania e la Boemia, suddivise in principati, vescovati e città indipendenti, che pur sostanzialmente autonomi, riconoscono, almeno teoricamente, l’alta sovranità dell’imperatore, cui spetta una sorta di potere di indirizzo e di coordinamento all’interno dell’impero. Per un momento, nella prima metà del Cinquecento, un sogno (o, a seconda dei punti di vista, un incubo) sembra materializzarsi, quello della restauratio imperii, la rinascita dell’impero.

Le quattro eredità di Carlo V
La parola «impero» richiama antiche e importanti tradizioni cui occorre, sia pure rapidamente, accennare. Nella sua fase tarda l’impero romano era stato un impero cristiano e l’imperatore aveva rappresentato una sorta di onnipotente esecutore della volontà divina in terra. La memoria di questo unico, sconfinato potere terreno, costruito a imitazione del potere spirituale dell’unico Dio dell’Antico e del Nuovo Testamento e per questo ammantato esso stesso di sacralità, non aveva da allora più abbandonato l’Europa. Allorché, una volta dissolto l’impero romano, il regno dei franchi – sicuramente il più forte dei regni creati nell’Europa romanizzata in seguito alle cosiddette invasioni barbariche – aveva coltivato ambizioni di espansione e di egemonia su scala europea, non a caso aveva di nuovo guardato all’impero romano come a un modello da imitare. Tra l’VIII e il IX secolo, infatti, il sovrano franco Carlo Magno, con l’appoggio del papato, aveva tentato di fare rinascere quell’antica istituzione universale, adattandola alla nuova realtà dell’Europa medievale: in tale contesto, il giorno di Natale dell’anno 800, papa Leone III aveva incoronato Carlo Magno, attribuendogli il titolo di imperatore del Sacro romano impero. Nel corso del basso Medioevo (secoli XII-XIV) gli imperatori tedeschi come Federico I di Hohenstaufen, detto il Barbarossa (1123-90), o Federico II di Svevia (1194-1250), si erano duramente scontrati con il papato che temeva lo strapotere dell’autorità imperiale e le connesse pretese che i suoi detentori, come rappresentanti della volontà di Dio nella sfera degli affari terreni, potevano avanzare in materia di organizzazione ecclesiale.
Se per il papato la rinascita dell’impero aveva finito per costituire una minaccia, viceversa, per tutti coloro che – come ad esempio Dante Alighieri (1265-1321) – ritenevano pericolose e sbagliate le pretese papali di costituire la massima autorità religiosa e politica della cristianità, il sogno dell’impero, e cioè di una monarchia universale in grado di garantire nella realtà terrena la realizzazione dei valori cristiani (e in primo luogo della pace), rimase a lungo vivo. Per quanto decaduto e ormai circoscritto alla realtà germanico-boema, a cavallo fra Medioevo ed età moderna, l’impero conferisce ancora a chi ne cinge la corona una teorica superiorità rispetto agli altri sovrani e costituisce una fondamentale risorsa di legittimazione giuridica e politica per poteri di natura «pubblica» (principi, città, feudatari, signori) e «privata» (corporazioni, comunità, istituzioni ecclesiastiche). Finché tuttavia a tale autorità universale non corrisponde un’intrinseca forza politico-militare del detentore del titolo imperiale, nessuno ritiene praticabile la prospettiva di una nuova rinascita imperiale. Ciò fino a quando la corona imperiale non si posa sul capo di un sovrano come Carlo V d’Asburgo, che si presenta quale nuovo Carlo Magno e che possiede teoricamente risorse economiche e forze in grado di assoggettare l’intero continente europeo.
Anche in questa straordinaria e irripetibile congiuntura, tuttavia, il sogno della rinascita dell’impero, come del resto rilevò la maggioranza degli osservatori coevi, si dimostra irrealizzabile. Lo stesso Carlo V, che pure ha impiegato le sue migliori energie nel tentativo di ridare vigore all’idea imperiale, deve riconoscere, alla fine della propria vita, l’incapacità a superare le enormi difficoltà legate alla complessità della politica europea e, nella fattispecie, la propria impotenza a tenere unito e a trasmettere a un unico erede il complesso di domini che ha governato. Questa ammissione traspare chiaramente dalla sua decisione di dividere l’eredità asburgica in due tronconi: egli lascia al figlio Filippo II le corone di Castiglia e di Aragona, più i territori dell’eredità borgognona e italiani, mentre al fratello Ferdinando garantisce la successione al trono imperiale, sostenuta dai tradizionali possedimenti asburgici in Austria, cui si sommano le corone recentemente acquisite di Boemia e d’Ungheria. Ciò significa la nascita di due rami dinastici distinti, alleati e imparentati, ma guidati da differenti interessi dinastico-territoriali, e sancisce così apertamente il tramonto della prospettiva di un unico impero cristiano europeo; una prospettiva destinata alla sconfitta e resa inattuabile dalla forza dei nuovi processi che investono l’Europa tra Quattro e Cinquecento: la fine dell’unità religiosa cristiana, i nuovi equilibri territoriali determinati dall’avanzata dell’impero ottomano nel Mediterraneo e dall’avvio dello sfruttamento delle Americhe, ma soprattutto la formazione e il consolidamento in diverse parti del continente europeo di forti poteri monarchici, in grado di sottomettere vaste estensioni territoriali, nuclei di quelle che saranno considerate in seguito alcune tra le più importanti nazioni europee.
1.1. Le nuove monarchie...
L’elemento più importante nello sviluppo delle società europee all’inizio dell’età moderna è la formazione di poteri monarchici che dispiegano la loro autorità su territori di ampie dimensioni. In questi ambiti il potere dei sovrani si esercita più fortemente che nel passato, grazie alla creazione di efficaci ancorché esili strutture burocratiche incaricate del controllo della vita civile e religiosa, dell’amministrazione della giustizia e della riscossione delle tasse, oltre che, naturalmente, di armare in caso di necessità un esercito o una flotta per la difesa del territorio o per la conquista di nuovi possedimenti. Tale sviluppo comporta una graduale trasformazione anche del ruolo della monarchia e dell’immagine dei monarchi.
Tradizionalmente i sovrani erano visti soprattutto come i severi detentori della virtù della giustizia, coloro ai quali ci si rivolgeva per dirimere in giudizio le controversie fra i sudditi; allo stesso tempo essi erano considerati i generosi dispensatori delle grazie terrene, i soli davvero in grado di promuovere e innalzare i sudditi ai principali onori materiali e spirituali. In pratica il re, a somiglianza di Dio, era immaginato come colui che punisce e premia, raddrizzando i torti e ricompensando i meriti, l’unica autorità terrena in grado di riportare un’armonia sociale continuamente messa a rischio dalle passioni e dai peccati degli uomini. Le qualità principali di un sovrano erano perciò considerate l’equanimità e la magnanimità, che si dovevano accompagnare alle funzioni precipue della sovranità, quali la protezione dei beni e delle vite dei sudditi e la difesa della religione, ovverosia dell’unico credo condiviso, quello cristiano.
A queste attribuzioni, tuttavia, i sovrani vengono aggiungendo tra Quattro e Cinquecento nuove prerogative che derivano intimamente dalla crescente capacità di controllo di vasti possedimenti territoriali. Si tratta anzitutto dell’aumento della capacità di prelievo fiscale, reso in parte autonomo dalla contrattazione annuale che ne vincola l’esazione all’assenso delle rappresentanze politiche dei territori (ad esempio gli Stati generali o i Parlamenti). È attraverso l’ampliamento della potestà d’imporre e incassare tasse che le corone riescono a finanziare apparati burocratici stabili (e cioè stipendiati) e soprattutto eserciti e flotte sempre più potenti e tendenzialmente in ferma permanente, cioè pagati in maniera continuativa e non solo in occasione di una guerra, come usava nei secoli precedenti (cfr. infra, cap. 10).
Questa affermazione di potenza comporta due essenziali conseguenze. Nei confronti degli assetti tradizionali interni al regno, si manifesta l’inclinazione dei sovrani a liberarsi di ogni struttura di potere che minacci o condizioni quello della corona. Si pensi anzitutto ai grandi feudatari, abituati da secoli a considerarsi dei «quasi pari» del re, ma si pensi anche alle città autonome, avvezze all’autogoverno e a una sostanziale indipendenza. All’origine della propensione dei sovrani a estendere il raggio d’azione della giustizia regia e a incrementare le forme di controllo del territorio da parte di ufficiali nominati direttamente dalla corona sta dunque essenzialmente l’esigenza di tenere a freno e sotto tutela le tendenziali spinte centripete. E tuttavia questa esigenza fa avvertire il bisogno di un apparato regio più consistente e quindi di maggiori risorse finanziarie per sostenerne il funzionamento, cui si può far fronte solo accrescendo il controllo del territorio, in un processo circolare che acquisirà nei secoli successivi grande rilievo.
Non meno importante è tuttavia un secondo effetto della crescita del potere dei re, e cioè la tendenza di questi ultimi a porre la loro sovranità come indipendente da ogni altro potere esterno e a considerarla come voluta direttamente da Dio. Una sovranità, dunque, che non riconosce alcun potere terreno superiore al proprio. Ne fa le spese anzitutto la teorica supremazia imperiale, che in pratica non viene più riconosciuta né rispettata dai monarchi. Ma rischia di subire conseguenze pesanti anche il papato, nella misura in cui pretende di assoggettare il potere dei re a vincoli che derivano dalla propria supremazia spirituale. La tendenza dei sovrani a non riconoscere altri poteri superiori al proprio comporta, nella migliore delle ipotesi, la tendenza a subordinare le strutture ecclesiastiche al controllo della corona (il che significa avere un ruolo decisivo nella nomina dei vescovi e degli abati, in quanto titolari della gestione di imponenti patrimoni ecclesiastici) e, nella peggiore delle ipotesi, la totale separazione dalla Chiesa di Roma, profittando della storica occasione che si profila con la Riforma protestante (cfr. infra, cap. 5).
I processi di irrobustimento delle monarchie si legano infine al coagularsi di quella che gli storici hanno chiamato formazione delle identità protonazionali. In pratica l’insediamento e la stabilizzazione di monarchie territoriali contribuiscono alla nascita e allo sviluppo di tradizioni e di costumi comuni e all’acquisizione da parte delle classi dirigenti della consapevolezza di far parte, al di là delle pur significative differenze locali e regionali, di un unico organismo politico, vincolato alla continuità delle proprie tradizioni, leggi e costumi.

L’Europa intorno al 1500
Secondo il grande storico ottocentesco svizzero Jakob Burckhardt, le radici dei processi di accentramento politico e di omogeneizzazione amministrativa realizzati nelle «nuove» monarchie hanno la propria radice nella cultura rinascimentale, una cultura in cui lo Stato e la politica vengono percepiti chiaramente non più come riflesso della volontà divina, ma come artifizio umano, fino ad assumere la forma di una vera e propria «opera d’arte» creata dalla virtù di un principe. Nel corso del Novecento, la storiografia è venuta quindi insistendo sulla creazione di possenti apparati burocratici, amministrativi e militari come il segno sicuro della realizzazione di un superiore livello di cultura collettiva. La creazione di un’entità superiore quale la monarchia, incentrata sulla figura di un sovrano, è parsa agli storici il presupposto necessario per l’affermazione di un positivo e progressivo principio di tendenziale uguaglianza dei sudditi. In tempi più recenti, tuttavia, è venuto emergendo dagli studi come la maggioranza delle esperienze monarchiche europee della prima età moderna non sia affatto caratterizzata dall’affermazione sicura dei principi di superamento dei particolarismi amministrativi, culturali e politici nel segno di una sempre crescente omogeneizzazione. Al contrario, mentre il caso della Francia (tradizionale modello di riferimento per l’idea di un percorso storico finalizzato all’edificazione dello «Stato moderno») appare sempre più un caso a se stante, la costruzione delle «nuove monarchie» viene vista come un processo molto più complesso e meno lineare di quanto si ritenesse in passato. In particolare lo storico inglese John H. Elliott ha fatto notare come, nella stragrande maggioranza dei casi, i sovrani europei della prima età moderna siano portatori di differenti diritti di successione sui diversi territori che formavano i loro domini, titoli che venivano accumulati e giustapposti, come tante corone su un’unica testa, senza fondersi in superiori unità politiche, giuridiche e amministrative. Tale agglomerato politico-territoriale, tenuto insieme dalla sola persona del sovrano – e dagli appartenenti alla sua dinastia –, è stato definito da Elliott «monarchia composita».
L’affermazione di principi di parziale razionalizzazione amministrativa e politica deve essere pertanto ricondotta all’esito di un processo, per nulla lineare, volto a inglobare le diverse tradizioni giuridiche e amministrative in complessi politico-territoriali più ampi.
Questi processi si delineano concretamente in alcune realtà significative. La prima e più importante monarchia sulla scena europea è naturalmente quella di Francia, erede diretta del già citato regno franco e retta dalla dinastia dei Valois. La lunga guerra contro l’Inghilterra (chiamata guerra dei Cent’anni, sebbene in realtà si tratti di una serie di conflitti che coprono un arco cronologico ben più lungo, dal 1337 al 1453) consente ai sovrani francesi di cementare l’unità del regno nella difesa dalle pretese di dominio inglesi. I sovrani della casa di Valois, inoltre, sono molto attenti ad attaccare ed eliminare i domini feudali autonomi, potenziali pericoli per la stabilità della corona. È il caso del ducato di Borgogna, un importante e ricco agglomerato territoriale comprendente la Borgogna, la Piccardia, l’Artois, la Franca Contea, il Lussemburgo, il Brabante e la Fiandra, la cui corte ha raggiunto fama europea per splendore e mecenatismo. Il re Luigi XI di Valois (1451-83), al fine di accrescere il proprio potere in Francia, favorisce la disintegrazione del ducato, dopo aver sconfitto l’ultimo duca, Carlo detto il Temerario, suo acerrimo avversario (1477). Sarà lo stesso Luigi XI, negli anni successivi, ad annettere al regno di Francia altri nuclei territoriali che sfuggivano al controllo dei Valois: l’eredità dell’estinta dinastia degli Angiò, comprendente le importanti regioni dell’Angiò, del Maine e della Provenza. Il suo successore, Carlo VIII (1483-98), completerà questo processo sposando Anna di Bretagna, erede del più importante complesso territoriale semiautonomo rimasto in territorio francese, la Bretagna appunto. Tale percorso di aggregazione territoriale è sostenuto dal rafforzamento dell’esercito, reso possibile dall’imposizione di una serie di tasse da versare direttamente alla corona (la taille, la taglia, una tassa diretta annuale gravante sui focolari domestici, gli aides, gli aiuti, percepiti sui beni di consumo corrente, e la gabella del sale) ed è accompagnato da un crescente controllo sulla Chiesa francese, dalla creazione di un’amministrazione stabile e dalla riorganizzazione degli apparati giudiziari.
I successori di Carlo VIII, e cioè i sovrani Luigi XII d’Orléans (1498-1515), Francesco I (1515-47) ed Enrico II (1547-59), procederanno nella loro azione di governo lungo le medesime direttrici, ma in un contesto internazionale di molto mutato, che avrà al suo centro la necessità di limitare sulla scena europea la potenza della rivale casa d’Asburgo, sfruttando a tal fine il vero e proprio terremoto politico e culturale provocato dalla Riforma.
Sconfitta nelle sue pretese di dominare il regno di Francia, l’Inghilterra vive, nei decenni successivi alla conclusione della guerra dei Cent’anni, una serie di conflitti intestini animati dalle due casate contrapposte degli York e dei Lancaster, che si contendono il diritto alla successione sul trono inglese come eredi dell’estinta dinastia dei Plantageneti. Questa stagione di conflitti che, dalle insegne sugli scudi delle due fazioni in lotta, è nota come guerra delle Due rose (1455-85) indebolisce l’autonomia della corona, rendendola fortemente dipendente dall’aristocrazia, nonché dal Parlamento, dal clero e dalle città. Solo con Enrico VII Tudor (1485-1509), erede designato dai Lancaster e marito di Anna di York, la monarchia inglese ritrova una propria capacità di azione politica, mediante la riorganizzazione del sistema fiscale e la creazione della Camera stellata, un tribunale di diretta dipendenza regia che consente al sovrano un’ampia giurisdizione su reati di natura politica. Questa vigorosa strategia, che punta anche su un’espansione commerciale e marittima sostenuta da una robusta flot...
Indice dei contenuti
- Premessa
- 1. Il sogno dell’impero, la realtà di monarchie e repubbliche
- 2. Ordini, ceti e forme della rappresentanza politica
- 3. La scoperta dell’America e gli imperi coloniali
- 4. Umanesimo e Rinascimento
- 5. Solo la grazia salva: la Riforma protestante
- 6. La frontiera mediterranea e l’impero ottomano
- 7. La Chiesa in armi: l’Europa della Controriforma
- 8. Cristianesimo lacerato: l’età delle guerre di religione
- 9. La rivolta dei Paesi Bassi e la nascita delle Province Unite
- 10. Economia e finanze nel secolo dei genovesi
- 11. L’affermazione del barocco
- 12. Un mondo di numeri: la nascita della scienza moderna
- 13. Tra guerra e rivolta: la crisi politica di metà Seicento
- 14. La rivoluzione inglese
- 15. Il Seicento fra crisi e trasformazioni
- 16. Divisione dei poteri, libertà, ricchezza: il modello di società olandese e inglese
- 17. La monarchia di Luigi XIV: l’Europa all’epoca della preponderanza francese
- 18. La seconda rivoluzione inglese e l’affermazione della potenza britannica
- 19. Il gioco delle dinastie: i nuovi assetti politici europei nella prima metà del Settecento
- 20. L’espansione europea e le nuove gerarchie economiche internazionali
- 21. Vita urbana e mondo rurale
- 22. Famiglia, genere, individuo
- 23. Diradare le tenebre: il mondo al lume della ragione
- 24. Il dispotismo riformatore
- 25. Niente tasse senza rappresentanza: la nascita degli Stati Uniti d’America
- 26. La rivoluzione francese
- 27. L’erede imperfetto: Napoleone Bonaparte
- 28. La prima rivoluzione industriale
- 29. Restaurare l’antico regime
- 30. Ancora la rivoluzione