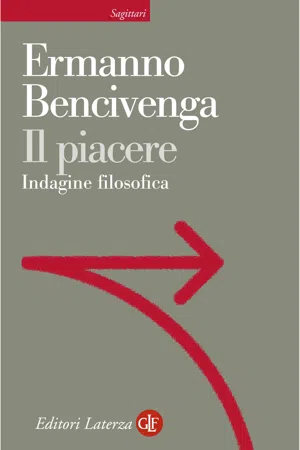1. Troppo vicino per poterlo conoscere?
Mi piacciono gli spaghetti e la pizza, Mozart e i Beatles, la filosofia e il bridge; mi dànno piacere i rapporti sessuali e le camminate in montagna, i film di Hitchcock e le serate in casa con un paio di comode pantofole ai piedi, un buon libro e la pioggia che batte sui vetri. Mi piace insegnare, guidare la macchina, conversare con gli amici e bere vini di Bolgheri. Ci sono persone che derivano piacere dall’umiliare i propri simili, perfino dal torturarli fisicamente. C’è chi prova piacere a torturare sé stesso. È possibile che in tutti questi usi della parola «piacere» e affini si stia parlando della stessa cosa? Certo le esperienze cui facciamo riferimento sono molto diverse. Gli spaghetti e la pizza mi piacciono mentre li mangio, purché abbia fame, e mi disgusterebbero se fossi già sazio; Mozart e i Beatles mi piacciono anche se non li sto ascoltando, mi piace il fatto che esistano, ma in compenso quando li ascolto non mi sazio mai, potrei ascoltarli per sempre. I rapporti sessuali sono accompagnati da una profonda eccitazione e un estremo vigore, e acuiscono le mie sensazioni fino a renderle quasi insopportabili; e da quell’estremo si arriva per gradi, attraverso l’insegnare, il camminare in montagna, il conversare e il guidare, alla quieta inerzia di una serata casalinga, dove ogni fonte di stimolo è attutita, depotenziata, resa inoffensiva, dove sembra che il piacere stia nell’assenza di eccitazione. Molto di ciò che mi piace ha un carattere sociale – mi piace (o mi piace di più) se il piacere è condiviso – ma è improbabile che ciò valga per un dittatore o un sadico. In qualche caso, la natura di un’esperienza piacevole cambia, eppure io continuo a descriverla come piacevole, e come tale proprio nel senso in cui è cambiata: la prima volta (spesso anche la seconda), i film di Hitchcock mi piacevano per quanto m’inquietavano e mi sorprendevano; adesso mi piacciono per quanto ho imparato a riconoscere, con un tono affettivo che non esiterei a definire rassicurante, i piccoli e grandi segni della sua maestria.
La neurofisiologia può dirmi che in tutte queste esperienze è attiva la medesima area del mio cervello, sia essa l’ipotalamo o il septum pellucidum, o che in ogni caso siffatto sono coinvolte sostanze chimiche come le endorfine; ma questo non fa che spostare il problema. Perché mai in un essere umano esperienze così disparate dovrebbero sollecitare un medesimo organo e coinvolgere le stesse sostanze chimiche? Che cosa le accomuna? C’è qualcosa che le accomuna, o devo pensare che il loro afferire al medesimo organo sia un fatto puramente casuale? Io non vivo la mia neurofisiologia; mi affiderei a un neurofisiologo solo se la mia vita fosse minacciata, se ne stessi perdendo il controllo e accettassi di farmi ridurre al contenuto di una cartella clinica o all’esito di una terapia. Normalmente, vivo in un orizzonte di senso, e mi piacerebbe (!) capire che senso ha tutto il discorso sul piacere, ammesso che ne abbia.
Forse non ne ha. Esiste infatti una soluzione semplice e radicale per il problema che mi sono posto: sarà anche vero che l’elenco delle esperienze che causano piacere a un particolare essere umano non è più omogeneo o strutturato di una lista della spesa, ma non importa, perché quelle sono, comunque, le esperienze che tale essere giudica positive e desiderabili. Il piacere è uno stato soggettivo: solo un soggetto (umano, e forse anche animale) può sapere che cosa gli piace, e nessun altro ha sull’argomento alcuna voce in capitolo, né ha il diritto di chieder conto al soggetto della ragionevolezza o coerenza dei suoi piaceri. Questo vale per ogni stato soggettivo: se io dicessi che ho paura dei topi, dei fantasmi e degli organismi geneticamente modificati, o che mi intristiscono i programmi televisivi e le autostrade intasate, e se qualcuno mi chiedesse che cosa unifica le varie cose di cui ho paura o che mi intristiscono, l’unica risposta plausibile sarebbe che quelle cose fanno paura a me o mi intristiscono, punto e basta. Non sarebbe nemmeno lecito contestarmi il fatto che i fantasmi non esistono, o che io so che non esistono, perché ciò non m’impedisce di averne paura e sono io a stabilire di che cosa (reale o fittizia) ho paura: dentro le quattro mura della mia soggettività (per quanto spaventato) sono assoluto padrone. Nel Filebo, il suo dialogo dedicato al piacere, Platone suggerisce una posizione simile quando fa dire a Socrate: «chi, in qualche misura e in qualche maniera, prova un qualsiasi godimento gode sempre realmente, anche se di ciò che non esiste, a volte poi di ciò che non è esistito, e addirittura spesso, forse più frequentemente, di ciò che neppure esisterà mai» (p. 143).
Secondo questa posizione, il piacere è personale e infalsificabile: ognuno prova il suo e l’unica base su cui si può accertarne la presenza è il resoconto di chi lo prova. Esigere una qualche relazione fra i piaceri o una loro comune essenza che giustifichi il chiamarli «piaceri» significherebbe collocare il piacere in uno spazio pubblico, oggettivo, cioè fraintenderne la natura. Se tu e io usiamo la parola «vero», «giusto» o «bello», è legittimo interrogarci su come queste parole siano definite ed eventualmente accusarci l’un l’altro di usarle male, perché si presume che verità, giustizia e bellezza siano le stesse per tutti: tu e io possiamo avere pareri opposti su che cosa siano verità, giustizia e bellezza ma in tal caso almeno uno di noi ha torto, e forse abbiamo torto entrambi. Quando si tratta di ciò che piace a te e a me, d’altra parte, la tua e la mia opinione al riguardo sono tutto quel che conta; e se ci piacciono cose opposte non possiamo far altro che scrollare le spalle e tollerare questa differenza. Tu potrai dirmi che assecondando i miei piaceri avrò effetti perversi o letali, che sarebbe saggio cambiare i miei indici di gradimento o che ciò di cui godo rivela una mente e un corpo malati, ma non potrai mai dirmi che le cose che mi piacciono non mi piacciono. Se io dichiarassi vera l’ipotesi che il Sole ruota intorno alla Terra, giusto il comportamento di chi evade le tasse o bello un centro commerciale, potresti cercare di convincermi altrimenti, cercare di dimostrarmi che l’ipotesi non è vera o il comportamento non è giusto; ma sarebbe assurdo cercare di convincermi che non mi piace la pizza.
Un soggettivista estremo come quello che ho descritto non ha dunque nulla da dire sull’identità del piacere, su che cosa il piacere sia – null’altro che una banalità: il piacere è, per ciascuno, quel che gli piace. La sua natura assolutamente personale, però, genera una forte tendenza a usarlo per definire un altro tipo d’identità: quella, appunto, di una persona. Che cosa sono io? Che cosa mi caratterizza e mi distingue? Potrei rispondere citando le mie credenze, i miei valori o i miei ideali, ma in tutti questi casi mi sentirei costretto, prima o poi, a difenderli, quindi a difendere quel che sono e a riconoscerne implicitamente la fragilità. Forse le mie credenze, i miei valori e i miei ideali sono scorretti; forse dovrei averne altri; e, se così fosse, sarei ancora lo stesso? Qual è il mio «zoccolo duro», il nucleo che mi definisce e che nessuno può negare, o costringermi a rinnegare? Una risposta facile e naturale è: esso include tutto (e solo) quel che mi piace. E infatti, se siamo contestati nelle nostre credenze, nei nostri valori o ideali, e ci troviamo in difficoltà, ci sentiamo naturalmente inclini a slittare verso un linguaggio di personale apprezzamento: a passare da «questo o quello è vero, o giusto, o bello» a «questo o quello mi piace», mettendoci al riparo da ogni critica.
L’altra faccia di tale sicurezza teorica è una pratica dominata dall’angoscia. Quando ogni essere umano è ridotto a un coacervo di pulsioni cieche, ripetitive e perentorie verso il conseguimento del piacere (di quel che per lui è piacere), sorge inevitabile e insanabile un conflitto fra questi esseri, le loro pulsioni e i loro piaceri, e ciascuno è vissuto da tutti gli altri come una minaccia. Nel già menzionato Disagio della civiltà, Freud pone la questione con il consueto disincanto:
Ci chiederemo... che cosa, attraverso il loro comportamento, gli uomini stessi ci facciano riconoscere come scopo e intenzione della loro vita, che cosa pretendano da essa, che cosa desiderino ottenere da essa. Mancare la risposta è quasi impossibile: tendono alla felicità, vogliono diventare e rimanere felici. Questo desiderio ha due facce, una meta positiva e una negativa: mira da un lato all’assenza del dolore e del dispiacere [sono la stessa cosa, dolore e dispiacere, o cose diverse?], dall’altro all’accoglimento di sentimenti intensi di piacere... Come si vede, ... il programma del principio di piacere stabilisce lo scopo dell’esistenza umana... [Ma questo] programma è in conflitto con il mondo intero... È assolutamente irrealizzabile, tutti gli ordinamenti dell’universo si oppongono ad esso. (p. 568)
Che cosa precisamente si oppone alla ricerca del piacere? «La sofferenza ci minaccia da tre parti: dal nostro corpo..., dal mondo esterno... e infine dalle nostre relazioni con altri uomini» e «la sofferenza che trae origine dall’ultima fonte viene da noi avvertita come più dolorosa di ogni altra» (pp. 568-569). È dunque
impossibile ignorare in qual misura la civiltà sia costruita sulla rinuncia pulsionale, quanto abbia come presupposto il non soddisfacimento (repressione, rimozione o che altro?) di potenti pulsioni. Questa «frustrazione civile» domina il vasto campo delle relazioni sociali degli uomini; già sappiamo che è la causa dell’ostilità contro cui tutte le civiltà devono combattere. (p. 587)
Tale sarebbe la tragica realtà sottesa a ogni incontro con il mio prossimo. Possiamo tentare di sfumarla, muovendo dalle varie forme di edonismo individuale all’utilitarismo: la complessa architettura filosofica, morale, politica ed economica elaborata da Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Henry Sidgwick e G.E. Moore. Secondo questa visione, il Bene Supremo è la massima somma algebrica di piaceri e dispiaceri (o dolori; su questa incertezza terminologica, già segnalata sopra in Freud, dovrò ritornare) per la totalità degli esseri umani (o, nelle originarie intenzioni di Bentham, esseri senzienti – il che spiega come l’utilitarismo, nelle mani di Peter Singer, sia diventato una formidabile piattaforma teorica per i fautori della liberazione animale). Ognuno decide per sé stesso che cosa gli piace e quanto gli piace; e noi tutti dovremmo tendere a realizzare una situazione ideale in cui la quantità di piacere complessivo, e magari la sua durata e intensità, siano il più alte possibile, tenendo a mente che il piacere di qualcuno potrà causare il dispiacere o dolore di qualcun altro e si tratterà quindi di calcolare fattori positivi e negativi. Nell’asettica scienza sociale contemporanea, lo stesso schema è formulato con termini meno evocativi di «piacere»; si usano parole più neutre e dall’aspetto più rigoroso quali «utilità» o «preferenza». Ogni individuo ha il suo insieme di preferenze, più o meno chiaramente gerarchizzato (io, per esempio, potrei preferire vivere con la pizza piuttosto che senza, vivere con gli spaghetti piuttosto che senza e, se fossi costretto a scegliere, vivere con la pizza piuttosto che con gli spaghetti), e tale insieme (o profilo) lo guida nelle sue azioni. Poiché le azioni di un gruppo risultano dall’aggregato delle azioni individuali, occorre trovare il modo più equo per aggregare le preferenze; e in un modello simile è difficile pensare a qualcosa di meglio della democrazia elettorale. Ogniqualvolta è necessaria una scelta comune, tutti esprimono le loro preferenze e chi ha più voti vince, il che idealmente vorrebbe dire che quella scelta piace (più delle altre) alla maggior parte dei membri del gruppo. Perché piaccia può essere tema di interessanti analisi psicologiche o sociologiche; ma che piaccia è un dato indiscutibile, e metterlo in discussione vorrebbe dire per chi sposa il più semplice schema utilitaristico «non rispettare le decisioni del popolo». Anche in questa (apparentemente) pacifica, democratica modalità d’incontro, però, l’accordo che permette il costituirsi di una maggioranza è ottenuto mediante un negoziato e un compromesso, quindi attraverso una rinuncia a parte dei propri piaceri, e la rinuncia sarà più cospicua e penosa per le minoranze. Per quanto velata da espressioni edificanti («volontà generale», «libertà di suffragio», «diritti civili»), la Legge che fonda il contratto sociale è dispotica e violenta, proibisce o limita drasticamente il godimento, impone sanzioni a chi gode oltre il consentito. Nel fantasioso linguaggio totemico spesso usato da Freud e accolto da Lacan, manifesta l’autorità di un padre geloso del proprio potere e pronto a castrare i figli che all’autorità si ribellano (e sarebbero altrettanto pronti a castrare lui).
Le tracce di un’antropologia così disperata sono onnipresenti nella tradizione e nell’attualità. All’inizio dell’Etica nicomachea leggiamo:
il volgo e le persone rozze sembrano concepire il bene e la felicità come il piacere. Per questo essi amano la vita che è dedita al godimento... Ebbene, la massa si mostra del tutto simile agli schiavi, scegliendo una vita propria degli animali; tuttavia trova una giustificazione per il fatto che molti di coloro che rivestono cariche direttive hanno gusti uguali a Sardanapalo. (p. 93)
Cioè, potremmo dire (ma poi vedremo che il messaggio di Aristotele è ben diverso): Quanto più uno è rozzo, privo di civiltà e cultura, tanto più manifesta la sua natura animale, il suo essere guidato dalla ricerca indiscriminata di ciò che lo soddisfa. Gli altri, le persone educate, sono quanti hanno adottato la dura disciplina della temperanza (che suona più gentile dell’astinenza ma in fondo non è che astinenza parziale) e sono dunque meglio in grado di controllare l’ambiente e vivere in società. I più abili fra loro, però, in quanto acquistano un grande potere (economico, politico, amministrativo), riescono ad affrancarsi da tale disciplina, ritornando a un comportamento dedito interamente alla propria gratificazione e rivelando così l’ipocrisia generale e gli autentici «valori» comuni. Sebbene con la loro avidità rubino un poco (o tanto) a tutti, questi non possono fare a meno di ammirarli (suggerivo nella prefazione) perché incarnano un ideale che tutti, se fossero onesti con sé stessi, dovrebbero ammettere di perseguire – o di non perseguire solo per timidezza o codardia.
La stigmatizzazione di comportamenti sardanapaleschi emerge costante nella confabulazione quotidiana, con scarsissimi risultati. Il motivo è quello che ho appena indicato: un giudizio negativo etico («è ingiusto») o estetico («è repellente») che si sovrapponga dall’esterno alla nostra concezione dell’essere (in questo caso, umano) criticandola e contrastandola apparirà come un pio desiderio. Se così stanno le cose (così sono le persone), si penserà, a che vale dire che dovrebbero stare diversamente? Se io fossi al posto del tiranno, farei quel che fa il tiranno; con quale legittimità posso dire allora che quel che fa lui è ingiusto o repellente? Anche i pii desideri hanno una funzione, certo; questi, in particolare, esprimono il rimpianto per una condizione umana che avvertiamo in modo oscuro e inarticolato come fraintesa e tradita. Ma il rimpianto non basta e con oscurità e mancanza di articolazione non si va molto lontano: occorre mettersi al lavoro e offrire un quadro diverso di come stanno le cose che sia tanto fonte di speranza quanto quello che ho tratteggiato è fonte di disperazione, entro il quale i nostri giudizi (negativi e positivi) siano formulati in un linguaggio non di mortificazione (rinuncia, astinenza, sacrificio) ma di vitalità e l’etica e l’estetica cui dànno voce siano colonne portanti dell’essere stesso, rispettose della sua struttura, di quanto c’è di più solido e autentico in quella struttura, quanto più rende l’essere tale. Finché la morale sarà concepita come una serie di divieti, di proibizioni contro tutto ciò che ci viene «naturale» fare e desiderare, non potrà essere che un incubo o un pretesto; se vogliamo che conti, che si possa davvero crederci e farsene guidare, dobbiamo associarla a vigore, passione e, sì, anche piacere. Dobbiamo fornire un’immagine dell’umanità per cui Sardanapalo sia meno umano, meno vitale e meno felice di una qualche altra creatura cui dare con gioia la chiave del nostro progetto esistenziale. Nella Repubblica, Socrate affronta un problema analogo quando i suoi interlocutori Glaucone e Adimanto (fratelli maggiori di Platone) lo sfidano a difendere la giustizia senza far appello all’interesse personale e sociale («saremmo ancora giusti se l’anello di Gige ci rendesse invisibili, e come lui potessimo impunemente uccidere il re e violarne la moglie?»); la lunga ed elaborata descrizione di uno Stato ideale che segue è un tentativo di raccogliere la sfida. Che questo tentativo ci convinca o meno, è uno sforzo del genere che è richiesto qui: è inutile prendersela con Sardanapalo finché Sardanapalo rispecchia appieno la nostra antropologia; per farlo con cognizione di causa bisogna fornire un’antropologia diversa, diversi criteri d’identità per ciò che è umano.
Se quello che ho appena descritto è uno scopo degno, lo spazio di manovra per realizzarlo sembra molto stretto, addirittura inesistente. Che il piacere abbia un carattere soggettivo è innegabile: è una sensazione, e solo chi ha una sensazione sa che cosa sente. Nessuno può vedere al posto mio e, anche se vediamo «le stesse cose», è una questione aperta (sulla quale s’indagava parecchio nel Sei-Settecento; Locke, per esempio, ne discute animatamente) se e quanto quel che vedo io sia simile a quel che vedi tu. In modo analogo, solo io posso sapere che cosa mi piace; anche nel caso di un piacere ch...