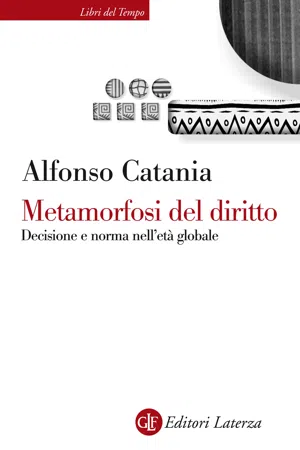
- 214 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Nessuna delle categorie giuridiche intorno alle quali si organizza oggi la teoria del diritto può essere considerata fuori gioco: né la sovranità, né i diritti, né la giurisdizione; e tuttavia, nessuna sembra avere più il significato che le ha dato nei secoli la scienza giuridica. Da una parte si parla di degiuridificazione, deregulation, deroghe ed eccezioni. Dall'altra, mai come in questo periodo è cresciuta l'enfasi sul rapporto diritto-diritti. In un mondo globalizzato il nesso decisione e norma – le relazioni tra decisioni politiche, tecniche economiche e norme giuridiche – è ancora proponibile nei termini tradizionali? Può essere la chiave di lettura di poteri sempre più disarticolati?
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Metamorfosi del diritto di Alfonso Catania in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Diritto e Storia giuridica. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
DirittoCategoria
Storia giuridicaII. La norma
1. Come fare emergere la norma dagli enunciati dati
Il primum da cui muove il nostro ragionamento non può essere che quel fenomeno giuridico che potremmo chiamare dispositivo, riferendoci soprattutto ad una costellazione di elementi più o meno coordinati – dis-posti, dunque posti e positivi – che convergono per ottenere un certo effetto, per essere efficaci nel determinare, stabilizzare o modificare la realtà. È questa costellazione – in verità una nebulosa piuttosto opaca –, la cui coesione è assicurata dalla sola mira all’effettività, a costituire il dato di partenza, ciò che rinveniamo nella realtà. In essa si sovrappongono elementi cartacei: codici, testi, regolamenti, decreti, mandati, documenti; elementi istituzionali più o meno persistenti: organi, rappresentanze, commissioni, organizzazioni, comitati; elementi di prassi e di azione: atti, decisioni, sentenze, accordi, contrattazioni, deleghe, azioni in deroga, negoziazioni. Muovere dalla costellazione del dispositivo, piuttosto che da elementi più formalizzati, più giuridici dello stesso, ci permette di ricomprendere, nella nostra considerazione, tutta la nuova, ampia gamma di forme giuridiche che arricchisce il diritto oggi, mettendone in crisi la descrizione tradizionale.
Solo a partire dalla complessità del dispositivo – e tenendo presente che operiamo astraendo, riducendo, analizzando – è possibile far emergere le categorie che, come si è detto introduttivamente, possono guidarci a comprendere meglio la mutazione attuale del fenomeno giuridico: la norma e la decisione. A mio avviso, infatti, categorie come queste, piuttosto generiche e formali, risultano paradossalmente strumenti euristici ancora più adeguati oggi di quanto non lo fossero nell’analisi dell’ordinamento moderno, proprio perché capaci di disarticolare il complesso sistemico del dispositivo: l’intreccio di momenti decisionali e politici in cui si origina, le forme che assume per influire sul sociale, i rapporti che instaura con cultura e mentalità, gli scambi simbolici e comunicativi con cui si contamina, la rete di ricezioni che suscita, i comportamenti che vi si conformano o meno.
Come si vede da questo sommario elenco, l’operazione di far emergere il momento normativo (ma la stessa cosa avverrà quando cercheremo di individuare la traiettoria decisionale) implica un’operazione costruttiva e teorica, in quanto nei dati offerti dal fenomeno giuridico la norma non è in sé, come norma, rinvenibile: è il documento, il codice, il verbale di negoziazione o quant’altro ne sia il riferimento che viene interpretato come norma1. Ovviamente si tratta di un’operazione che viene messa in atto a più livelli e, spesso, senza alcuna problematizzazione. È la scienza giuridica, come vedremo, che solleva il problema logico dell’enunciato giuridico da considerare come norma, inserendolo così nella sistematizzazione giuridica; gli altri, i consociati, gli organi, la gente comune, operano questa identificazione della norma in una chiave empirica e pratica. La problematica del profilo logico oppure empirico, conoscitivo oppure pratico del concetto di norma ha molto rilievo in un approccio metodologico di tipo analitico: la separabilità della dimensione conoscitiva da quella pratica è, come ho detto più volte, indispensabile, a mio avviso, non solo e non tanto per la purezza scientifica, ma perché è necessaria per delineare una forma di prassi critica.
Ma si tratta, è bene ricordarlo ancora una volta, di un’operazione astrattiva su un materiale, una fattualità assai confusa, e per di più di un’operazione con un doppio livello di astrazione, quello empirico e quello logico appunto: almeno per come la denotano i più rigorosi logici analitici2.
Da parte mia, volendo cercare di afferrare la trasformazione del diritto contemporaneo in modo da rimanere fedele alla sua concretezza, per quanto possa essere contraddittoria, ritengo che alcune di queste distinzioni possano essere proposte in modo sfumato e apparire come dimensioni diverse di un’unica, complessa azione di identificazione del giuridico. Azione di identificazione che non può essere ridotta al momento descrittivo, cui magari si accompagna l’organizzazione in modo sistematico del materiale descritto, attraverso il concetto di ordinamento o di istituzione: come se si trattasse esclusivamente di presentare la massa proteiforme dei dati giuridici rilevanti al fine di renderla utilizzabile da funzionari, avvocati, giudici o da parte di chi, essendo soggetto al diritto vigente, deve conoscerlo per manipolarlo per motivi professionali o personali. Non si tratta solo di descrivere, dal momento che ho parlato di far emergere le norme dal materiale dato: significa piuttosto utilizzare una logica dell’interpretazione. Operare su quel materiale, facendone emergere le norme, significa interpretare.
E siamo dunque di nuovo alla questione affrontata nel capitolo precedente. La logica richiesta da questa operazione è di natura logico-deduttiva o di natura ermeneutica, quindi una forma di razionalità pratica, che sembrerebbe più adeguata alla interpretazione giurisprudenziale? Privilegiare quest’ultima forma di razionalità orienta poi l’intera costruzione del diritto nel senso della centralità dei tribunali e delle corti e rende cruciale il tema della natura normativa dei principi generali e delle norme implicite nella enunciazione dei diritti costituzionali. Questa scelta ha come conseguenza l’apertura del sistema giuridico alla morale, al senso comune, all’influenza di altre sfere della vita sociale. La scelta della logica ermeneutica nell’interpretazione del materiale giuridico è peraltro spinta esattamente dalla prassi giuridica attuale, sempre meno distintamente articolata tra momento conoscitivo e momento pratico, dalla commistione di fatto tra diritto ed etica, dall’ingresso prepotente dell’etica e dei valori, soprattutto come effetto della globalizzazione, nel disciplinamento politico-giuridico delle azioni umane3.
Come ho accennato in precedenza, la prassi giuridica contemporanea si apre sempre più spesso al (o autorizza esplicitamente il) ricorso a norme extragiuridiche di natura morale, facendone derivare conseguenze giuridiche. È chiaro che l’attività ermeneutica sui principi che si presume siano sottesi al sistema nel suo complesso appare preponderante e decisiva. Si diffondono teorie inclusive più o meno forti anche all’interno delle prospettive positiviste, accanto, ovviamente, al rilancio del diritto naturale che, come sempre, non ha problema alcuno a colmare le lacune e a individuare soluzioni di diritto ai nuovi problemi etici: basta guardare alla natura! Salvo poi rinvenire, in luogo della natura, un codice di manipolabilità e di flessibilità assoluta piegato alle ragioni economiche.
Ma la mia analisi della logica ermeneutica e della razionalità pratica, che evince dal contesto culturale le coordinate per far emergere norme è intenzionata, piuttosto che a criticare queste forme e il loro ricorso a principi di prudenza, ragionevolezza, saggezza (virtù che se ci sono e, quando ci sono, sono benvenute), a sottolineare il carattere non induttivo della operazione che gli interpreti-ermeneuti compiono alla ricerca delle norme.
Se è vero che l’operazione non è riconducibile, come vorrebbe la rigida assiomatica giuridica, al logicismo deduttivo, essa, però, non si limita ad indurre dal contesto culturale ed etico principi generali che vi sarebbero immersi; contiene invece potenti iniezioni di volontà creativa che, infatti, i più avveduti rappresentanti di quel tipo di razionalità pratica sanno riconoscere. E creatività significa politicità.
Dall’altro canto sta, con appeal sempre decrescente, la logica deduttiva, che applica la logica formale e la logica dell’inferenza ai sistemi normativi: logiche per le quali è possibile dedurre assiomaticamente da un insieme finito di enunciati assiomatici di base la totalità delle conseguenze4. Una serie di considerazioni realistiche inducono a pensare che oggi questo processo di assiomatizzazione e di deduzione – che pure offre analisi formali innovative e qualche volta destabilizzanti rispetto al senso comune, aprendo prospettive inedite – sia incapace di afferrare la complessità del diritto attuale, se mai sia stato possibile che ci riuscisse una volta. Basti pensare alla caduta del presupposto che viene enunciato come condizione primaria per una indagine di questo genere: la finitezza del sistema, che oggi viene smentita dalla indeterminatezza e apertura indefinita del giuridico; conseguenza, questa, dell’indebolimento della sovranità statuale che reggeva quell’unità finita, ma conseguenza anche di una pluralità di fonti, irriducibile, nella globalizzazione, ad una qualche coerenza.
Ma, in verità, sono tutte le proprietà formali dei sistemi normativi ad essere problematiche e smentite dai fatti: la completezza, la coerenza, l’indipendenza.
Perché allora richiamare, nell’operazione della emersione delle norme, una sistematicità così dichiaratamente formale e sintattica, così indifferente al mondo delle decisioni e dei comportamenti che ho detto di voler mantenere al centro dell’indagine? Si tratta di una sistematicità che, paradossalmente, converge, sia pure in chiave molto diversa, sugli esiti della tradizione giuridica di Ugo Grozio, Samuel Pufendorf fino a Immanuel Kant e Johann Gottlieb Fichte – dunque la tradizione del diritto naturale – e della razionalità positivista della dogmatica ottocentesca (di cui pure critica la rozzezza scientifica). Esiti che fanno della scienza giuridica e della conoscenza del diritto, ancora una volta, una scienza razionale e ideale, la quale di quello che fanno gli uomini realmente e concretamente, come di quello che è il contenuto degli enunciati normativi, non si occupa più di tanto. Una sistematicità contro il cui deduttivismo si sono schierati con discreto successo, ancora nel secolo scorso, le scuole sociologiche e realistiche nordamericane e scandinave, che hanno eroso il concetto stesso di sistema, cercando di fondare invece su osservazioni empiriche l’identificazione di ciò che è normativo.
Ebbene, a me sembra che la logica deduttiva – nel senso non del movimento dal generale al particolare, ma nel senso della coerenza tra premesse e conclusioni – ha l’unico ma importante vantaggio, che vorremmo mantenere nella nostra argomentazione, di considerare normativi quegli enunciati che «connettono un caso ad una soluzione»5 o, con altro lessico, quegli enunciati che connettono ad una norma una decisione o conseguenza normativa. Non va fatto l’errore, peraltro molto diffuso, di considerare questo ragionamento deduttivo come predeterminato e meccanico nei risultati. La deduttività non significa meccanicità, perché sarebbe tale solo se esistessero procedimenti che determinano in modo univoco passaggi conoscitivi e soluzioni decisionali. Il fatto di essere logicamente implicata nelle premesse non significa affatto che essa sia meccanica, soprattutto se si pensa che la ricerca della decisione è sempre funzionale ad un fine determinato. Basti pensare d’altronde alla teoria dell’interpretazione kelseniana, che riconosce il tratto autoritativo (e dunque logicamente indeducibile) della decisione giudiziale in ogni gradino dello Stufenbau!
Alleggerendo quindi questa prospettiva logica del caratteristico formalismo – che garantisce il rigore del ragionamento, ma lo esula dalla complessità del reale e suscita ostilità diffusa nei giuristi – e rivedendo radicalmente l’idea di sistematicità, mi sentirei di affermare che, come siamo interessati ad assumere la razionalità pratica liberandola dalla pretesa di indurre dal contesto concreto una normatività che vi è insita e riconoscendo in essa una potente azione interpretativa e creativa e dunque politica, così possiamo ricorrere alla prospettiva logica deduttiva per individuare il legame che, all’interno del nebuloso, eterogeneo fenomeno che stiamo osservando, si dà tra un enunciato, di qualsiasi genere, e una conseguenza che ad esso viene riferita: anche se ciò avviene, è bene ricordarlo, in una modalità deduttiva che è tipica della normatività e dunque non necessitata e univoca come un processo meccanico. Nel processo di individuazione di una norma a partire dagli enunciati e dai testi ci sono momenti di ragionamento deduttivo (quando chi opera desume norme complesse dagli enunciati dati), e certamente va mantenuta una implicazione logica quando si mettono in relazione le premesse con la conclusione, ma l’attività di costruzione di quella norma e di ricostruzione del contesto normativo, nonché la riformulazione interpretativa che mette in evidenza principi generali impliciti, è tutt’altro che meccanica, densa di creatività e immaginazione. Il che non significa che ciascun operatore/conoscitore del diritto, nel compierla, crea nuovi enunciati normativi (compito creativo del legislativo spesso confuso con questa); significa piuttosto che la conoscenza stessa, l’approccio cosiddetto logico non è puramente descrittivo, ma è denso della dimensione innovativa, dunque in qualche modo responsabile, e, inutile ripeterlo, politica.
2. Norme-sapere. Il ruolo della conoscenza e dei giuristi-tecnici
Quale sarà la norma che emergerà dai dispositivi giuridici? Facciamo un esempio: se Tizio viene investito del compito di presiedere un seggio elettorale, troverà una serie di norme che regolano il corretto funzionamento delle operazioni elettorali: sembra quasi, nel linguaggio quotidiano, che esistano come entità oggettive delle cose chiamate norme che debbono essere rese operanti. Il linguaggio è ambiguo, perché ad un’indagine più dettagliata risulta che di oggettivo non c’è niente. Non nel senso che non esista una regolamentazione ben precisa delle operazioni elettorali, ma nel senso che a Tizio si presenteranno una serie di testi, regolamenti, dispositivi amministrativi, con alle spalle un certo numero di altri enunciati legislativi e addirittura costituzionali, che solo attraverso un’operazione di identificazione e qualificazione di questo materiale come giuridico daranno luogo a norme adatte ai fini di un comportamento corretto e dunque ad atti decisionali validi ed effettivi. Si badi bene, lo stesso fatto che il presidente del seggio venga riconosciuto in questa sua qualità deriva dal fatto che certi enunciati, documenti...
Indice dei contenuti
- Introduzione. Crisi dell’ordinamento e della neutralizzazione giuridica
- I. Positività e politicità del diritto
- II. La norma
- III. Il riconoscimento
- IV. La decisione
- Conclusioni in forma interrogativa