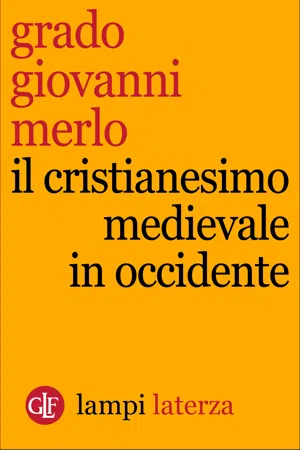
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Il cristianesimo medievale in Occidente
Informazioni su questo libro
Dal VII-VIII secolo alla Riforma protestante il cristianesimo occidentale si struttura nella particolare forma del cattolicesimo romano. La robusta tradizione del primato occidentale del vescovo di Roma si trasforma in superiorità dottrinale e giuridica su tutta la "cristianità" e il cattolicesimo di Roma opera una comunanza istituzionale e culturale in tutte le aree cristianizzate. Una sintesi di questo periodo ricco di mutamenti che hanno influenzato profondamente questa parte di mondo, fino ai giorni nostri.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Il cristianesimo medievale in Occidente di Grado Giovanni Merlo in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Teologia e religione e Storia del cristianesimo. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
Teologia e religioneCategoria
Storia del cristianesimoIl cristianesimo medievale in Occidente
1. Introduzione
Nel lungo periodo che va dal VII-VIII secolo alla Riforma protestante si definisce un cristianesimo peculiarmente occidentale non solo nella distinzione dal cristianesimo bizantino, ma per evoluzione e mutamenti interni. Non si pensi però che siffatto cristianesimo non abbia coscienza di rappresentare la cattolicità, ovvero l’universalità della fede in Gesù Cristo. Anzi, i lenti processi che conducono alla strutturazione del cristianesimo occidentale nella particolare forma del cattolicesimo romano, sono ripieni di ideologia universalistica, sia pur nell’accezione specifica di ideologia religiosa. Questo è il risultato storico di più alto significato e di più lunga durata (oltre che di perdurante realtà). Insomma, la cattolicità romana diventa tale – cattolicità romana in quanto «chiesa» convergente e culminante nel papato romano, che via via assume i connotati di monarchia pontificia – in quell’età che può essere detta contestualmente Medioevo occidentale. L’ideologia tende a coincidere con un’ecclesiologia attraverso uno sforzo intellettuale e organizzativo di straordinario rilievo. Così a partire dalla seconda metà dell’XI secolo la robusta tradizione del primato occidentale del vescovo di Roma si trasforma in superiorità dottrinale e giuridica su tutta la «cristianità», ossia sulle aree di cristianizzazione più o meno recente coincidenti con l’ambito geografico che ancor oggi siamo usi definire come Europa occidentale. Con ciò non si intende certo dire che l’Europa, in quanto area che oggi si vorrebbe unificata politicamente, sia un prodotto ecclesiastico; questo sarebbe, tra l’altro, contraddittorio rispetto alla stessa volontà universalistica della chiesa cattolico-romana. Tuttavia, uno degli elementi comuni che collegano paesi tra loro anche molto lontani è certamente il cristianesimo, ovvero il cattolicesimo romano.
La comunanza si presenta soprattutto a livello istituzionale e culturale. La chiesa occidentale, in primo luogo, produce strutture territoriali ed ecclesiastiche del tutto simili: regioni metropolitane o arcidiocesi, diocesi, pievi o parrocchie. Il cristianesimo si definisce secondo suddivisioni spaziali, alle quali corrispondono specifiche competenze sacramentali e disciplinari. Elementi di complicazione non mancano per la consistente presenza di monasteri e canoniche regolari «esenti», oltre che di chiese variamente collegate a poteri autonomi. Ma la chiesa occidentale è eminentemente una chiesa «sacerdotale», ossia episcopale in quanto i vescovi sono considerati in possesso della pienezza del sacerdozio. Orbene, su tale fondamento si inseriscono i processi di esaltazione del papato romano, identificato come vertice di un ordinamento ecclesiologico ed ecclesiastico: al vescovo di Roma sarà riconosciuto un diritto universale di intervento, una «pienezza di poteri» che non sarà limitata al corpo ecclesiastico, ma si estenderà, in modo giudicato legittimo, a ogni e qualsiasi aspetto della convivenza umana. La monarchia pontificia si farà ierocrazia, inducendo fenomeni di aspra concorrenza da parte dei detentori del potere pubblico, concorrenza conflittuale che, in particolare, logorerà papato e impero nel corso di una lotta secolare. Monarchia pontificia significa ancora costruzione di organismi centrali, curiali, e di una burocrazia in grado di intervenire con efficacia in ogni parte della cristianità, e, nel contempo, sviluppo di un pensiero giuridico e di un’attività normativa – il diritto canonico – capaci di dare fondamento legale al potere pontificio e di far funzionare in modo ordinato le istituzioni di chiesa.
In secondo luogo, nei secoli qui considerati avviene una larga omogeneizzazione, se non proprio unificazione, di riti e liturgie. È il primo piano dell’unità culturale, che si realizza in ambito sia elitario sia «popolare». Non si sottolineeranno mai troppo i fenomeni di circolazione «orizzontale» della cultura scritta e degli «intellettuali», fenomeni che pervengono al loro culmine con la fondazione di istituzioni originali quali le Università. C’è pure un’intensa circolarità «verticale» della cultura secondo una duplice direzione, dall’alto verso il basso e viceversa. Le elaborazioni religiose delle élites chiericali attraverso la predicazione, la cura d’anime, la ritualità, l’iconografia, l’architettura, si trasmettono e pervengono a ogni livello sociale: per contro, il patrimonio delle tradizioni folkloriche, quando non sia affatto respinto e annichilito, perviene al pensiero «colto», che lo metabolizza e lo riutilizza a proprio arricchimento, assai spesso riproponendolo in forme cristianizzate.
Se queste sono alcune linee lungo le quali si formano taluni dei caratteri principali del cristianesimo occidentale – per cui è talvolta difficilissimo, se non impossibile, distinguere la storia del cristianesimo dalla storia politica, sociale, economica, culturale –, non si deve dimenticare quanto ricche si facciano le sperimentazioni religiose a partire dall’XI secolo proprio in corrispondenza con i processi di centralizzazione e di burocratizzazione del corpo ecclesiastico: sperimentazioni religiose che talvolta non giungono nemmeno a consolidarsi e assai spesso si pongono in singolare contrasto con la volontà di inquadramento delle gerarchie ecclesiastiche. Ne deriva una dialettica molto vivace che non sempre trova una sintesi, ovvero un riconoscimento istituzionale e, dunque, un incorporamento nell’organismo ecclesiastico. La storia del cristianesimo medievale in Occidente è anche storia di occasioni mancate, di repressioni violente, di chiusure ottuse, di conflitti di classe, di esclusioni drammatiche.
Di quanto sinora rapidamente illustrato si cercherà di dar conto in questo tentativo di sintesi: nella piena consapevolezza che di tutto non sarà possibile parlare, che non si potranno sciogliere tutti gli intrecci tra cristianesimo e società, che non si potranno seguire tutti gli sviluppi istituzionali, dottrinali, liturgici. Si cercherà invece di descrivere quei fenomeni che risultano di maggior rilievo oggettivamente e soggettivamente, ossia in considerazione degli effetti storici da essi provocati e in dipendenza dalle prospettive interpretative e valutative alle quali una qualsivoglia ricostruzione storica non può sottrarsi.
2. Orientamenti occidentali del cristianesimo e fondazione dell’Europa cattolico-romana
L’occidentalizzazione del cristianesimo è il risultato di un processo plurisecolare difficilmente riassumibile e presentabile in modo rapido. Pertanto, limitiamoci alla constatazione che gli storici, grosso modo, concordano nel rilevare che l’Europa occidentale comincia a diventare tale con l’età carolingia, ossia al volgere dall’VIII al IX secolo, quando la potenza franca si incontra con il papato: incontro anticipato dalla lunga gestazione della fusione latino-germanica iniziata al tempo dei re merovingi per accelerarsi sotto i primi Pipinidi. Insomma, vere cesure e autentici punti di partenza sono assai difficili da stabilire, perché i termini si spostano facilmente in relazione ai parametri e alle prospettive dei singoli storici. Oggi, abbandonate le ambizioni di pervenire a sistemi interpretativi dalla cogente esclusività, si è più cauti e attenti a proporre visioni univoche, rigide e onnicomprensive, quando non onnivore, considerate indebite «riduzioni a uno» di fenomeni storici invero assai complessi e aperti. Sono tramontati così la «santa romana repubblica», come il «Medioevo cristiano», per limitarci alle interpretazioni più famose e vulgate della storiografia italiana.
Si è più attenti persino a cogliere un Medioevo definibile come tale non in base a criteri astrattamente cronologici o meccanicamente unificati: un Medioevo che non sia sèguito e premessa di periodi assai più gloriosi di quanto esso non possa essere, un Medioevo che non sia un’età di transizione tra epoche inevitabilmente più importanti del Medioevo stesso – l’Antichità e l’Età Moderna –, ma che trovi la sua ragion d’essere in se stesso; un Medioevo che, però, è inevitabilmente occidentale, proprio in base ai caratteri generali e peculiari che quel determinato periodo ebbe nell’Europa occidentale e soltanto nell’Europa occidentale. Ciò non implica che, nel contempo, si debba avere una cristianità peculiarmente occidentale coincidente tout court col Medioevo, cioè che si debba avere un «Medioevo cristiano», un Medioevo che per essere tale debba essere cristiano. Semmai è il contrario: è il Medioevo occidentale che ha un cristianesimo medievale occidentale, il quale si mantiene in continuo rapporto dialettico con l’evoluzione complessiva e particolare della società: un cristianesimo, dunque, come uno degli elementi costitutivi di un periodo storico coinvolgente un’area geografica certo diversificata, ma non tanto da non avere destini incrociati, caratteri comuni e organiche relazioni.
Quand’è allora che il cristianesimo si fa medievale e occidentale? E che cosa significa che il cristianesimo si connoti come medievale e occidentale? Sono domande di vastissima portata, per rispondere alle quali occorrerebbe una trattazione assai più lunga e specifica di quanto sia possibile e lecito nel presente contributo. In questa sede limitiamoci a suggerire che il cristianesimo si fa medievale e occidentale quando si realizza l’incontro e la fusione delle tradizioni germaniche con quelle latine attraverso la mediazione della cultura greco-romana e degli uomini di chiesa, con ciò allentando e quasi abbandonando i legami con il mondo bizantino, ovvero non avendo più necessità di riferimenti, per dir così, strutturali con il cristianesimo orientale. È indubbio che queste condizioni si creino con la convergenza tra regno dei Franchi e papato, pienamente realizzatasi nell’VIII-IX secolo. I percorsi per giungere a tale risultato non furono obbligati, anzi, nella loro complessità e polidirezionalità, prendono strade che si possono definire casuali, di una casualità che soltanto nei suoi esiti si fa cogente.
Le premesse, muovendo dagli esiti, sono facilmente individuabili. Il pensiero corre inevitabilmente alla conversione di Clodoveo sul finire del V secolo e al significato «provvidenziale» ad essa subito attribuito dall’episcopato galloromano, alle missioni dei monaci irlandesi al volgere dal VI al VII secolo e, dunque, alla cristianizzazione delle popolazioni germaniche ancora politeiste, alla strutturazione ecclesiastica del mondo germanico secondo i modelli episcopali mediterranei, alle missioni anglosassoni della prima metà dell’VIII secolo, al grandioso fenomeno di acculturazione cristiana di aristocrazie e popolazioni, alle modificazioni dello stile di vita episcopale nella simbiosi dell’alto clero con le aristocrazie militari, alle occasioni colte – in modo più o meno consapevole rispetto alla loro portata «futura» – dai Pipinidi-Carolingi per collegarsi col papato romano in modo diretto e privilegiato trasformando la loro prevalenza «franca» in una dominazione di vastissime ambizioni politiche e culturali. Tra tutti questi tratti e fenomeni un punto di partenza pur occorre scegliere. Muoviamo allora dal momento in cui tra VII e VIII secolo una nuova generazione di missionari, di provenienza anglosassone, si portò nel cuore del continente europeo.
Qui quei missionari, cresciuti nella rigida disciplina ascetica e morale del monachesimo insulare, si trovarono di fronte a un episcopato dal costume violento e dai comportamenti certamente estranei a un rigoroso e composto stile di vita proprio della tradizione vescovile romano-ellenistica: la stessa organizzazione ecclesiastica da tempo non ruotava più intorno ai metropoliti, né contemplava periodiche riunioni sinodali, importanti occasioni per interventi disciplinari e normativi. Di tutto ciò e di altro ancora è testimonianza esplicita e preziosa la lettera che il monaco Bonifacio inviò a papa Zaccaria – ultimo di una lunga serie di papi di origine greca –, immediatamente dopo l’elezione di questi, agli inizi degli anni Quaranta dell’VIII secolo. Bonifacio non era il nome originario di questo monaco anglosassone: egli, nobile del Wessex, si chiamava Wynfrith. Dopo essersi recato a Roma, assunse il nome di Bonifacio e fu creato da papa Gregorio II vescovo missionario. Dopo aver operato per decenni – sempre a nome del papato romano – tra le popolazioni di recente assoggettate dai Franchi, morì martire tra i Frisoni nel 754.
Orbene, dalla ricordata lettera a papa Zaccaria – secondo i cui suggerimenti Bonifacio intende agire – si ricavano preziosissime indicazioni sia sulla situazione della chiesa franca, sia sulle prospettive di intervento che Bonifacio intendeva attuare in stretto collegamento, per un verso, col papato e, per altro verso, con i Pipinidi. Innanzitutto egli provvede a organizzare territorialmente le aree a oriente del Reno secondo distretti diocesani, elevando a città/sedi episcopali diversi luoghi fortificati. In secondo luogo, vuole soddisfare alla richiesta di Carlomanno, primogenito di Carlo Martello, di indire un sinodo per la riforma di episcopato e clero franco, per porre rimedio a una situazione ecclesiastica assai insoddisfacente: come abbiamo già ricordato, da parecchi decenni i prelati non si riunivano più, né le sedi episcopali si raccordavano con le sedi metropolitiche; il clero viveva «tra fornicazioni e turpitudini»; i vescovi non trovavano contraddittorio, rispetto al loro alto ministerio, darsi all’ubriachezza, alla caccia, alla guerra, combattendo personalmente e versando «il sangue dei pagani e dei cristiani».
Insomma, la lettera testimonia la convergenza del movimento riformatore di ispirazione monastica e papale con il vertice del regno franco, che a metà dell’VIII secolo doveva passare definitivamente e istituzionalmente sotto i Pipinidi-Carolingi. Nel 751 Pipino il Breve, proclamato re, ricevette l’unzione dai vescovi e, probabilmente, dallo stesso Bonifacio: unzione rinnovata tre anni dopo da papa Stefano II in persona, recatosi in Francia per sollecitare l’aiuto contro i Longobardi. In tali fatti vi sono le premesse per le successive unzione e incoronazione, famosissime, di Carlo Magno nell’800 da parte di Leone III. Era così sanzionata una convergenza politica e culturale, che aveva comportato, tra l’altro, la definitiva sconfitta dei Longobardi nel 774 e il non meno definitivo distacco dalla corte imperiale di Costantinopoli. L’ideologia imperiale cristiana si rivolgeva a destinatari peculiarmente occidentali, come occidentali si facevano sempre più la prassi e le teorie ecclesiastiche ed ecclesiologiche. Ideali cristiani e motivi politici si intrecciano in modo indissolubile nella fondazione dell’Europa cattolico-romana: e siffatto intreccio si prolungherà per secoli. Tuttavia questa considerazione non deve impedirci di cogliere e di ritagliare la specificità delle vicende ecclesiastiche e religiose.
Ritornando alla lettera di Bonifacio a papa Zaccaria, non possiamo fare a meno di sottolineare come gli intendimenti riformatori del monaco anglosassone siano condivisi da Carlomanno, il quale percepisce l’importanza fondamentale della restaurazione dell’ordinamento ecclesiastico nei processi di costruzione della propria dominazione politica. In coerenza, e per converso, i Pipinidi-Carolingi offrono la loro forza coercitiva a supporto efficace dell’azione di riforma disciplinare dell’episcopato e del clero, e di riordinamento territoriale, secondo modelli vescovili, dell’organizzazione ecclesiastica. Il supporto si dirige nondimeno verso la conversione delle popolazioni germaniche politeiste o non ancora pienamente cristianizzate. Si pensi, per esempio, alle ripetute e assai cruente campagne di Carlo Magno contro i Sassoni: la conversione di queste ostinate genti fu ottenuta attraverso stragi inesorabili, seguite o accompagnate dall’emanazione di norme altrettanto inesorabili. La fondazione dell’Europa cattolico-romana avveniva dunque nella sovrapposizione di desiderio di martirio, di intolleranza sanguinosa e di violenza conquistatrice. Ma su questi aspetti torneremo più avanti. Soffermiamoci ora su alcuni elementi del cristianesimo di età pipinide-carolingia.
Se rivolgiamo nuovamente l’attenzione alle informazioni fornite dalla lettera di Bonifacio, l’episcopato franco risulta certo lontano dal composto e ordinato modello vescovile grecoromano: risulta, però, al tempo stesso un episcopato che sembrerebbe non trascurare la celebrazione dei riti, né tralasciare i compiti di intermediazione sacrale e, persino, di predicazione – supponiamo elementare – del Vangelo. È proprio a tale proposito che il monaco-missionario manifesta il suo sdegno: il clero che celebra i riti, che esercita le funzioni sacrali e che legge i testi sacri, si macchia di comportamenti indegni per chi sia diacono, presbitero o, addirittura, vescovo. Anzi, la gravità della situazione consiste nel contrasto tra la «santità» delle funzioni sacerdotali e la «peccaminosità» disordinata del costume degli uomini di chiesa. L’appello di Bonifacio al papa è di fornirgli indicazioni per interventi riformatori che siano coerenti con i «canoni ecclesiastici»: nella prospettiva di imporre un sacerdozio sacralmente ispirato ai valori ascetici e virginali, nettamente distaccato dalla «carnalità» del mondo e dei rapporti interpersonali. D’altro canto, in linea con un’ispirazione veterotestamentaria e con la suggestione dei Libri penitenziali introdotti sul continente dai monaci insulari, siffatti ideali saranno estesi anche ai comportamenti dei laici: per esempio, con l’imporre ai coniugi l’astensione dai rapporti sessuali in taluni periodi dell’anno, con l’attribuire alla puerpera una condizione d’impurità.
Sono fatti, indicazioni e orientamenti che, com’è facile comprendere, avranno lunghissima durata nel cristianesimo del Medioevo occidentale. Non diversamente di lunga durata sono le decisioni circa l’uniformazione delle credenze teologiche e delle pratiche cultuali, oltre che alcuni provvedimenti presi in età pipinide-carolingia. A metà dell’VIII secolo si stabiliscono l’obbligo della fe...
Indice dei contenuti
- Il cristianesimo medievale in Occidente
- Bibliografia
- L’autore