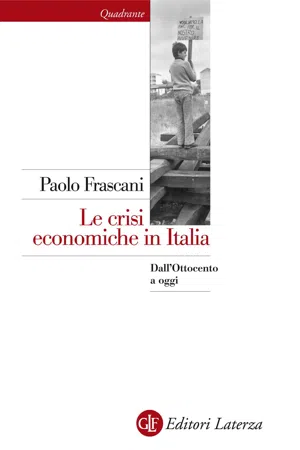
- 300 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
L'attuale crisi economica pone l'esigenza, finora poco avvertita, di interrogarsi sul modo in cui eventi simili siano stati, in passato, affrontati e percepiti. Paolo Frascani analizza tre momenti salienti della storia economica dell'Italia contemporanea: la depressione di fine Ottocento, la recessione tra le due guerre mondiali e quella causata dagli shock petroliferi degli anni Settanta del secolo scorso. Tre fasi destinate a influenzare profondamente, oltre agli assetti finanziari e produttivi, anche la storia sociale e politica dell'Italia, segnando mentalità e saperi del tempo della crisi.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Le crisi economiche in Italia di Paolo Frascani in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Economics e Economic History. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
EconomicsCategoria
Economic HistoryIII. L’altro volto dello sviluppo: la crisi degli anni Settanta
1. Premessa: dagli anni del boom alla crisi internazionale degli anni Settanta
Tra la depressione intrabellica e quella dell’inizio degli anni Settanta corrono poco più di quarant’anni. Un arco di tempo che rappresenta una rottura epocale nella storia del paese. Guerra e dopoguerra, distruzioni e ricostruzione, in un nuovo sistema di regole economiche per il mondo occidentale, contrassegnano l’avvio dei golden twenty dell’Europa dei miracoli.
L’Italia riesce, come altri paesi, a salire sul treno dello sviluppo e si trova a cambiare pelle, a crescere nella scala economica delle democrazie industriali. In poco meno di dieci anni si accumulano record sui versanti della lotta alla disoccupazione, del potenziamento del sistema infrastrutturale, del consolidamento di posizioni di rilievo nel sistema degli scambi internazionali. Obiettivi e risultati conseguiti di getto, traendo vantaggio dai piani di sostegno allo sviluppo avviati dagli Stati Uniti per scongiurare il ripetersi, nell’Europa prostrata dalla guerra, delle crisi politiche ed economiche del primo dopoguerra.
Il meccanismo che rimette in moto l’industria nazionale si serve del legato dell’economia pubblica della stagione precedente e sa sfruttare, almeno inizialmente, l’offerta di lavoro, a costi contenuti, che l’Italia, ancora agricola, in prevalenza meridionale, può fornire. Il lavoro, come fattore trainante della crescita, diventa protagonista nella costruzione di un modello di relazioni industriali fondato sullo scambio tra occupazione e contenimento del salario più che sui benefici di un avanzato sistema di garanzie sociali. Ma anche la stabilità monetaria, i conti pubblici in ordine, la deregulation del commercio agiscono come indirizzi di politica economica decisivi nell’agevolare la sostenuta crescita degli investimenti e gli aumenti di produttività che consentono la corsa dell’economia, tra la metà degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta406. La ricerca del perché e del come fu possibile conseguire questi risultati è da molto al centro delle riflessioni di storici ed economisti che ne hanno analizzato i diversi elementi, puntando l’attenzione sull’incidenza degli investimenti e sull’andamento delle esportazioni.
Nella crescita ininterrotta dei primi è stato individuato il fattore determinante della nascita della «società industriale», affidata «all’estendersi del tessuto di piccole e medie imprese nelle regioni settentrionali, che assorbono le quote più consistenti di occupazione, per via delle loro tecnologie meno avanzate e del basso costo medio del lavoro»407. Questo motore di crescita, articolato nella spesa statale sostenuta, nell’investimento pubblico e nell’aumento delle esportazioni nette, ha provocato quell’aumento di salari e profitti alla base non solo dello «sviluppo del sistema di produzione fisico della ricchezza ma anche della formazione delle classi sociali fondamentali, con tutte le debolezze e le fragilità culturali e morali ch’esse in tal modo incorporano in sé»408, mentre si riesce ancora a sfruttare l’onda lunga della diffusione dei moduli tecnologici e organizzativi della fabbrica fordista. Si tratta soprattutto di un passaggio di sistema, perché, «in ogni caso, la condizione sine qua non del ‘miracolo’ è da identificare in quel passaggio del know how tipico del modo di produzione ‘fordista’ [...] dagli Usa alle economie di Europa e Giappone»409. Affermazione che la storiografia più recente fa propria, lasciando intravedere la trama di intricate connessioni che, a partire dalla fine degli anni Quaranta, regolano i rapporti tra le due sponde dell’Atlantico410. Indubbiamente, dopo l’arresto della fase di crescita, l’integrazione delle esportazioni italiane – in particolare per quanto riguarda il settore dei beni di investimento – nel sistema degli scambi internazionali risulta come un dato acquisito del sistema manifatturiero, capace di rimanere sostanzialmente inalterato anche nelle successive fasi critiche della congiuntura. Tra il 1962-1963 e il 1967-1968 la vendita dei prodotti dell’industria meccanica aumenta del 53,1% grazie soprattutto al lungo trend di investimenti in spese militari sostenute dall’economia Usa411. Ed è altrettanto vero che la performance dell’Italia industriale, trainata dal volano del settore industrialmente più avanzato (meccanica, chimica) e favorita da una stabilizzazione delle relazioni industriali, nasconde limiti e contraddizioni che attendono di essere risolti. Essi ineriscono, almeno in parte, alla natura stessa della grande trasformazione sociale e culturale in atto e costituiscono l’altra faccia del «miracolo», di fronte a quella esibita e celebrata, costituita dal benessere scaturito dalla disgregazione di una società ancora largamente agraria che, chiusa nei soffocanti orizzonti piccolo borghesi, aveva dato l’impronta al proprio stile di vita e al comune sentire del paese, già negli anni dell’industrialbellicismo fascista.
La stagione del dopoguerra volge al termine e i nodi di una rapida, quanto disordinata, modernizzazione giungono al pettine. Prende pertanto corpo l’esigenza di affrontare e risolvere la contraddizione tra la scelta dell’equilibrio dei bassi consumi, fondata su contenuti livelli salariali e mano libera padronale, e la richiesta di migliori condizioni di lavoro in fabbrica, poco compatibile con gli alti indici di produttività e con l’elevata competitività delle nostre esportazioni. Tutto questa comincia a maturare all’interno del movimento sindacale, ma viene adottato anche da forze politiche quali il Partito socialista e il Partito repubblicano, con sponde non marginali nella sinistra democristiana. Incalza così il tentativo di imprimere una correzione di rotta al governo dell’economia, inscrivendo il processo di crescita in un sistema di coerenze e priorità capaci di selezionarne gli obiettivi mediante il controllo della dinamica dei redditi. Prende da qui avvio un’intensa fase di dibattiti e di tormentati confronti sull’Italia da riformare. Si fa balenare, agli occhi dell’opinione pubblica, l’immagine di un paese che può ovviare alle distorsioni geografiche ed economiche, salvaguardando l’ambiente e ripartendo in maniera più equa i carichi fiscali. Un insieme di idee e di «programmi» che costituiscono un inventario delle occasioni perdute dalla politica negli anni Sessanta, oltre che un lascito su cui sarebbe opportuno soffermarsi per le aspettative, reali o immaginarie, che accendono negli attori economici del tempo412. Le abitazioni insufficienti, gli ospedali e le scuole fatiscenti, perfino gli interventi per equilibrare la distribuzione del reddito, entrano nella retorica della politica, diventano il tema centrale di documenti di programmazione, suscitano l’attenzione e le speranze di tecnici, economisti, urbanisti che si muovono intorno al Partito socialista o repubblicano, finendo per rivelarsi un boomerang in un confronto ideologico che non coinvolge solo le teste d’uovo dei vari comitati per la programmazione ma, più concretamente, gli industriali della Brianza, i palazzinari romani, le corporazioni dell’apparato pubblico che si sentono minacciate dall’ascesa di una nuova burocrazia. Il tentativo fallisce anche per l’incapacità, come ammette Ugo La Malfa, di «aver lasciato cadere l’appello alle forze sociali per la programmazione in un momento nel quale tutti i problemi che oggi travagliano il nostro paese potevano essere affrontati in condizioni certo migliori di quelle degli ultimi anni»413. Questo risultato penalizzerà profondamente la possibilità stessa di governare l’imminente futuro dell’Italia.
Il «percorso di quelle riforme su cui sembrava esservi sostanziale accordo – scrive Guido Crainz, riprendendo giudizi di Piero Craveri, Pietro Scoppola, Silvio Lanaro – è una storia di discussioni defatiganti e astratte, di continui intralci, dirottamenti insabbiamenti e rinvii»414, ma significa anche l’emergere, al momento non percepito, di strette e insospettabili connessioni tra il piano di sviluppo da costruire, astratto e geometrico degli economisti, e quello, impervio e frammentato, della politica praticata.
La crisi economica del 1964 scandisce la fine dell’era dei primati e non solo richiamando alla realtà i protagonisti della politica e dell’economia, immersi nei sogni di un mitico riformismo. Essa porta in primo piano le forti resistenze a modernizzare radicalmente il tessuto dell’economia italiana. La sua evoluzione non guadagna la dovuta attenzione da parte degli storici economici. L’evento rimane incardinato nelle cronache della congiuntura e non trova un narratore capace di comporre in una trama più analitica e complessa le tessere del racconto dei testimoni del tempo, rappresen...
Indice dei contenuti
- Introduzione
- I. Tra crisi vecchie e crisi nuove
- II. Nella grande depressione
- III. L’altro volto dello sviluppo: la crisi degli anni Settanta
- Epilogo