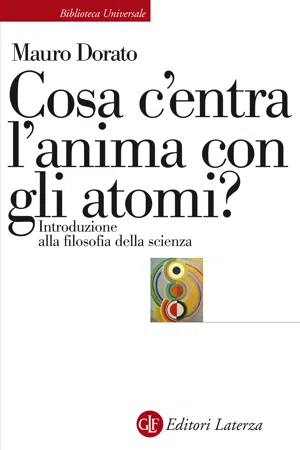
eBook - ePub
Cosa c'entra l'anima con gli atomi?
Introduzione alla filosofia della scienza
- 272 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
La scienza può spiegare tutto? Qual è il rapporto tra ipotesi e osservazioni? Che differenza c'è tra una teoria scientifica e una filosofica? Se le teorie scientifiche mutano nel tempo, come possiamo definirle vere? In questa introduzione alla filosofia della scienza si mettono in evidenza con chiarezza e sistematicità gli snodi concettuali e i punti di contatto tra scienza e filosofia, due modalità inseparabili di interpretazione del mondo.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Cosa c'entra l'anima con gli atomi? di Mauro Dorato in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Philosophy e Logic in Philosophy. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
PhilosophyCategoria
Logic in PhilosophyCapitolo quarto.
A chi e a che cosa dobbiamo credere?
Ipotesi scientifiche ed evidenze osservative
4.1. Il disaccordo degli esperti e il moltiplicarsi delle conoscenze
In una società nella quale le conoscenze scientifiche e tecnologiche si moltiplicano senza sosta, formare in modo autonomo la nostra opinione, e quindi decidere autonomamente in casi pratici concreti, può diventare un compito quasi impossibile. D’altra parte, appoggiarsi ai cosiddetti «esperti» può risultare altrettanto frustrante, soprattutto se questi ultimi sono in disaccordo fra di loro e sono talvolta asserviti a interessi di parte.
Forse per questi motivi, il filosofo della scienza Paul Feyerabend (1924-1994) invitava spesso a diffidare degli esperti, perché sono «pieni di pregiudizi, non ci si può fidare di loro, e i loro consigli devono essere valutati in modo approfondito» (Feyerabend 1980, cap. 5, parte 2). Così scrivendo, si riferiva anche agli scienziati, sostenendo che la scienza dei nostri giorni rischiava di diventare una nuova fede intollerante, incapace di ascoltare e trarre ispirazione da teorie minoritarie, «eretiche» o alternative. E a sostegno della sua tesi, da buon conoscitore della filosofia scettica antica, portava il vecchio argomento delle «opinioni contrarie»: non di rado, diceva, si trovano scienziati o esperti che discutono in modo acceso, senza trovare alcun accordo, sull’utilità di una certa procedura sperimentale, di un intervento chirurgico, sulla nocività di una sostanza o di un’applicazione tecnologica. Si noti tuttavia che qui è Feyerabend a essere in contraddizione con se stesso: se gli scienziati sono spesso in disaccordo fra loro, ma la scienza è oggetto di una nuova fede officiata da sacerdoti intolleranti, come spiegare il proliferare di disaccordo nella scienza? Nell’attaccare le tesi che difendevano l’esistenza di un unico metodo scientifico, Feyerabend sosteneva, in modo certamente provocatorio, che non esiste un criterio o un metodo per stabilire quale sia la «retta opinione» scientifica su un qualsiasi argomento: qualunque criterio va bene, anzi, «tutto va bene» (anything goes).
Il punto su cui più spesso batteva il filosofo viennese nell’opera sopra citata era la medicina: il suo intento era cercare di difendere le medicine cosiddette «alternative» da facili e aprioristiche condanne. La medicina ufficiale, affermava Feyerabend, avrebbe molto da apprendere se cercasse di studiare con più umiltà le tecniche terapeutiche «eretiche»: fino a che punto questo consiglio di Feyerabend deve essere accolto?
Un solo esempio sarà sufficiente per rendersi conto che il problema sollevato da Feyerabend non ha a che fare solo con dibattiti tecnici, affrontati in ambito specialistico da un ristretto numero di metodologi e filosofi della scienza, ma coinvolge questioni pratiche di interesse generale. In Italia ben 11 milioni di persone ricorrono oggi a cure omeopatiche («la Repubblica», 16 febbraio 2006), e ciò fa aumentare di molto la spesa pro capite per i prodotti omeopatici. Tali forme di terapia, che sono in costante aumento anche in pediatria e dunque tra i bambini, sono osteggiate da parte della medicina ufficiale, e i governi si trovano spesso a dover decidere se pagare con il denaro pubblico farmaci la cui efficacia terapeutica si basa su un principio in apparenza assai bizzarro: malattie come raffreddori, cefalee, allergie ecc., si dovrebbero curare con sostanze che nella persona sana provocano gli stessi sintomi che ha il malato. L’omeopatia si basa infatti essenzialmente sul principio che cose simili si curano con rimedi simili, ovvero similia similibus curentur.
Per rispondere alla domanda con la quale abbiamo intitolato il capitolo, partiremo allora proprio discutendo l’esempio dell’omeopatia, anche in considerazione delle controversie che suscita proprio da un punto di vista metodologico. Oltre a essere molto diffusa, l’omeopatia offre il vantaggio che i suoi principi generali possono essere introdotti senza richiedere conoscenze tecniche particolarmente sofisticate. Essa può quindi fornirci una serie di spunti interessanti per discutere la questione centrale che affronteremo in questo capitolo: in che modo dovremmo formare ipotesi a partire da evidenze sperimentali e osservative? Si noti da subito l’aspetto normativo o prescrittivo che il «dovremmo» di cui sopra implica1, aspetto che sarà meglio compreso a patto che si rifletta su come invece tendiamo di fatto a formare le nostre ipotesi.
4.2. L’ABC dell’omeopatia: lo studio di un caso
Cominciamo con il considerare che l’inventore della tecnica omeopatica, Samuel Hahnemann (1755-1843), visse due secoli fa, in un periodo in cui la medicina del tempo prescriveva rimedi che erano spesso peggiori del male che dovevano curare (si pensi ai clisteri, ai salassi o alle purghe di cui racconta Collodi nel suo Pinocchio). Anche supponendo che l’omeopatia non abbia alcun effetto benefico – cosa che in questo capitolo dovremo discutere –, il fatto che essa almeno non faccia danni può già qualificarsi come un progresso, soprattutto se pensiamo al tempo in cui venne inventata. Dopotutto, il primo dovere del medico è non nuocere.
Il sopra menzionato primo principio dell’omeopatia («il simile si cura con il simile») può essere illustrato con un semplice esempio: una persona che soffra di raffreddore dovrebbe assumere della cipolla, in dosi minime specificate dalle tecniche di preparazione farmacologica omeopatica. E questo perché, sulla persona sana, la cipolla in dosi massicce provoca gli stessi effetti del raffreddore nel malato, ovvero fa piangere e crea muco nelle narici. Analogamente, un’assunzione in dosi minime e ben specificate di caffeina può curare l’insonnia, perché la caffeina in dosi massicce ha l’effetto di «svegliare» le persone sane: il principio del curare le cose simili con sostanze che inducono effetti simili è rivelato dall’etimo della parola omeopatia, che deriva dal greco «simile» (omoios) e «malattia» (pathos). Nella tradizione omeopatica, la medicina tradizionale curerebbe invece con il principio opposto, attribuito a Ippocrate, in base al quale i contrari sono curati dai contrari (contraria contrariis curentur).
Assai schematicamente, gli altri due principi su cui si basa l’omeopatia sono la cosiddetta legge degli infinitesimi e una concezione olistica della malattia. La legge degli infinitesimi si rifà all’idea originaria di Hahnemann, assai controintuitiva per chiunque ricorra ai farmaci di tipo tradizionale: più piccola è la dose assunta – ovvero maggiore la diluizione del principio attivo in acqua – e maggiore è l’effetto terapeutico della sostanza. Questo principio presuppone che il corpo abbia, nel suo complesso, un’innata capacità di ristabilire autonomamente la propria salute, una capacità che la dose omeopatica del farmaco, stabilita anche sulla base di uno studio «psicologico» sul paziente, è in grado di stimolare. Il principio della diluizione può spiegare in parte la diffusione dei farmaci omeopatici anche ai nostri giorni: se la diluizione dovesse far sparire il principio attivo, tali farmaci almeno non avrebbero effetti negativi o controindicazioni, presenti invece – come è noto – in molte medicine tradizionali. E in effetti scopriamo che il 70% dei pazienti che oggi si curano con l’omeopatia afferma che la propria scelta deriva dall’elevato grado di tossicità dei farmaci tradizionali2.
Il terzo principio, quello «olistico», è certamente apprezzabile: il fatto che l’omeopata tratti il paziente non come una macchina costituita da tanti pezzi che si possono rompere e aggiustare separatamente, ma «olisticamente», ovvero come un tutto, e quindi come un organismo caratterizzato anche da tratti psicologici e fisiologici diversi da individuo a individuo, rende l’omeopatia più «umana» rispetto ad alcune pratiche della medicina ufficiale. Nell’omeopatia esistono classificazioni di pazienti con nomi divertenti, che ricordano assai da vicino la vecchia teoria galenica degli umori3: la «Pulsatilla» è una giovane donna gentile, bisognosa d’affetto e un po’ timida, il tipo «Nux Vomica» è aggressivo, ambizioso e iperattivo, mentre il «Sepia» è ostile e acido. Poiché i trattamenti vanno riferiti a questo tipo di classificazione psicologica, l’omeopatia difende l’indissolubilità della mente e della personalità del paziente dal suo corpo ed è in questo senso che l’omeopatia è «olistica». Ogni sintomo dipende da tutto il resto e lo stato d’animo del paziente ha un ruolo decisivo nella diagnosi4:
In ogni stato di malattia lo stato d’animo del paziente costituisce uno dei sintomi più importanti, che va sempre rilevato per poter fare il quadro fedele del male e conseguentemente poterlo guarire con la cura omeopatica. Tal cosa è tanto importante nella scelta del medicamento, che spesso lo stato d’animo del paziente è decisivo, perché rappresenta un sintomo preciso e caratteristico e che meno di qualsiasi altro può sfuggire all’osservazione del medico attento (Hahnemann 2006, p. 123, paragrafi 210 e 211).
Dopo questa schematica introduzione, possiamo formulare la domanda che ci interessa: è giusto chiedere, come fa la recente normativa europea, che tutti i farmaci omeopatici, per poter essere messi in commercio, vengano sottoposti allo stesso tipo di test sperimentali cui sono soggetti i rimedi tradizionali o «allopatici»? Molti medici omeopati sostengono che i loro farmaci presuppongono modalità di cura completamente diverse, incompatibili o incommensurabili con la medicina tradizionale5. E lo stesso atteggiamento ostile nei confronti dei test statistici si registra tra i sostenitori di altre terapie alternative, quali l’agopuntura, la chiroterapia e la fitoterapia.
È legittimo che i sostenitori dell’omeopatia riparino sulla difensiva in questo modo? Nel resto del capitolo noi argomenteremo che la risposta è negativa: se i farmaci omeopatici non fossero sottoponibili a test statistici comparabili con quelli della medicina tradizionale, la loro somministrazione sarebbe ingiustificabile, e lo Stato non dovrebbe rimborsare il loro acquisto. Per motivare questa tesi, introdurremo alcune considerazioni sul modo in cui dovremmo sottoporre a prova un’ipotesi scientifica in generale, per poi contestualizzare il nostro discorso alla medicina e alla farmacologia. Per onestà nei confronti dei sostenitori del metodo omeopatico, n...
Indice dei contenuti
- Ringraziamenti
- Capitolo primo. Scienza e filosofia della scienza
- Capitolo secondo. Tre luoghi comuni sulla spiegazione scientifica
- Capitolo terzo. Perché le cose sono come sono?*Modelli di spiegazione a confronto
- Capitolo quarto. A chi e a che cosa dobbiamo credere? Ipotesi scientifiche ed evidenze osservative
- Capitolo quinto. Che cos’è una teoria scientifica?
- Capitolo sesto. Il mutamento delle teorie e il realismo sulle entità
- Capitolo settimo. Scienza e verità
- Capitolo ottavo. Scienza e natura umana
- Bibliografia