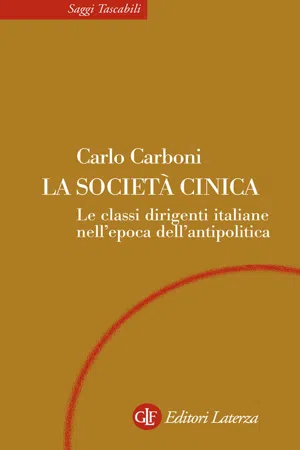
eBook - ePub
La società cinica
Le classi dirigenti italiane nell'epoca dell'antipolitica
- 168 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
La nostra società è cinica come la sua élite. È necessario aprire gli occhi sulle reali condizioni del paese, sull'Italia dell'antipolitica, l'Italia che concepisce lo spazio pubblico in funzione di un vantaggio personale, in cerca di scorciatoie, quella delle protezioni clientelari e che non rispetta le regole, qualunquista e indolente. Pezzi di nazione deserti di merito, che condividono i vizi e le carenze di chi la dirige. D'altro canto c'è anche un paese diverso, che preme per il cambiamento: lì è il vero motore, il centro da cui si può irradiare una concreta riforma del sistema.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a La società cinica di Carlo Carboni in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Economia e Politica economica. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
EconomiaCategoria
Politica economica1. Classi dirigenti e antipolitica: declino della società di massa e cittadinanza competente
Abbiamo vissuto e abbiamo visto. L’immaginazione è rimasta fuori della porta del potere.
Dentro alle vecchie stanze del palazzo, nulla di più immaginifico, e di più terra terra,
che il dilagare della corruzione politica. Nonostante tutto, le strutture della nostra sempre fragile democrazia,
che sono riuscite a sopravvivere al terrorismo, alle mene dei servizi segreti deviati,
e ai colpi mortali delle varie mafie che infestano alcune regioni del nostro paese, non sono crollate.
E non paiono neppure pericolanti.
Norberto Bobbio, Saggi sulla scienza politica in Italia, Laterza, Roma-Bari 1996, p. x
È possibile generare classe dirigente?
In questi anni, prima le ipotesi di declino economico e poi la critica alla «casta politica» hanno spostato l’attenzione dell’opinione pubblica sulle nostre classi dirigenti. Si è molto parlato del loro profilo mediocre, invecchiato, maschile, autoreferenziale, centrosettentrionale, provinciale, a basso ricambio, vocato ai meccanismi di consenso più che a valorizzare le competenze1. Insomma, più che una classe dirigente, un insieme di élites bloccate nel segreto delle loro debolezze, disponibili a non decidere pur di durare. Il panorama non proprio incoraggiante che esce dalle nostre ricerche sulle classi dirigenti è stato utile ad accelerare riflessioni e proposte per migliorare lo stato delle cose nelle stanze dei bottoni, nella consapevolezza che tale miglioramento potrebbe stimolare, forse, quel tanto di propensione in più all’innovazione e al riformismo dei quali c’è bisogno nel paese. Esperti e opinion maker sono passati quindi a chiedersi se e come sia possibile colmare quella distanza tra classi dirigenti e società e, in particolare, quel vuoto pneumatico tra classe politico-istituzionale e cittadini che alimenta antipolitica e populismo.
Come innovare e migliorare le nostre classi dirigenti? Sembra ci sia un generale accordo che non si tratta di sostituire alcuni personaggi con altri, poiché i sostituti, con ogni probabilità, si rivelerebbero cloni dei precedenti.
Gran parte del dibattito si è incanalato in una più feconda discussione sulla necessità di cambiare registro in tema di selezione e formazione per le nostre classi dirigenti2: troppa cooptazione e poco merito, troppi privilegi/protezioni e poca competizione, troppi ingressi laterali e poche competenze, troppe teaching universities e poche research universities, pochi grandi progetti-paese e troppi maestri privi di generosità e responsabilità sociale.
Un altro filone utile su cui il dibattito si è articolato ruota attorno al tema della fiducia e della reputazione delle nostre classi dirigenti, connesso ad aspetti di responsabilità sociale e di senso etico e legale. Un tema «bollente» che ha portato il nostro giornalismo quotidiano a concentrarsi sul nuovo fantasma che – dopo il declino – si aggira nel nostro paese: l’antipolitica. E anche a questo proposito appare urgente prendere decisioni sulla riforma istituzionale (efficienza e costi) che, come detto, rappresenta la porta stretta attraverso la quale devono transitare le nostre classi dirigenti.
Tuttavia, Ernesto Galli della Loggia ha giustamente rilevato che le classi dirigenti non possono essere generate in vitro, poiché sono un prodotto storico-sociale3. Con questo ci ha ricordato che è bene parlare di una riforma universitaria e della ricerca, di cultura e regole che generano merito e responsabilità, ma che il sapere codificato e le regole non sono sufficienti, occorrono progetti, incentivi e stimoli culturali che sono legati alla cultura sociale del tempo. La nostra classe dirigente del dopoguerra, con la ricostruzione del paese, riuscì a determinare una grande trasformazione dell’Italia, dimezzandone i ritardi rispetto agli altri principali paesi europei. Ma questi scarti, seppur ridotti, sono rimasti inalterati durante gli anni Ottanta e Novanta e, soprattutto, sono tornati a crescere proprio negli anni più recenti.
In tema di classi dirigenti e società, ripartirei dall’affermazione di Bertrand Russell che le classi dirigenti sono uno specchio della società (del tempo). E, quindi, ogni paese ha le classi dirigenti che merita (e anche le classi dirigenti hanno la società che si meritano). Ma a questa verità ne aggiungerei un’altra. È vero che tutti siamo sulla stessa barca, ma la classe dirigente non soffre i disagi di chi vive e lavora nella stiva: in cambio di questo privilegio, deve dimostrare di saper tracciare una rotta e stare al timone della nave. Ha la responsabilità di governarla e guidarla. E di dare l’esempio.
Mi occuperei di questo filone del rapporto tra classi dirigenti e società, intuitivamente importante se l’intento è colmare il vuoto pneumatico tra le prime e il paese reale. Come accade spesso, il percepito (il sentiment dell’informazione mediatizzata) probabilmente ci offre un’immagine più negativa di come stanno effettivamente le cose. Le classi dirigenti e la società italiana, in realtà, hanno tra loro lo stesso rapporto che c’è tra due persone che si assomigliano, ma non lo ammettono. Esattamente allo stesso modo di buona parte dei leader e dei dirigenti da noi intervistati, i quali hanno negato di essere simili al resto della classe dirigente4. Le responsabilità, insomma, sono sempre di qualcun altro. Ciò sembra indicare, se non una fuga di appartenenza, una bassa responsabilità di ruolo da parte degli stessi componenti le élites: un vero deficit di responsabilità sociale e perciò di leadership. E, senza per ora soffermarci, sappiamo che nella società le cose non vanno troppo diversamente.
Gli alti circoli del potere
Prima di qualche osservazione interpretativa in proposito, schematizzerei uno scenario socio-politico di riferimento. Nel nostro caso, lo scenario è «contagiato» dalle ultime nostre ricerche sulle classi dirigenti5. L’immagine è, in un certo senso, capovolta: è infatti una vista dall’alto della società. Un approccio che fu molto coltivato da Charles Wright Mills.
Immaginerei questo scenario rappresentandolo mediante cerchi concentrici, a partire da quelli più piccoli e centrali dei circoli ristretti delle élites fino a quello più ampio della «società di massa».
Nel primo cerchio, il più piccolo, ci sono all’incirca 2.000 «numeri uno», leader in ambito di grandi istituzioni, enti, associazioni economiche, politiche, culturali, professionali. I protagonisti più vocati alla leadership (notorietà e carisma) sono gli imprenditori, gli opinion maker, gli ecclesiastici, i parlamentari europei e nazionali. La loro immagine è ultramediatizzata.
Il primo cerchio è compreso in un secondo più ampio, composto da circa 6.000 protagonisti eccellenti, la forza dei quali consiste nel disporre di risorse organizzative di vertice. Se il primo cerchio è dei «leoni», il secondo è delle «volpi», ai vertici dei principali apparati fiduciari del paese. Questo è il cerchio delle élites potenzialmente traenti, dalle quali dipendono le decisioni, compresa quindi la scelta di «fare classe dirigente», esercitare cioè una guida dell’intero paese anche sul piano morale. È il cerchio decisivo dove si creano o si rompono equilibri trasversali tra le élites, dove si stringono o si sciolgono accordi e patti di vertice.
Un terzo cerchio concentrico, secondo le nostre ricerche, è composto di 17.000 unità. Esso comprende élites di policy e di territorio (le élites funzionali di cui parla Giuliano Amato) che, a differenza delle precedenti, sono portatrici di visioni, risorse, competenze parziali, settoriali e spesso corporative. C’è la classe dirigente pubblica, politico-amministrativa in prevalenza, ma anche tutta l’articolazione territoriale del nostro potere, come effetto del localismo. Questo cerchio allargato è anche «allargabile», nel senso che abbassando la soglia dei nostri criteri selettivi, si potrebbero contare anche oltre 50.000 individui.
Un quarto cerchio concentrico annovera circa 2 milioni e mezzo di persone e – eventualmente – i loro familiari. Si tratta della classe borghese, forse dell’unica classe sopravvissuta al vecchio ordine sociale classista e industriale. Essa oggi vale in quantità, perché di per sé mobilita 5-6 milioni di italiani e beneficia del 40% della ricchezza nazionale. Si è perciò notevolmente e sorprendentemente ampliata negli ultimi venticinque anni. Alle tradizionali posizioni borghesi, si sono aggiunti almeno un milione di professionisti e anche l’aumento delle professioni intellettuali. Ma si tratta di una classe, anch’essa, sempre più spesso lacerata da forti conflitti di interessi, e perciò composta di tante debolezze (capitalismo senza capitali in un paese privo di reali egemonie).
La cittadinanza competente e il declino della società di massa
Nel quinto cerchio c’è un’area sempre più decisiva per le sorti socio-politiche del paese (cioè quelle che oggi preoccupano maggiormente l’opinione pubblica). Metterei in questo cerchio la cittadinanza competente, come potenziale serbatoio per il ricambio della classe dirigente. Si tratta di circa 15 milioni di cittadini che hanno livelli superiori di istruzione, si informano su quotidiani e tv, leggono libri, frequentano, in alcuni casi, il volontariato e, soprattutto, si interessano di politica anche quando non ci sono le elezioni (nell’altro caso, raddoppiano). Composta in maggioranza da ceto medio intellettuale e autonomo, la cittadinanza competente è una sorta di classe media di cittadinanza. È la parte più moderna della società, quella che sta più in fretta assimilando il nuovo che avanza nel pluralismo valoriale. La cittadinanza competente costituisce il maggior aggregato di valori espressivi connessi alla crescita di autonomia di scelta dell’individuo. Essa chiede maggior partecipazione e una riforma del sistema politico-istituzionale (meno sprechi e irrazionalità, più sobrietà e rigore). È il cerchio sociale più sensibile a considerare la democrazia non solo nella sua veste rappresentativa di interessi socio-economici, ma soprattutto nella sua dimensione di razionalità e professionalità. La cittadinanza competente è la più incline a comprendere i temi della governabilità e quelli stringenti del riformatore. È un settore decisivo ai fini della condivisione di una svolta che riguardi innanzitutto l’autoriforma del sistema politico e istituzionale. Se occorre cominciare a riempire quel vuoto civico, è questa innanzitutto la platea a cui, soprattutto la classe politica, dovrebbe rivolgersi. Vedremo meglio più avanti come e perché.
Nel sesto cerchio concentrico, metterei la maggioranza dei cittadini, una rete di relazioni ancora orfana della vecchia società di massa industriale, sebbene percorsa da nuovi valori e nuove aggregazioni. Vi gravita tutto il resto della società italiana. Sorvoliamo per ora (cfr. infra, cap. 3) sulla nuova instabile morfologia di questa maggioranza, di questa area di lealtà passiva che, in larga parte, rappresenta il conservatorismo di destra e di sinistra. È la maggioranza sociale, anch’essa bloccata da una bassa mobilità fino a richiedere un’alta flessibilità, è invecchiata, localistica, spesso corporativa. Lo specchio della maggioranza delle nostre classi dirigenti. Al pari loro, è orfana della rottura dei tre grandi patti che avevano segnato la crescita dell’economia e della società del nostro paese: tra politica ed economia, tra sistema politico e apparati pubblici e, infine, il patto consociativo6. Sempre più plurale, la sua stratificazione sociale è complessa, con aree di accentuato ritardo socio-culturale. È il cerchio che trova maggior coincidenza con l’area del dis...
Indice dei contenuti
- Introduzione. La porta stretta
- 1. Classi dirigenti e antipolitica: declino della società di massa e cittadinanza competente
- 2. Le classi dirigenti nella società della conoscenza: valori e capitale umano
- 3. La società: civica o cinica?
- 4. Le classi dirigenti: problematiche in pillole
- Epilogo. Ci meritiamo L’Italia?