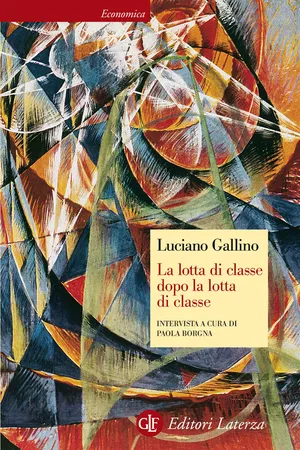1. Esistono ancora le classi sociali?
D. Top manager e leader politici, anche da sinistra, sono di recente tornati ripetutamente sull’idea che parlare degli operai, ovvero dei lavoratori dipendenti in genere, come se fossero una classe sociale sia un ritornello frusto e che la lotta di classe sia un residuo arcaico della rivoluzione industriale. Occorre dunque ragionare sulla società italiana e sulla società globale in termini del tutto nuovi, prendendo atto del fatto che le classi sociali, con riferimento alle quali sono state descritte e analizzate le società sin dalla metà dell’Ottocento, non esistono più?
R. Bisogna cominciare con una distinzione. Chi afferma che le classi sociali non esistono più muove in genere dalla constatazione che non si vedono più manifestazioni di massa che siano chiaramente attribuibili ad una data classe. Oppure intende dire che non vi sono più partiti di un certo peso elettorale che per il loro statuto o programma si rifanno chiaramente all’idea di classe sociale. In questi casi si può convenire che negli ultimi decenni le classi sociali, e con esse la lotta di classe, sono diventate assai meno visibili. Il che pare dar ragione a chi arriva a concludere che, non essendo le classi visibili e la lotta di classe chiaramente discernibile, non esistono più le classi. Però una classe sociale, come disse qualcuno tempo fa, distinguendo tra la classe in sé e la classe per sé, non è delimitata o costituita soltanto dal fatto di dar forma ad azioni collettive in quanto espressioni di un conflitto, o da una forte presenza pubblica di partiti che fanno delle classi e magari della lotta di classe la loro bandiera. Una classe sociale esiste indipendentemente dalle formazioni politiche che ne riconoscono o meno l’esistenza, e perfino da ciò che i suoi componenti pensano o credono di essa.
Ricorrendo ad un’espressione che risale anch’essa a parecchio tempo addietro, far parte di una classe sociale significa appartenere, volenti o nolenti, ad una comunità di destino, e subire tutte le conseguenze di tale appartenenza. Significa avere maggiori o minori possibilità di passare, nella piramide sociale, da una classe più bassa ad una classe più alta; avere maggiori o minori possibilità di fruire di una quantità di risorse, di beni materiali e immateriali, sufficienti a rendere la vita più gradevole e magari più lunga; disporre oppure no, in qualche modo, del potere di decidere il proprio destino, di poterlo scegliere. Per definire una classe, insomma, è necessario ma non basta dire che è una comunità di destino: rientra nella definizione anche la possibilità per chi vi appartiene di poter influire sul destino stesso, di poterlo in qualche misura cambiare.
Ci sono poi altri motivi che inducono molti, da tempo, ad affermare che le classi sociali non esistono più. Uno di essi è la relativa omogenizzazione dei consumi e dello stile di vita della classe operaia, o classe lavoratrice, e delle classi medie. Le famiglie degli operai e dei muratori, dei magazzinieri e dei conducenti di autobus hanno in molti casi l’automobile, la tv a schermo piatto, il telefono cellulare, la lavatrice, vivono in un alloggio di proprietà, mandano i figli a scuola almeno sino alla fine delle superiori e fanno le vacanze al mare: proprio come le famiglie dei dirigenti d’azienda, dei professionisti, dei funzionari della pubblica amministrazione, dei commercianti, dei piccoli imprenditori che formano la classe media ovvero la piccola e media borghesia, come si chiamava una volta. Qui occorre naturalmente precisare: un conto è lo stile di vita o il consumo di massa visivamente osservabile; altra cosa è la qualità del lavoro che un individuo svolge, la possibilità di crescita professionale, la probabilità di salire nella scala sociale, il fatto di avere o non avere qualcuno sulla testa che dice ad ogni momento che cosa devi fare. In questa prospettiva le differenze di classe rimangono cospicue, anche se a causa della Grande Crisi esplosa nel 2007, e diventata una Grande Recessione che durerà forse molti anni, una parte della classe media ha subìto una sorta di processo di proletarizzazione.
Un altro motivo per affermare che le classi sociali non esistono, che risale ancor più lontano nel tempo, ma che anche oggi si sente riproporre da politici di destra non meno che di centro-sinistra, è grezzamente ideologico. Esso suona così: operai, dirigenti e proprietari hanno tutti interesse a che un’impresa funzioni bene e faccia buoni utili. Sono, si dice, nella stessa barca. Asserire che hanno interessi diversi e quindi appartengono a classi obiettivamente contrapposte è un’idea priva di senso, si sostiene, e anzi dannosa per tutte le parti in causa. Perciò operai e sindacati devono essere “complici” dei manager e dei proprietari: è arrivato a dirlo nientemeno che un ministro del Lavoro italiano, Maurizio Sacconi, rompendo una tradizione che ha visto succedersi in tale carica politici dediti a trovare i modi per regolare il conflitto strutturale tra le due parti, non a camuffarlo. Quasi due secoli e mezzo fa, Adam Smith aveva spiegato perfettamente perché l’idea che operai e padroni possano o debbano essere “complici” non sta in piedi: gli operai, per la posizione che occupano, vorrebbero sempre ottenere salari più alti; i padroni, per i mezzi di produzione che controllano, vorrebbero pagare sempre salari più bassi.
D. Classe operaia, classe lavoratrice, classe media. Ma come si fa a stabilire che certi gruppi o strati sociali appartengono all’una o all’altra classe? Alla fine, anche un artigiano può dire giustamente di essere un lavoratore. E un dirigente che guadagna cinque o dieci volte più di un operaio è pur sempre un dipendente che può essere licenziato.
R. “Classe operaia” e “classe lavoratrice” sono sinonimi, come si ricava anche dall’uso che ne viene fatto in diverse lingue sin dai primi decenni dell’Ottocento. In inglese si è sempre parlato di working class, ponendo così in primo piano il processo generico di lavoro, mentre tedeschi, francesi e spagnoli hanno sempre parlato di Arbeiterklasse, classe ouvrière e clase obrera, espressioni che richiamano piuttosto le persone che svolgono un particolare tipo di lavoro. Quest’ultimo si distingue da ogni altro perché presenta in modo congiunto e inscindibile due caratteri: richiede un’attività fisica ovvero corporea, in prevalenza manuale, oltre che intellettuale, e si svolge alle dipendenze di altri perché il soggetto non possiede i mezzi per lavorare in proprio. Con il progresso tecnologico è accaduto che in molti lavori la componente fisica si sia ridotta a paragone di quella intellettuale, ma è tuttora presente anche là dove si usano le tecnologie più avanzate. Stare davanti a un computer per otto ore al giorno, per dire, eseguendo operazioni predeterminate della durata media di un minuto, come avviene in un call center, comporta un notevole impegno corporeo oltre che intellettuale.
Ora, se si accoglie l’idea che la classe operaia o lavoratrice è formata da coloro che sul lavoro debbono impegnare sia il corpo che la mente, e lo prestano in quanto dipendenti da un datore di lavoro, si possono individuare anche i caratteri di altri raggruppamenti che sono invece riconducibili alla classe media. Gli artigiani, ad esempio, svolgono un lavoro con una importante dose di manualità, ma non sono alle dipendenze di nessuno. Per contro gli insegnanti, i funzionari pubblici, gli impiegati amministrativi di un’impresa lavorano come dipendenti, ma la componente della manualità è irrilevante. Gli uni e gli altri possono essere quindi considerati come parte della classe media. È ovvio che esistono vari altri raggruppamenti così caratterizzabili, e senza dubbio il confine tra classe operaia-lavoratrice e classe media è talora sfumato. Nondimeno mi pare che con queste definizioni si possa stabilire con chiarezza sufficiente chi appartiene all’una o all’altra.
Volendo complicare un poco la definizione, si potrebbe aggiungere che la classe operaia o lavoratrice è costituita dagli individui che con la loro forza lavoro, erogata alle dipendenze di qualcuno, assicurano la produzione delle merci e del capitale, mentre rientrano nella classe media coloro che assicurano la circolazione delle une (ad esempio con il trasporto e il commercio) e dell’altro (ad esempio con il credito). Un tempo quest’ultima era chiamata piccola e media borghesia, per distinguerla dall’alta borghesia formata da imprenditori, redditieri (i proprietari di grandi patrimoni), proprietari terrieri e immobiliari, alti dirigenti delle imprese e della pubblica amministrazione.
D. Max Weber, il maggior studioso del Novecento circa i rapporti tra economia e società, utilizzò il termine destino per riferirsi alla differenziazione delle possibilità di vita determinata dalla possibilità di utilizzazione di beni o del lavoro sul mercato. “Un elemento costantemente presente nel concetto di classe è rappresentato dal fatto che la qualità delle possibilità offerte sul mercato rappresenta la condizione comune del destino di tutti gli individui”, egli scrisse in un testo pubblicato postumo nel 1922. È questo il significato del termine destino a cui ti riferisci?
R. Direi di sì. Destino non è un termine astratto. Significa avere o no un buon livello di istruzione e poterlo trasmettere; poter scegliere o no dove e come abitare; vivere in salute più o meno a lungo; fare un lavoro gradito, professionalmente interessante oppure no; avere o non avere preoccupazioni economiche; dover temere oppure no che il più modesto incidente della vita quotidiana metta in serie difficoltà sé o la propria famiglia. Da questo punto di vista, le classi sono delle realtà concrete oggi come sempre lo sono state nella storia. Più che mai da quando esiste l’industrializzazione, che fa dipendere il destino individuale dalla possibilità o dalla impossibilità di essere indipendenti sul lavoro.
Quello che caratterizza l’epoca contemporanea è che, da un lato, per ogni individuo appartenere a una comunità di destino risulta – se ne renda conto o meno – come una sorta di determinazione ineludibile, ferrea, e quindi siamo dinanzi ad un processo che vede ancor sempre, almeno dal punto di vista della posizione occupata nella società, le classi sociali come comunità di destino aventi una loro perentoria esistenza. Dall’altro lato manca invece, anche in prospettiva, lo sviluppo, la formazione di una o più classi che, oltre ad essere oggettivamente determinate, siano anche in grado di agire come soggetto per modificare in qualche misura il loro stesso destino. Nei termini della distinzione di origine marxiana richiamata poco sopra, manca cioè il passaggio dalla classe in sé alla classe per sé, intendendo con questo il passaggio della classe dallo stato di mera categoria oggettiva allo stato di soggetto consapevole e quindi capace di intraprendere un’azione politica unitaria.
D. In questa prospettiva, l’espressione lotta di classe cosa significa?
R. Significa due cose a un tempo. Per chi non è soddisfatto del proprio destino, delle vicende che la vita appare proporgli anche per un lontano futuro, significa mobilitarsi per tentare di migliorare, insieme con altri che si trovano nella medesima condizione, il proprio destino con diversi mezzi; o, quanto meno, per evitare che esso peggiori. Ma c’è anche l’altra situazione, quella di coloro che sono soddisfatti del proprio destino e vorrebbero difenderlo, o che in ogni caso vedono con apprensione la possibilità che venga compromesso. Questa situazione rinvia alla lotta di classe condotta da parte di coloro che già in passato hanno avuto in essa la meglio, qualificandosi in qualche modo come i suoi vincitori.
Bisogna ancora tenere presente che in ambedue i casi chi vuol difendere la propria posizione sociale – perché difendere il proprio destino significa appunto questo – o al contrario vuole migliorarla, non è detto che debba farlo unicamente scendendo in piazza, facendo risonanti discorsi pubblici, intervenendo a manifestazioni oppure organizzandole. La lotta di classe ha aspetti appariscenti ed altri che lo sono assai meno. La lotta di classe ha componenti economiche, riguardanti il reddito che si ottiene con il lavoro o con il capitale, la ricchezza di cui la propria famiglia dispone, ovvero la distribuzione dell’uno e dell’altra; in sostanza, componenti che toccano la possibilità di godere o meno di benefici materiali. E ovviamente ha componenti politiche, che hanno a che fare con la possibilità di riuscire a esercitare o meno un qualche potere nei luoghi dove si decidono le leggi, le norme che regolano la vita di una società e, in essa, di tutte le classi sociali.
Esiste anche una lotta culturale. Essa consiste, ad esempio, nel far risaltare i meriti della posizione sociale che si occupa e descrivere invece in modo negativo la posizione sociale di altri, in specie delle classi con cui una determinata classe si trova a competere, a lottare. Questa forma di lotta può consistere anche nel tentare di dimostrare che chi ha un destino ingrato – sul piano del lavoro, della salute, dell’educazione, della fruizione di aspetti significativi dell’esistenza, della mancanza di potere e di prospettive – in fondo lo deve unicamente a se stesso. Tale schema interpretativo fa parte da almeno duecento anni della lotta di classe, ma viene oggi utilizzato come forse mai in passato. Da un lato si descrive la propria posizione, quando essa è gratificante, come il risultato di un merito; dall’altro si descrive come il risultato di un demerito, se non di una colpa, la posizione di chi, invece, da quella sorta di gabbia di ferro in cui si trova in qualche modo racchiuso trae risorse scarse, mancanza di potere e una vita un po’ più breve, povera e crudele.
D. Ammesso che oggi esista qualcosa che si possa definire lotta di classe, quale sarebbe la sua caratteristica saliente?
R. V’è un fatto storicamente comprovabile: tra la fine della seconda guerra mondiale e la fine degli anni Settanta-inizio anni Ottanta, la classe operaia, e più in generale la classe dei lavoratori dipendenti a partire da chi lavora in fabbrica, ha ottenuto, in parte con le sue lotte, in parte per motivi geopolitici, miglioramenti importanti della propria condizione sociale. Anche senza volerli chiamare, alla francese, i gloriosi Trent’anni, si è trattato di un periodo in cui decine di milioni di persone hanno avuto per la prima volta un’occupazione stabile e relativamente ben retribuita. Basti pensare, per quanto riguarda il nostro paese, che ancora nel 1951, anno del primo censimento dopo la guerra, esistevano in Italia centinaia di migliaia di braccianti pagati a giornata, su chiamata mattutina di un caporale, che lavoravano mediamente 140 giorni all’anno.
Per questi strati sociali, un impiego stabile nell’industria ha rappresentato un notevole avanzamento sociale. Sono aumentati i salari reali; sono stati introdotti o ampliati in molti paesi, Italia compresa, i sistemi pubblici di protezione sociale, dalle pensioni fondate sul metodo a ripartizione (in base al quale il lavoratore in attività contribuisce a pagare la pensione di quelli che sono andati a riposo, metodo che le mette al riparo dai corsi di Borsa e dall’inflazione) al sistema sanitario nazionale; si sono ridotti gli orari di lavoro di circa 2-300 ore l’anno (che vuol dire quasi due mesi di lavoro in meno); si sono allungate di settimane le ferie retribuite. Infine si sono estesi in diversi paesi, a partire dal nostro, i diritti dei lavoratori ad essere trattati come persone e non come merci che si usano quando servono o si buttano via in caso contrario. Queste conquiste, a cominciare dai sistemi pubblici di protezione sociale, sono state il risultato di riforme legislative – rinvio qui al nostro Statuto dei Lavoratori del 1970, voluto da un ministro del Lavoro socialista, Giacomo Brodolini, e redatto in gran parte da un giovane giuslavorista socialista pure lui, Gino Giugni – non meno che di imponenti lotte sindacali. Senza dimenticare il movimento degli studenti che in Italia come in Francia e in Germania contribuì sul finire degli anni Sessanta a inserire nell’agenda politica la richiesta di una democrazia più partecipativa.
Va rilevato che le conquiste in parola erano anche il risultato di un quadro geopolitico che è poi cambiato rapidamente dopo la fine degli anni Ottanta. Ad Oriente c’era infatti la grande ombra dell’Urss, il gigante di cui si temevano le mosse, che si poteva considerare in qualche modo rappresentato in Occidente da partiti politici di peso, come il Partito comunista in Francia e in Italia. Le classi dominanti sono state così indotte a cedere una porzione dei loro privilegi, tutto sommato limitata. In ogni caso ciò ha voluto dire una riduzione del potere di cui godevano, dovuta in parte alle lotte dei lavoratori, in parte al convincimento che fosse meglio andare in quella direzione affinché l’ombra ad Oriente non esercitasse troppa influenza nel contesto politico occidentale.
Verso il 1980 ha avuto inizio in molti paesi – Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Italia, Germania – quella che alcuni hanno poi definito una contro-rivoluzione e altri, facendo riferimento ad un’opera del 2004 dello studioso francese Serge Halimi, un grande balzo all’indietro. Le classi dominanti si sono mobilitate e hanno cominciato loro a condurre una lotta di classe dall’alto per recuperare il terreno perduto. Simile recupero si è concretato in molteplici iniziative specifiche e convergenti. Si è puntato anzitutto a contenere i salari reali, ovvero i redditi da lavoro dipendente; a reintrodurre condizioni di lavoro più rigide nelle fabbriche e negli uffici; a far salire nuovamente la quota dei profitti sul Pil che era stata erosa dagli aumenti salariali, dagli investimenti, dalle imposte del periodo tra la fine della seconda guerra mondiale e gli anni Ottanta.
In sostanza non è affatto venuta meno la lotta di classe. Semmai, la lotta che era stata condotta dal basso per migliorare il proprio destino ha ceduto il posto a una lotta condotta dall’alto per recuperare i privilegi, i profitti e soprattutto il potere che erano stati in qualche misura erosi nel trentennio precedente.
La caratteristica saliente della lotta di classe alla nostra epoca è questa: la classe di quelli che da diversi punti di vista sono da considerare i vincitori – termine molto apprezzato da chi ritiene che l’umanità debba inevitabilmente dividersi in vincitori e perdenti – sta conducendo una tenace lotta di classe contro la classe dei perdenti. È ciò che intendo per lotta di classe dopo la lotta di classe.
D. Chi sono gli attori, i protagonisti di questa lotta di classe condotta dall’alto? Come si compone la classe che conduce questa controffensiva?
R. Questa lotta viene condotta dalle classi dominanti dei diversi paesi, le quali costituiscono ormai per vari aspetti un’unica classe globale. Rientrano in esse i proprietari di grandi patrimoni, i top manager, ossia gli alti dirigenti dell’indust...