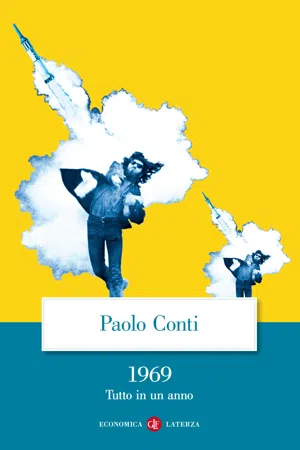1.
Gennaio.
Jan Palach accende un fiammifero
«La lettera, salvi la lettera!». Il tranviere sente il grido e rimane quasi immobile con il cappotto in mano. Vorrebbe spegnere subito le fiamme che divorano il corpo del ragazzo. Il torso e le gambe si contorcono ma lui non si ribella. Sembra arreso al fuoco. Ma come si può estinguere un incendio progettato in ogni dettaglio e alimentato da una intera lattina di benzina? Il tranviere ci prova comunque ma viene preso in contropiede dall’urlo della torcia umana: «La lettera, salvi la lettera!».
Lui, il conducente di uno dei vecchi tram di Praga, gli stessi che pochi mesi prima si erano fermati nel cuore della città antica bloccati dai carri armati sovietici invasori, ha seguito, quasi con la coda dell’occhio, gli strani gesti di un ventenne magro e ben vestito mentre il suo mezzo sferragliava verso il centro di piazza San Venceslao. Il ragazzo, Jan Palach, vent’anni, studente iscritto a Filosofia, l’aria ordinata e chiara tipica della fiera gente di Praga, è in piedi sulla scalinata del Museo nazionale. L’autista del tram, mentre guida, lo vede poggiare lo zaino per terra: al suo interno più tardi troveranno solo un pettine, alcune istantanee di Jan, di amici, di familiari. Poi il giovanotto tira fuori una lattina, si toglie il cappotto, si sfila le scarpe e le allinea, si inzuppa con gesti rapidi tutti gli abiti. Quasi un rito ripetuto mille altre volte. Non un varco al nervosismo, all’ansia.
Jan accende un fiammifero. Il tranviere per istinto si ferma, aspetta l’inevitabile calore della vampata e viene investito dal nitore delle fiamme. Il tranviere corre giù con il suo inutile cappotto in mano e sente il grido: «La lettera, salvi la lettera!».
È il 16 gennaio 1969, pomeriggio inoltrato, quasi verso sera. La città, ghiacciata, è al quinto mese di occupazione sovietica. Anzi, di «aiuto fraterno», per dirla con la versione ufficiale di Mosca. Uno sguardo al 21 agosto 1968, quando comincia l’amorevole gesto politico di «aiuto fraterno». All’alba i carri armati violano il confine per soffocare la Primavera di Praga. Qualche cifra aiuta a capire le dimensioni della tragedia cecoslovacca, lo sfondo allo spettacolare suicidio di Jan Palach. Nella notte tra il 20 e il 21 agosto 1968, seicentocinquantamila uomini armati, che indossano divise dell’Unione Sovietica, della Germania Orientale, della Polonia, dell’Ungheria e della Bulgaria invadono la Cecoslovacchia. L’universo del Patto di Varsavia reagisce contro la cellula impazzita di Praga. Qualcosa sta scompaginando il plumbeo ordine del blocco comunista. Bisogna agire presto, prima che diventi qualcosa di serio e difficilmente controllabile come la rivolta di Budapest nel 1956.
La Primavera di Praga, nel 1968, non è certo una sommossa anticomunista, piuttosto il sogno di un comunismo democratico e riformato, strettamente legato alla democrazia. Nessuna velleità di abbattere il sistema collettivista, come avverrà con la caduta del Muro di Berlino: solo l’utopia di riformarlo e magari restituirlo alla creatività e alla fantasia della primissima rivoluzione russa, alla terra delle multicolori speranze ideologiche e artistiche poi soffocate dal totalitarismo.
Lo chiamano, con uno slogan famoso, voluto dal segretario del Partito comunista cecoslovacco Alexander Dubcˇek, il «socialismo dal volto umano». Dice Dubcˇek nelle ore in cui sostituisce il filosovietico Antonín Novotný alla guida del partito comunista cecoslovacco: «Dobbiamo rimuovere qualsiasi ostacolo che soffochi la creatività artistica e scientifica».
Quasi un’anticipazione, più creativa e sostenuta da una base popolare, della perestrojka di Gorbacˇëv. Esattamente trent’anni dopo lo scrittore e commediografo Václav Havel, parlando da presidente della Repubblica, avrebbe raccontato: «La Primavera di Praga fu bella e indimenticabile. Per la prima volta in vent’anni si poteva parlare liberamente, respirare liberamente. L’invasione sovietica rivelò cosa voleva dire veramente comunismo. Rivelò il suo carattere totalitario».
Gli invasori in effetti conquistano il palazzo della radio, ma i cechi riescono a portar via le attrezzature e così nasce una radio libera che, attraverso gli altoparlanti sistemati nelle piazze, diffonde per poco tempo la voce della resistenza agli armati del comunismo ufficiale.
Con l’invasione tutto finisce nel giro di qualche giorno: libertà di stampa, di espressione, di manifestazione. Niente letteratura del dissenso. Televisione sotto ferreo controllo. Nessuno a Praga spera nell’aiuto dell’Occidente. Dall’altra parte della «cortina di ferro» la parola d’ordine è perentoria: è un affare interno al blocco comunista, l’Ovest non ha alcun interesse a intervenire. Gli Stati Uniti hanno questioni ben più complesse e planetarie da affrontare: sono appena riprese le trattative sugli armamenti strategici con Mosca. L’impressione generale è che le due superpotenze abbiano raggiunto un equilibrio molto chiaro: i sovietici occupano con i loro carri armati Praga per soffocare i malesseri interni al sistema comunista, gli americani possono restarsene tranquillamente in Vietnam. La pura facciata, le dichiarazioni di circostanza espresse per la stampa e l’opinione pubblica, non contano assolutamente nulla.
Dopo la repressione dell’agosto 1968, nel giro di pochi mesi quasi trecentomila cecoslovacchi fuggono dal paese-fortezza. Ovviamente non utilizzano le frontiere ufficiali, ma abbandonano il territorio dai campi e dalle montagne. Soprattutto l’emorragia di intellettuali è devastante, per l’effervescente Cecoslovacchia, una frontiera tradizionalmente aperta sulla Mitteleuropa di cui continua a far parte col cuore e anche con la mente. Non se la passa bene nemmeno chi rimane. Milan Kundera, che l’Occidente ha appena conosciuto e amato per il suo Lo scherzo, premio 1968 dell’Unione degli scrittori cechi, una satira durissima degli anni in cui anche a Praga si celebravano i riti del culto della personalità di Stalin, viene espulso nel 1970 per la sua adesione alla Primavera.
Torniamo alla lettera di Jan, che affonda le sue disperate radici in tutto questo materiale storico e umano. La sua prosa è scabra e cupa, com’è Praga in quelle ore. Nessuna concessione a una prevedibile retorica: «Poiché i nostri popoli sono sull’orlo della disperazione abbiamo deciso di esprimere la nostra protesta e di scuotere la coscienza della gente. Il nostro gruppo è costituito da volontari, pronti a bruciarsi per la nostra causa. Poiché ho avuto l’onore di estrarre il numero 1, è mio diritto scrivere la prima lettera ed essere la prima torcia umana. Noi esigiamo l’abolizione della censura e il divieto della diffusione di ‘Zprávy’ [il giornale ufficiale delle forze di occupazione sovietiche]». E così si chiude: «Se le nostre richieste non verranno esaudite entro cinque giorni, il 21 gennaio 1969, e se il nostro popolo non darà un sostegno sufficiente a queste richieste, con uno sciopero generale e illimitato, una nuova torcia si infiammerà». La carta è semplicissima, un quaderno a righe da scolaro. La firma è «Torcia 1». Il primo della lista. Quanti erano i ragazzi pronti a darsi fuoco? Come vedremo, nessuno lo saprà mai.
Il gesto di Jan, agli occhi dei suoi concittadini e del mondo intero, cita insieme due esempi, uno antico e l’altro modernissimo. Il primo è Jan Hus, il sacerdote predicatore della cappella di Betlemme a Praga, grande fustigatore del clero e dell’aristocrazia, condannato al rogo dal Concilio di Costanza il 6 giugno 1415, simbolo della nazione ceca, della sua identità e dei suoi diritti. L’altro richiamo è naturalmente ai roghi dei monaci buddisti che, in Vietnam, si immolano, ieraticamente immobili, per protestare contro l’occupazione americana. Cogliendo l’analogia, il «Corriere della Sera» del 17 gennaio titola: «La protesta di uno studente contro i russi. Tenta di uccidersi a Praga, dandosi fuoco come i bonzi».
Scriverà qualche mese dopo, in Italia, Francesco Guccini nella sua canzone Primavera di Praga: «[...] la piazza fermò la sua vita / e breve ebbe un grido la folla smarrita / quando la fiamma violenta ed atroce / spezzò gridando ogni suono di voce [...]».
Palach non ha annunciato a nessuno la sua scelta. Dirà anni dopo a Enzo Biagi suo fratello Jirˇí: «Il giorno prima tutta la famiglia si è incontrata ai funerali di un mio zio. Ho parlato con Jan. Non c’era niente in lui che potesse far pensare al gesto che stava preparando. È stata l’ultima volta che l’ho visto». E ancora: «Il mattino dopo Jan ha salutato la mamma, le ha chiesto della carta da lettere. Non ne aveva, e lui ha detto ‘Non importa, me la comprerò per strada’». Invece Jan non trova fogli né buste regolari, ripiega su un comune foglio a quadretti da scuola elementare. Ecco il punto: la lettera. L’importante è scrivere la lettera, che finirà prima nelle mani del tranviere e poi all’ospedale di via Legerova, a cinquecento metri di distanza da piazza San Venceslao, dove viene ricoverato. Il testo della lettera viene scritto in una stanza da studenti, alla presenza di quattro amici.
La notizia del rogo umano, poi del messaggio politico, e infine delle condizioni di Jan Palach, che agonizza per settantatré ore dopo essersi procurato ustioni di terzo grado sull’80% della superficie del corpo, compie immediatamente il giro di Praga, poi dell’intero paese e in poche ore del mondo: il vicinissimo confine con l’Austria permette ai tanti corrispondenti stranieri, che vivono a Vienna per studiare da vicino l’universo comunista, di comprendere fin da subito la portata complessiva del gesto. Jan si mantiene a lungo lucido, segue alla radio e sui giornali le reazioni al suo gesto. Ed è proprio lui a spiegare ai medici il legame diretto con Jan Hus. La solidarietà popolare è immensa. Ai giornali arrivano centinaia di telefonate tutte uguali: «Siamo pronti a donare il nostro sangue, anche brani di pelle per salvare il signor Palach».
La piazza praghese si muove rapidamente. La mattina dopo, in piazza San Venceslao, si forma una manifestazione spontanea. Migliaia di telefonate tra studenti, un tam tam popolare. E poi bastano i telegiornali e i notiziari radiofonici ufficiali a far capire l’assurda gravità del momento.
Su uno dei tanti cartelli sistemati intorno al monumento a San Venceslao si legge: «Che cosa si deve dire di un’epoca nella quale un corpo che brucia porta la luce per il futuro?». Intorno, più numerosi a ogni ora che passa, altri cartelli. Poi fiori, candele, fotografie, ritagli di quotidiani. L’atmosfera ricorda una delle tante manifestazioni studentesche occidentali del momento. Ma col particolare che siamo nella Praga comunista, occupata dalle truppe del Patto di Varsavia. Ventiquattr’ore prima, un qualsiasi movimento di piazza come questo sarebbe stato sciolto dalla polizia, anzi dai militari. Accanto alle tracce del rogo, alcuni studenti alzano una tenda da campeggio e un gruppetto proclama lo sciopero della fame. Un centinaio di ragazzi raggiunge il centralissimo Hotel Haštal, sede del comando sovietico. Urlano «Russi tornatevene a casa», cantano l’inno nazionale cecoslovacco. E il tutto finisce sulle prime pagine dei quotidiani del blocco occidentale, al di qua (come si diceva all’Ovest) della «cortina di ferro». Ma da Mosca è certamente arrivato l’ordine, ai propri uomini a Praga, di non rispondere alle provocazioni. L’evidente pericolo è far precipitare una situazione già difficilissima: gli occhi del mondo occidentale sono tutti puntati sulla città ed è in gioco non solo l’equilibrio tra i blocchi ma anche il prestigio del blocco comunista.
Ma chi è Jan Palach? Non ci fosse stato il comunismo, sarebbe stato un tipico esponente della piccola borghesia praghese. Suo padre era stato proprietario di una bottega di pasticceria a Všetaty, dopo il 1948 era andato a lavorare in un panificio industriale. Jan sarebbe stato probabilmente un adulto diverso da lui, meno intrinsecamente piccolo-borghese, più intellettuale, più reattivo e meno abitudinario, sicuramente affacciato sulla cultura della grande tradizione del romanzo europeo e americano. Insomma, un ragazzo europeo degli anni Sessanta. Bernardo Valli, straordinario e attentissimo inviato speciale, elenca così le letture preferite dello studente di Filosofia, guardando i risvolti dei libri ritrovati a casa della madre, nel paesino di Všetaty: Dumas, Verne, Aragon, Hemingway, Tolstoj e Remarque. A sedici anni aveva già letto quasi tutta la Bibbia. Ma non per un legame con la fede cristiana di stampo evangelico che la madre aveva cercato di trasmettergli. In realtà gli interessava l’aspetto letterario e narrativo. In quegli anni passava ore e ore sprofondato nel divano a leggere, e sua madre era costretta quasi a cacciarlo di casa almeno per prendere aria e dare quattro calci a un pallone con gli amici. Con scarsi risultati. Forse da tutte queste letture precoci nasce la prosa secca, antiretorica, non compiaciuta della famosa lettera.
Mentre Jan agonizza, la macchina della propaganda ufficiale si muove con un unico scopo: bloccare gli altri quindici studenti, anonimi e non identificabili, che hanno già promesso di darsi fuoco. Due giorni dopo il rogo, la tv di Stato trasmette un accorato appello del presidente del sindacato scrittori, Jaroslav Seifert: «Vi prego di non pensare, nella disperazione in cui vi trovate, che la nostra situazione possa essere risolta immediatamente. Voi avete il diritto di fare ciò che volete, ma non uccidetevi, se non volete che noi tutti ci uccidiamo».
Jan muore. Nemmeno dal Vaticano arriva una condanna ufficiale. Si spiega che un suicida, in speciali casi, non deve affrontare la disperazione dell’inferno. Praga è una città cattolica, anche se sotto il dominio comunista, e il giudizio etico assolutorio è più di un segnale politico e religioso insieme. Il 25 gennaio si celebra il funerale. Piove, fa molto freddo, a tratti cade nevischio misto a pioggia. Praga si mobilita in silenzio, la rete popolare si sostituisce a una informazione ufficiale fredda e asettica. Chi arriva dalla provincia lo fa a piedi, nella notte, per evitare il blocco dei treni. Ma cosa si può ...