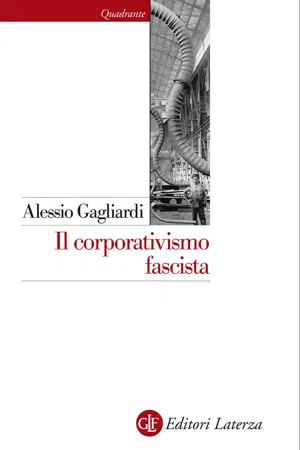
- 208 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Il corporativismo fascista
Informazioni su questo libro
Il fascismo volle proporsi come 'terza via' alternativa al capitalismo e al socialismo, come esperimento rivoluzionario fondatore di uno 'Stato nuovo' e di un diverso sistema sociale. Della terza via fascista il corporativismo fu uno degli aspetti principali e maggiormente appariscenti. Oggetto di accesi dibattiti e della costante attenzione delle gerarchie del fascismo, l'attuazione delle corporazioni fu però tardiva e per nulla commisurata alle aspettative. Nonostante la notevole sproporzione tra le parole e i fatti, l'azione del sistema corporativo non fu però senza esito, perché accompagnò e favorì trasformazioni profonde nell'organizzazione delle classi e dei ceti e nel rapporto tra la società e lo Stato.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Il corporativismo fascista di Alessio Gagliardi in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Storia e Storia del XXI secolo. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
StoriaCategoria
Storia del XXI secolo1. Cultura, idee, ideologia
1. La «civiltà dei produttori»
Nessuna questione più del corporativismo riuscì ad animare il dibattito culturale e ideologico dell’Italia fascista. Il miraggio di una società armonica, non più infuocata e divisa dalla lotta di classe, attirava e coinvolgeva ampi settori del mondo intellettuale. Tra la metà degli anni Venti e la fine degli anni Trenta videro la luce migliaia di volumi, articoli, opuscoli divulgativi e riviste dedicate appositamente al tema; furono organizzati convegni di studio e innumerevoli incontri di propaganda; vennero create apposite istituzioni culturali; furono infine modificati gli insegnamenti universitari nelle materie economiche e giuridiche per inserire istituzionalmente il verbo corporativo. L’impressionante mole delle pubblicazioni è perfettamente testimoniata dalla Bibliografia sindacale-corporativa pubblicata da Alfredo Gradilone nel 1942, composta di oltre millecento pagine e di circa dodicimila voci bibliografiche1.
Tra gli innumerevoli contributi si annoverano non solo quelli dei dirigenti fascisti di primo piano e di molti dei più noti intellettuali del periodo. Il tema circolò ampiamente anche presso gli intellettuali non inseriti nell’accademia e nei grandi istituti culturali, presso le riviste a diffusione provinciale e le piccole case editrici. Il corporativismo fu infatti, durante il fascismo, pressoché l’unico argomento sul quale in Italia si potessero esprimere posizioni difformi2.
Già negli anni precedenti numerosi filoni culturali e politici avevano manifestato e variamente sviluppato l’esigenza di un superamento dello Stato liberaldemocratico e il sostegno a modelli corporativi. L’aspirazione a una riforma dello Stato incentrata sulla presenza nel parlamento di rappresentanze delle categorie produttive e il vagheggiamento di una conciliazione dei diversi interessi sociali attraversavano infatti gli schieramenti. Il corporativismo, come forma di difesa dalla lotta di classe ma anche dall’invadenza dello Stato, rappresentava dall’ultimo ventennio dell’Ottocento uno degli aspetti costitutivi della dottrina sociale della Chiesa e del programma del movimento cattolico. Nel primo dopoguerra, sulla scia anche dell’esperienza della mobilitazione industriale durante la prima guerra mondiale, la questione della collaborazione tra le classi aveva esercitato significative suggestioni nel mondo imprenditoriale, nella minoranza turatiana del Partito socialista e in alcuni settori della dirigenza sindacale3. Evidenti richiami al corporativismo permearono la Carta del Carnaro, la costituzione dello «Stato libero di Fiume». L’invocazione di una «trasformazione del Parlamento mediante un’equa partecipazione di industriali, di agricoltori, di ingegneri e di commercianti al Governo del Paese» appariva anche nel Manifesto del Partito futurista italiano stilato da Marinetti all’inizio del 19184. Il corporativismo fu soprattutto un elemento decisivo dell’ideologia e del programma politico dei nazionalisti – principalmente per opera di Alfredo Rocco, che ne realizzò una torsione in senso statalista – e di quella componente del sindacalismo rivoluzionario approdata, attraverso la scelta interventista, alla nuova esperienza del sindacalismo nazionale dell’Unione italiana del lavoro, guidata da Alceste De Ambris ed Edmondo Rossoni5.
Fu proprio da questi due precedenti politici e ideologici che il fascismo trasse gli architravi su cui fondare la propria idea di corporativismo. Il primo era il produttivismo, che sostituiva la lotta per la distribuzione della ricchezza tra le classi con l’obiettivo dell’aumento al massimo grado della capacità produttiva dell’economia nazionale. La figura di riferimento diveniva quella del «produttore», che racchiudeva tutte le componenti che partecipavano alla produzione, dall’operaio al tecnico fino all’imprenditore. Il secondo, legato strettamente al presupposto produttivistico, era il rifiuto del sistema di rappresentanza liberale, incentrato sul meccanismo elettorale e sull’atomismo individuale, e il conseguente sostegno a un nuovo sistema di rappresentanza basato sulle categorie produttive. Non il cittadino ma il produttore era dunque posto al centro del sistema corporativo. L’individuo veniva in questo modo inchiodato a una dimensione unica, identificato strettamente con il suo status professionale e con la sua condizione lavorativa6.
Vale la pena rilevare come un’identificazione di questo genere appaia, almeno a prima vista, difficilmente conciliabile sia con la mobilitazione ideologica promossa dal regime, fondata sull’identificazione diretta di individuo e Stato fascista e connotata da marcati accenti antimaterialisti e spiritualisti, sia con l’allargamento e la differenziazione delle esperienze di vita di ampi settori delle classi medie, prodotto di una prima limitata diffusione dei consumi e di una nuova disponibilità di tempo libero. Solo una storia sociale delle idee potrebbe illuminarci non solo su come queste diverse spinte si sommarono l’una all’altra ma anche sull’interazione con i diversi strati della società. La riflessione degli intellettuali, da parte sua, non contribuì certo a sciogliere il nodo, di cui anzi si mostrò generalmente poco consapevole.
In ogni caso, fortemente radicata nella temperie degli anni a cavallo della grande guerra, quando numerosi filoni culturali e politici furono in varia misura contagiati dall’ottimismo della «civiltà dei produttori», la prospettiva produttivistica sarebbe apparsa assai poco realistica nel pieno della crisi economica degli anni Trenta. La caduta di quella prospettiva avrebbe perciò costretto molti interpreti dell’idea corporativa ad abbandonare la strada del culto dell’efficienza tecnica e della razionalità organizzativa per percorrere quella dell’antimaterialismo e dell’antiutilitarismo.
L’idea di un sistema fondato sull’eliminazione del conflitto fra le classi faceva parte sin dall’inizio del bagaglio ideologico e programmatico del fascismo. Fu però solo dalla metà degli anni Venti che prese avvio il vero e proprio dibattito sul corporativismo. Da quel momento infatti il tema iniziò a uscire dalla vaghezza e dalla nebulosità. Cominciarono a diradarsi alcuni equivoci concettuali e semantici che ne avevano accompagnato la messa a punto. Basti pensare al fatto che, ancora fino alla legge sindacale del 1926, il termine «corporazione» veniva utilizzato nelle riviste e nei documenti ufficiali per indicare indistintamente le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi pubblici che avrebbero dovuto sovrintendere all’operato delle une e degli altri e coordinarne le attività in funzione di un comune obiettivo.
La fase di maggiore intensità e apertura delle discussioni sul corporativismo si ebbe nella prima metà degli anni Trenta. Coincise quindi con gli anni della crisi economica e della costruzione delle istituzioni corporative e iniziò a segnare il passo con la guerra d’Etiopia e la svolta imperialista, cui fece da contrappunto, nella politica e nell’ideologia economica, l’adozione dell’indirizzo autarchico7.
Nel corso di questo periodo il corporativismo costituì l’alveo entro cui venne ricondotta la produzione intellettuale sul tema della regolazione dell’attività economica, della «fine del laissez-faire», del controllo del progresso tecnologico, di una nuova legittimazione sociale dello Stato di massa, del carattere istituzionale assunto dalle organizzazioni di rappresentanza degli interessi sociali.
Per la scienza economica e per il pensiero giuridico degli anni Trenta le discussioni sul corporativismo furono anche l’occasione per tentare il rinnovamento di teorie e paradigmi interpretativi. Nell’ambito della cultura economica, i cosiddetti «corporativisti integrali» – Ugo Spirito, Gino Arias, Filippo Carli, Nino Massimo Fovel, tra i più rilevanti – tentarono, in termini diversi l’uno dall’altro, di porre in atto un’ambiziosa quanto velleitaria opera di demolizione della teoria classica e neoclassica, per costruire una «nuova scienza economica»8. Della dottrina marginalista, presto sbrigativamente denominata «liberale», i corporativisti misero in discussione soprattutto le premesse individualistiche, di cui era espressione l’astrazione dell’homo oeconomicus9. In quelle premesse vedevano l’origine della scissione di economia e politica, ritenuta «quasi una sorta di peccato d’origine»10. A legittimare le posizioni dei teorici della nuova scienza economica era lo stesso Mussolini. Per il capo del governo, infatti, il rifiuto della teoria dell’«uomo economico» era parte della costruzione dell’«uomo integrale» («che è politico, che è economico, che è religioso, che è santo, che è guerriero»), con cui si superavano le scissioni prodotte dalla civiltà liberale e si concretizzava l’«uomo nuovo» teorizzato e agognato dall’ideologia del fascismo11.
Sebbene la maggior parte degli studiosi accademici preferì rifugiarsi nel «nicodemismo» della separazione della teoria dalla politica economica o, come per l’agguerrita e autorevole minoranza liberista in cui spiccavano Luigi Einaudi, Pasquale Jannaccone e Costantino Bresciani-Turoni, nell’intransigente difesa della tradizione, è tuttavia significativo che un drappello di figure di indubbia autorevolezza – quali Rodolfo Benini, Alberto De Stefani, Luigi Amoroso e, più timidamente, Celestino Arena – seguisse la strada di una rivisitazione dei principi della disciplina alla luce della sfida portata dal corporativismo, cercando di coniugare l’abbandono del paradigma walrasiano della concorrenza perfetta e dell’individualismo metodologico con quanto di valido era conservato dalla teoria marginalista.
Anche la cultura giuridica partecipò attivamente al dibattito sul corporativismo. Questo rappresentava infatti una sorta di contenitore nel quale convergevano temi e suggestioni da lungo tempo centrali nella scienza del diritto, come le riflessioni sulla crisi dello Stato o le influenze dell’antindividualismo e dell’organicismo, frequentemente evocate nel pensiero giuridico italiano tra Otto e Novecento12.
L’incontro della scienza giuridica con il tema del corporativismo fu favorito anche dal fatto che l’esperimento corporativo costituì per i giuristi una sorta di detonatore per avviare un ripensamento del proprio ruolo e dei contenuti della disciplina13. Da un lato fu uno stimolo per uno svecchiamento della scienza del diritto, ancora largamente votata al culto ottocentesco dei testi normativi; dall’altro, impresse ancora più forza al tema del protagonismo sociale dello Stato e del superamento della tradizionale distinzione tra diritto, politica ed economia, e quindi tra diritto pubblico e diritto privato.
Anche in questo caso ci si trova davanti a un ampio ventaglio di riflessioni e analisi. Ai due estremi si collocavano i «giuristi di regime», o «giuristi militanti», partecipi alla costruzione dello «Stato nuovo» fascista e disposti a inserire l’ideologia politica all’interno del discorso giuridico (era il caso tra gli altri di Rocco, Costamagna, Panunzio, Volpicelli) e, sul versante opposto, i «giuristi della tradizione», ancorati al modello individualistico di convivenza e alla tradizione disciplinare (Del Vecchio, Ranelletti, Filippo Vassalli, Chiarelli, Asquini)14. Tra le nutrite schiere dei primi e dei secondi si segnalò poi un gruppo di autori che, pur respingendo la proposta totalitaria, vide nel corporativismo la possibilità di salvare alcuni elementi irrinunciabili del passato senza sposare completamente le soluzioni liberali, di ribadire la strutturale limitatezza del potere statuale, di sviluppare il tema della presenza pubblica nell’economia e nella società e, infine, di liberare il giurista dall’obbligo esclusivo dell’esegesi (fu il caso, tra gli altri, di Mossa, Cesarini Sforza, Finzi, Greco, Grechi, Capograssi)15.
2. La ricerca della terza via
La gran parte degli scritti e delle riflessioni sul corporativismo puntava però non solo a rifondare teorie e paradigmi culturali ma anche, soprattutto, a progettare un nuovo modello di società e di Stato. In quasi tutti i contributi confluivano infatti idee, analisi e proposte che inerivano direttamente alla ricerca degli elementi costitutivi e fondamentali dell’ideologia e del progetto politico del fascismo.
Il fascismo volle proporsi come «terza via» alternativa al capitalismo e al socialismo, come esperimento rivoluzionario fondatore di uno «Stato nuovo» e di un sistema sociale basato su un diverso equilibrio tra Stato, società e mercato16. Della terza via fascista, nei termini con cui fu costruita ideologicamente, propagandata e percepita negli anni tra le due guerre mondiali, il corporativismo fu uno degli aspetti principa...
Indice dei contenuti
- Introduzione
- 1. Cultura, idee, ideologia
- 2. L’autoritarismo sindacale
- 3. Corporativismo senza corporazioni
- 4. Le corporazioni entrano in funzione
- Sigle e abbreviazioni