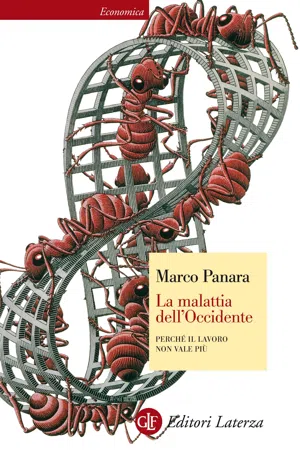Un razzo a quattro stadi
La crisi, volendo semplificare, è come un missile con quattro stadi: la crisi finanziaria, la crisi dell’economia reale, il crollo dell’occupazione, l’esplosione dei debiti sovrani.
Il boom nella costruzione di case è stato uno dei motori principali della crescita dell’economia americana tra il 2002 e il 2007, per l’attivismo del settore immobiliare in sé ma anche per quello che si porta dietro: l’acquisto di mobili, elettrodomestici, piatti, bicchieri e posate, coperte e lenzuola. Il boom immobiliare è stato fenomenale, e se l’economia americana, britannica e spagnola hanno fatto meglio in quegli anni rispetto agli altri paesi industrializzati in buona parte è dovuto ad esso.
Finanza (tassi bassi e denaro facile), economia reale (crescita trainata dal boom immobiliare), finanza (crollo dei subprime e tutto quello che è successo dopo). Questa è stata la prima concatenazione. Ma i meccanismi con i quali la crisi è passata dalla finanza all’economia reale sono più articolati e complessi.
Innanzitutto, prima, durante e dopo l’acme della crisi, sono accadute una serie di cose. La prima, in ordine di tempo, è la bolla delle materie prime. La finanza, si sa, non sta mai ferma, e i capitali enormi che vagano per il pianeta in cerca di opportunità di guadagno, abbandonato l’immobiliare, avevano individuato una nuova preda: le materie prime appunto. A partire dai primi mesi del 2008 i prezzi del petrolio, del grano, del rame, del ferro hanno cominciato a salire con ancora maggiore velocità di quanto negli anni precedenti avevano fatto quelli delle case. Nell’estate del 2008 abbiamo visto il petrolio superare i 140 dollari il barile. Non c’era una ragione sostanziale. Certo Cina e India, con i loro 2 miliardi e mezzo di abitanti e la loro vivace crescita economica, avevano determinato un aumento della domanda di combustibili fossili, certo la partenza dei biocombustibili aveva creato una tensione sul mercato delle materie prime agricole, ma né l’uno né l’altro fenomeno erano tali da determinare aumenti dei prezzi di quella rilevanza e con quella rapidità.
Paolo Scaroni, l’amministratore delegato dell’Eni, dice che la speculazione è come la schiuma sull’onda, se non c’è l’onda non c’è neanche la schiuma. È vero, l’onda ci deve essere, ma come ha dimostrato la caduta dei prezzi delle materie prime dopo i picchi dell’estate 2008, in quel caso la schiuma era notevole. Erano le scommesse in derivati sui mercati delle materie prime a ingigantire fenomeni reali (le onde) ma assai più contenuti.
Ebbene, quando salgono i prezzi delle materie prime, e in particolare il prezzo del petrolio, l’effetto – non immediato ma dopo qualche mese percettibile – è un rallentamento della crescita economica. Il perché è presto detto: quando sale il prezzo del petrolio aumenta il costo dell’energia, e quindi della produzione di beni, e aumenta il costo dei trasporti dei beni e delle persone. Ogni euro di costo in più del pieno della propria auto o della bolletta del gas è un euro sottratto ad altri consumi. Il fenomeno è stato di breve durata, poi il rallentamento di tutte le economie ha risospinto le materie prime verso il basso, ma il colpo sull’economia reale si è sentito, e non è stato un colpo da poco.
Paul Ormerod, economista e scrittore di successo, ha così sintetizzato il fenomeno in una intervista al «Sole 24 Ore» del 5 luglio del 2009: «Prezzi più alti delle materie prime hanno trasferito reddito dall’Occidente ai paesi produttori. Così la crescita reale annua del Pil del G7 è stata del 2,2 per cento nel primo trimestre del 2008, dell’1,5 nel secondo, dello 0,4 nel terzo. La caduta della produzione c’era già» prima del fallimento di Lehman Brothers.
Un altro economista americano, James Hamilton, il primo a stabilire un legame statistico tra ogni rapido aumento dei prezzi del petrolio e una recessione negli Stati Uniti, conferma che la regola vale anche in questo caso. I prezzi del petrolio, quindi, e delle altre materie prime, balzati verso l’alto grazie anche alla spinta dei capitali finanziari orfani ormai dei titoli subprime e in cerca di nuove opportunità di guadagno, hanno fatto la loro parte, anzi sono stati il primo meccanismo attraverso il quale la finanza ha trasmesso il contagio all’economia reale.
Il primo ma non l’unico. Il secondo è legato direttamente allo scoppio della bolla immobiliare. Un settore trainante di molte economie, e di quella numero uno durante gli anni del boom, si è letteralmente fermato. Con i prezzi in discesa e le case che restavano con il cartello vendesi per mesi, i costruttori hanno tirato i remi in barca. È scesa verticalmente la richiesta di nuove licenze edilizie, la domanda connessa al settore si è fermata anch’essa. Legno, cemento, acciaio, piastrelle, parquet, moquette, rubinetterie e sanitari, e poi elettrodomestici, mobili, suppellettili hanno registrato un crollo verticale della domanda.
Con i prezzi in discesa nessuno compra aspettando che scendano ancora ma, anche volendo comprare, o il costruttore costruire, c’è un secondo ostacolo dirimente: i soldi. Le banche per mesi non hanno finanziato più i mutui né nuove iniziative di sviluppo immobiliare, un settore pesante dell’economia e quelli collegati si sono così fermati. La crisi della finanza, anche per questa seconda via, è arrivata all’economia reale.
Purtroppo il contagio non finisce qui. Sulle case, soprattutto americane, in tempi relativamente brevi si rivedrà la luce. Non ci sarà, si spera, un nuovo boom ma almeno un ritorno alla normalità per le ragioni della demografia. L’eccesso di case costruite negli anni del boom, visto il blocco delle nuove costruzioni negli anni successivi, entro alcuni mesi sarà riassorbito dalla normale domanda di abitazioni legata alle nuove generazioni che si affacciano sul mercato e all’immigrazione, e una volta che lo stock di invenduto sarà stato assorbito la discesa dei prezzi si fermerà e il mercato ripartirà sulla base di un nuovo equilibrio. Queste le previsioni degli analisti, e probabilmente in questo caso si può dar loro credito.
Dove la ferita sarà più lunga da curare è la propensione al consumo. Soprattutto negli Stati Uniti, ma anche altrove, i consumi privati sono stati la componente fondamentale dello sviluppo economico negli ultimi anni prima della crisi. Peccato che quel consumo fosse finanziato in larga parte con i debiti, spesso fatti proprio a fronte del maggior valore delle case. Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, accadeva che, pur avendo già un mutuo sulla casa, quando questa aumentava il suo valore fosse possibile aumentare l’importo del mutuo, garantito (apparentemente) dal maggior valore della casa, e accadeva che quel denaro venisse utilizzato non per investimenti ma per finanziare la scuola per i figli, viaggi, abbigliamento, un nuovo armadio o un nuovo divano. E poiché al debito ci si abitua, a debito sono state comprate automobili, utilizzando carte di credito a rimborso rateale sono stati acquistati cappotti, iPhone, tv a schermo piatto. Consumi, insomma, di beni durevoli e non, finanziati con il debito.
La crisi è stata un brusco risveglio. Anche volendo andare avanti a consumare facendo nuovi debiti, è diventato praticamente impossibile trovare qualcuno che ti finanzi, ma soprattutto è diventato indifferibile il ritorno al vecchio costume del risparmio, prima per pagare i debiti pregressi e poi per prepararsi ad affrontare una situazione nella quale il proprio patrimonio immobiliare e mobiliare (per chi lo ha) vale meno, il posto di lavoro (sempre per chi lo ha) è meno sicuro, la prospettiva che i figli si sistemino rapidamente è più vaga, la pensione, con il valore dei fondi investito in azioni e anche in derivati falcidiato dal crollo dei mercati, più povera.
L’America, grande supermarket del mondo, non per mesi ma per anni, dovendo risparmiare di più consumerà meno, importerà meno beni di consumo e, poiché le fabbriche avranno meno ordini, anch’esse rinvieranno gli investimenti in nuovi macchinari. Vale per gli Stati Uniti, per l’Europa, per il Giappone. La domanda non sarà più vivace come prima e dovremo aspettare un aumento della capacità di consumo dei cittadini dei paesi emergenti per tornare ai livelli del 2006 o del 2007.
Basterebbe tutto questo, ovvero l’aumento repentino dei prezzi delle materie prime, il crollo del mercato immobiliare e la frenata dei consumi a spiegare il passaggio della crisi dalla finanza all’economia reale, ma in realtà c’è dell’altro ancora.
La crisi, come abbiamo visto, ha colpito all’inizio soprattutto le banche. Il crollo del valore di titoli derivati di varia natura ha aperto nei loro conti delle voragini il cui ammontare complessivo viene ora valutato in circa 2.300 miliardi di dollari. Buona parte del patrimonio delle banche mondiali è stato letteralmente spazzato via e solo le garanzie e gli interventi diretti dei governi nel capitale di molte di esse hanno evitato il collasso finale. Tuttavia, come abbiamo detto nei capitoli precedenti, nonostante gli interventi pubblici, da settembre del 2008 e per alcuni mesi successivi, il mercato interbancario si è praticamente bloccato, le banche, non avendo fiducia le une delle altre, non si prestavano più denaro a vicenda, la liquidità non circolava. Per sei mesi o giù di lì ottenere soldi per un mutuo, per finanziare un investimento o il circolante è diventato difficilissimo per tutti, e quei sei mesi hanno posto le basi per un rallentamento forte e prolungato dell’economia reale.
Passati quei sei mesi e rimesso ordine nella circolazione della liquidità, il problema è diventato un altro, anzi altri due. Il primo è il rapporto tra il capitale delle banche e gli impieghi.
La Banca dei Regolamenti Internazionali di Basilea aveva fissato un rapporto massimo tra patrimonio di rischio (‘Core Tier 1’, nel lessico finanziario) e impieghi delle banche, un rapporto modulato secondo il tipo di impiego. Gli investimenti in titoli di Stato, per esempio, considerati sicuri, non impegnavano capitale, quelli in titoli con il rating massimo (la famosa tripla A) ne impegnavano pochissimo, i crediti alla clientela ne impegnavano di più. Quello che abbiamo scoperto con la crisi è che, nonostante i parametri di Basilea, le banche avevano investimenti pari a molte decine di volte il loro patrimonio di vigilanza, e abbiamo scoperto anche che in molti casi il crollo del valore di quegli investimenti si era mangiato a volte una parte, a volte tutto il capitale e a volte anche molto di più. Il sistema bancario è diventato un malato grave e la sola soluzione possibile in casi come questo è una doppia terapia fatta di ricostruzione del capitale da una parte e riduzione degli impieghi dall’altra. I tecnici chiamano questo processo ‘deleveraging’, i cronisti ‘credit crunch’. Per tutti gli altri è la umiliante esperienza di sentirsi chiamare dalla banca per rientrare del fido oppure di andare in banca e sentirsi rifiutare (o spesso non rispondere) quando si chiede un finanziamento.
Con il credito fermo o che va avanti con il contagocce è difficile che l’economia corra, è assai più probabile che vada indietro. Perché il rapporto difficile con le banche, o anche solo il timore di un rapporto difficile, innesca una spirale perversa: chi deve pagare i fornitori, anche se ha denaro in cassa rallenta i pagamenti, e chi deve incassare si trova a corto di denaro che pure riteneva di aver già guadagnato. Gli anelli più fragili della catena si spezzano, alcune aziende falliscono, il recupero dei crediti per i fornitori diventa improbabile e comunque a lunghissimo termine. Molti fanno fatica a tenere il ritmo dei pagamenti alle banche e vanno in sofferenza, le banche si spaventano e restringono ancora di più i cordoni della borsa. Molte imprese rinunciano a prendere ordini perché temono di non venire poi pagate o perché non hanno circolante per finanziare la produzione; la produzione rallenta, gli impianti vengono utilizzati assai meno rispetto alle loro potenzialità e i costi fissi aumentano la loro incidenza sui costi totali di produzione. Si ammala così anche il sistema produttivo.
Siamo arrivati allo stadio successivo. Con la domanda che crolla (perché i consumi sono bassi) e un accesso più difficile al credito, la reazione dell’impresa è molto simile a quella della famiglia: come quest’ultima riduce i consumi e rinvia l’acquisto di beni durevoli, così la prima taglia dove può i costi e blocca gli investimenti. Rallenta al massimo quelli in corso, rinvia a tempi migliori quelli programmati ma non ancora partiti. Gli investimenti sono un motore fondamentale della crescita economica attuale e sono la premessa per la crescita futura, bloccarli vuol dire quindi far crescere meno l’economia oggi e anche porre le premesse per una crescita più bassa domani.
È quello che è accaduto nel 2009 e che avrà conseguenze anche negli anni a venire.
Bloccare gli investimenti vuol dire non solo non costruire nuovi capannoni, ma anche non comprare macchinari, non acquistare tecnologie, il che comporta un crollo degli ordini per le aziende che quei macchinari e quelle tecnologie producono. Nell’insieme meno consumi e meno investimenti sono la causa del segno meno che ci troviamo dietro il dato sulla crescita del Pil nel 2009.
L’esito finale è la crescita negativa dell’economia mondiale, per la prima volta da molti decenni a questa parte. Il prodotto globale è andato indietro dell’1,1 per cento, ma ai paesi industrializzati è andata molto peggio. I leader, o forse dovremmo dire gli ex leader, hanno perso nell’anno il 3,4 per cento del loro prodotto, con punte del 5,1 in Giappone, del 4,9 in Germania, del 5,1 in Italia, del 4,8 nel Regno Unito. A bilanciare in parte il risultato finale ci ha pensato l’Asia che, escluso il Giappone, ha registrato una crescita del 5,6 per cento, e la Cina addirittura dell’8,7.
Quando l’economia va indietro e il portafoglio ordini delle imprese rallenta o si esaurisce, diminuisce il lavoro e la reazione delle aziende è quella di ridurre il personale. Prepensionamenti dove possibile, cassa integrazione dove e fin quando possibile, licenziamenti quando le altre strade si sono esaurite. Così dalla crisi finanziaria, diventata dopo qualche tempo crisi della economia reale, si arriva a un vero e proprio problema sociale, la crescita della disoccupazione, che per i meccanismi di trasmissione da un comparto all’altro dell’economia, raggiunge il suo punto più alto quando la crisi finanziaria è ormai sostanzialmente (si spera) superata e l’economia reale comincia a dare segni di ripresa.
La disoccupazione arriva più tardi ma è la conseguenza più grave, perché tocca direttamente la vita di milioni di persone e delle loro famiglie, il loro tenore di vita e il loro progetto di vita, incide sulle sicurezze, sulla visione, sulla politica. Incide sull’economia, perché si disperdono capacità e professionalità, si impoverisce il tessuto produttivo, e incide anche negativamente sui consumi, perché il minore reddito di milioni di famiglie si concretizza in minori consumi e, di conseguenza, in una più bassa domanda globale.
Secondo l’Organizzazione Internazionale del Lavoro il biennio 2008-2009 ha cancellato 34 milioni di posti di lavoro, un record storico, portando il totale dei disoccupati a 212 milioni. Il grosso si registra nei paesi occidentali. Nei soli Stati Uniti il numero dei disoccupati è balzato a 14,8 milioni e il tasso di disoccupazione ha sfiorato il 10 per cento. A quei 14,8 milioni bisogna peraltro aggiungere 9,4 milioni di persone che non compaiono nelle statistiche sull’occupazione perché hanno rinunciato a cercare lavoro (e quindi non sono inclusi nei 34 milioni di nuovi disoccupati censiti dall’Oil). Secondo l’Oil, la disoccupazione è cresciuta soprattutto nei paesi sviluppati e in Europa, con un aumento del 2,3 per cento, seguiti dall’Est Europa e dai paesi ex sovietici dove il balzo è stato del 2 per cento, e dall’America Latina e dai Caraibi con l’1,2 per cento. Complessivamente le tre aree contano per i due terzi dell’aumento della disoccupazione totale del 2009. Le previsioni fatte dall’Organizzazione all’inizio dell’anno calcolano un ulteriore aumento nel 2010, soprattutto nei paesi avanzati dove la disoccupazione è previsto salga dall’8,4 per cento del 2009 all’8,9 per cento nel 2010.
Ma le statistiche sulla disoccupazione non dicono tutto, perché, come abbiamo visto per gli Stati Uniti, dovunque un periodo prolungato di crisi determina un fenomeno sociale di diminuzione della partecipazione al mercato del lavoro. La gente, scoraggiata, semplicemente non cerca più e così scompare dalle statistiche sulla disoccupazione. C’è un altro dato che rivela questa tendenza, si chiama tasso di partecipazione al lavoro. Ebbene anche questo tasso è diminuito, globalmente dello 0,8 per cento. È un fenomeno che riguarda particolarmente i giovani, i più colpiti dalla disoccupazione in generale e dall’aumento determinato dalla crisi, l’1,9 per cento dei quali ha deciso di restare a casa e non cercare.
In Giappone, dove si dà un nome ad ogni cosa e ad ogni comportamento, questo popolo dei giovani che si autoescludono non solo dal mondo del lavoro ma dalla società in generale è stato battezzato ‘hikikomori’, ragazzi che finita la scuola o l’università si chiudono nella loro stanza e scelgono una vita autistica, rifiutano la sfida della crescita e dell’inserimento nella vita attiva. Si calcola che siano un milione, nel paese che fa del lavoro il perno della collocazione sociale. D’altra parte sempre in Giappone, dove in genere il giorno dopo l’uscita dall’università si sa già in quale azienda o amministrazione si andrà a lavorare, dei 450.000 laureati nella primavera del 2010, oltre 100.000 sono rimasti senza impiego, condannati probabilmente ad una fase, si spera breve, di totale disoccupazione, che poi diventerà un’occupazione part time o a tempo determinato per chissà quanto tempo.
I giovani, insieme alle donne, sono d’altra parte l’anello debole della catena. Sempre l’Oil ha calcolato che anche in tempi normali un giovane abbia 2,8 possibilità in più di rimanere senza lavoro rispetto ad un adulto. La disoccupazione giovanile globale, al 12,1 per cento nel 2008, quindi già decisamente più alta della media, è salita al 13,4 nel 2009 (l’aumento totale della disoccupazione tra il 2008 e il 2009 è stato dello 0,7 per cento, per i giovani dell’1,3). Nei paesi industrializzati il balzo è stato addirittura del 4,6 per cento, mentre la loro partecipazione al lavoro è diminuita globalmente del 3,4 per cento tra il 1999 e il 2009.
Negli Stati Uniti oggi oltre un terzo di chi ha tra 18 e 29 anni...