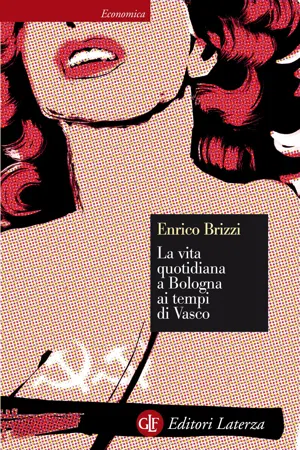Sciopero!
Ogni tanto la maestra Angela ci faceva aprire il diario, e dettava un avviso che ognuno era tenuto a mostrare ai genitori ché lo firmassero: «Le organizzazioni confederali Cgil-Cisl-Uil hanno proclamato una giornata di sciopero nella data del...».
A quel punto, già esultavamo scomposti: se lo sciopero era promosso dalle tre magiche sigle, avevamo la certezza che per noi non ci sarebbe stata scuola.
La maestra aveva un bell’affannarsi per spiegare la differenza fra uno sciopero e, poniamo, la festa del Santo Patrono.
Personalmente, ero contento perché sapevo che avrei potuto trascorrere la giornata in centro.
Richiedeva il suo tempo, raggiungere i dintorni di piazza Maggiore, e non era cosa di tutti i giorni. Ci si andava il sabato pomeriggio, a piedi e senza protestare in cambio d’un gelato alla Torinese; durante la settimana, solo quando saltava la scuola, ed era un po’ come andare all’estero.
Potevo accompagnare nonna a fare spese al Mercato delle Erbe, dove parlava in dialetto con i venditori. Qualcosa afferravo, ma appena la conversazione prendeva quota era come assistere a incomprensibili pezzi di teatro in giapponese, o uzbeco stretto.
Oppure potevo raggiungere insieme a mio padre piazza Verdi, il cuore della zona universitaria, dove svettavano tre totem metallici di Giò Pomodoro. Sotto le finestre erano appesi striscioni in un alfabeto sconosciuto, che mio padre giurava essere opera degli studenti greci.
«Sono buoni o cattivi, babbo?»
Niente paura, erano bravi ragazzi, figli di una democrazia ancora fragile.
Ero fiero di scortarlo all’interno del dipartimento di Discipline storiche, in largo Trombetti, dove condivideva un ufficio con il suo ex insegnante Paolo Prodi. Generalmente, mentre mio padre si procurava i documenti che avrebbe poi esaminato a casa, venivo parcheggiato con un foglio e una penna in un ambiente dalle alte scaffalature metalliche colme di libri e faldoni, che doveva essere l’archivio del dipartimento.
Seduto a un tavolo immenso per le mie dimensioni ancora ridotte, sotto la grande finestra difesa da una grata, aspettavo disegnando il ritorno del Pater.
Se non passavano a farmi visita i suoi colleghi che conoscevo come amici di famiglia, potevo restare solo per un tempo discretamente lungo, così mi cimentavo con soggetti complessi, vere e proprie scene di massa fitte di inglesi dell’Ottava Armata in azione contro l’Africacòrp.
Grazie agli amati soldatini Matchbox, agli inserti Conoscere insieme del «Giornalino» e ai vecchi «Supereroica» di mio cugino Gabriele conoscevo nel dettaglio l’equipaggiamento di tedeschi, inglesi, russi, americani e giapponesi. Altre marche proponevano autentiche chicche in scala 1/72, come i parà italiani (ma erano italiani buoni o cattivi?) o i fanti di marina francesi (e loro?). In determinate cartolerie off si trovavano financo i cinesi camuffati con la paglia. Inspiegabilmente, però, non c’era verso di rimediare una sola scatola di soldatini dedicata ai partigiani delle Brigate Garibaldi, e neppure ai polacchi del generale Anders, che pure nel giorno radioso del 21 aprile 1945 avevano liberato insieme la città dal giogo nazifascista.
La nostra versione cittadina della seconda guerra mondiale e della lotta di liberazione mostrava una crepa fatale agli occhi d’un bambino degli anni Ottanta: mancavano i gadget.
Se una ditta seria come la Matchbox non produceva partigiani e polacchi, e nella serie di diorami Atlantic la battaglia di Porta Lame del novembre 1944 non figurava accanto a Stalingrado, Iwo Jima e Bastogne, come avremmo potuto mettere in scena il nostro mito fondativo?
Un sospetto orribile si faceva largo: forse anche Bologna aveva perso la seconda guerra mondiale.
In ogni caso ne era uscita rossa, e la sua sterminata campagna, la Bassa, ancor di più.
Nonna Pina è stata battezzata nel 1920 nel paese di San Pietro in Casale, figlia d’un piccolo proprietario terriero reduce della Grande guerra, ed io conosco da sempre le sue storie.
Storie a lungo sussurrate al riparo di finestre chiuse, per non dare l’impressione ai vicini di voler recriminare su come si sono messe le cose a Bologna e dintorni dopo il 1945. Né ai vicini né ai figli, che tutti e sei votano a sinistra.
Sono le storie standard di una famiglia monarchica che, a re fuggito, fece l’errore di non voltare le spalle alla Repubblica Sociale di Mussolini.
Storie di ex braccianti che entrano in casa tua a piacimento, per taglieggiare e minacciare indiscriminatamente la famiglia dell’ex datore di lavoro.
Storie di esecuzioni a colpi di revolver lungo strade nebbiose di campagna, di uomini rapiti di fronte ai figli e mai più tornati a casa, di ragazzi di vent’anni trovati cadaveri nel forno del paese.
Se pure i repubblichini pagavano per vent’anni di dittatura e due inverni di occupazione militare straniera costellata di rappresaglie, nella Bassa la fine della guerra era stata seguita da uno strascico di violenze e vendette personali di cui era difficile immaginare i reali contorni, se non ascoltandone il racconto dalla viva voce delle vittime di quel regolamento di conti su larga scala che spazzò via migliaia di piccoli proprietari dalle campagne emiliane.
Nessuno parlava in pubblico di storie del genere, né dei successivi brindisi clandestini in occasione della morte di Togliatti, e neppure io facevo loro troppa pubblicità: non ero felice di sapere che la famiglia di mia madre, nel momento cruciale, si era schierata dalla parte sbagliata.
Quanto alla famiglia paterna, neppure nonno Agostino Brizzi era stato partigiano. Era del 1901, e il suo potenziale eroismo risaliva a un’epoca più remota. Dopo Caporetto, appena sedicenne, era scappato di casa col progetto di combattere gli austriaci faccia a faccia. Però nelle retrovie era stato intercettato da un gruppo di alpini laceri, reduci dalla prima linea, che l’avevano provvidenzialmente respinto: prima di rispedirlo dai genitori a San Lazzaro di Savena gli vuotarono lo zaino e si impossessarono di tutti i viveri, compresa una salsiccia su cui mio nonno doveva fare molto conto, se considerate che ne parlava ancora con rimpianto negli anni Novanta, né mostrava gratitudine per quei «ladroni con la penna sul berretto» che in fondo gli avevano salvato la vita.
Gli alpini non l’avevano lasciato partecipare per motivi d’età alla prima guerra mondiale, e la seconda l’aveva trovato già sposato e padre di famiglia, impiegato all’ufficio postale del suo paese alle porte di Bologna.
Si diceva che alla fine degli anni Quaranta avesse partecipato, pistola in pugno, alla cattura del bandito Casaroli, ma questo non cancellava il fatto che non avesse preso parte in alcun modo alla Resistenza.
Il resto era meglio immaginarlo senza parlarne troppo in giro.
Non potendo disegnare i miei antenati in camicia nera, nel ruolo dei Cattivi disegnavo l’Africacòrp di Rommel, mentre i Buoni erano quelli dell’Ottava Armata di Montgomery con il suo variopinto seguito di truppe dei dominions, gurkha nepalesi, fucilieri sikh e maori.
La superiorità di Montgomery doveva risultare chiara già dall’abbigliamento: se Rommel dirigeva i suoi appesantito da un pastrano e con una vezzosa sciarpa fuori ordinanza, l’Inglese preferiva stare leggero, con un semplice maglioncino, rinunciando all’orribile cappotto con gli alamari cui pure aveva dato il nome.
Mi impegnavo a fondo per rappresentare il momento clou della campagna d’Africa per come la immaginavo, e cioè quando Montgomery con i suoi fedelissimi accerchia Rommel, unico superstite tedesco della carneficina e, puntandogli la pistola addosso, ordina «Arrenditi, o lurida volpe del deserto».
Era un momento fondamentale, il disegno del fumetto che usciva dalla bocca di Montgomery, e per scrivere più o meno correttamente il testo dovevo ripeterlo più volte.
Magari nello sforzo del lettering mi scappavano anche degli «Ar-ren-di-ti, o lu-ri-da vol-pe» ad alta voce, e di tanto in tanto mio padre si affacciava preoccupato nell’orbita della porta dell’archivio.
«Li hai trovati, quei documenti che cercavi?» mi informavo.
«Ancora un momento di pazienza», si raccomandava aggiustando gli occhiali sul naso, segno che non era sincero. «Devo fare solo un paio di telefonate, e poi andiamo».
«Dove?»
«Da Zanichelli».
Era la mia libreria preferita. «Compriamo un libro?»
«Andiamo a sceglierne uno. Poi la prossima volta lo compriamo».
Lo diceva sorridendo. Non ci credeva neppure lui, che mi avrebbe lasciato sognare ad occhi aperti per poi condannarmi ad uscire a mani vuote, senza neppure un Mark Twain, o il suo amato Jack London «che dovresti assolutamente leggere».
«D’accordo» dicevo cercando di nascondere l’entusiasmo. «Io intanto finisco il disegno».
«Dài. E, se ci sbrighiamo, sulla strada del ritorno passiamo dalle sorelle Simili».
Quell’estrema promessa era segno che le telefonate di mio padre minacciavano di essere molto lunghe. Sarebbe servito correre, dopo, per arrivare in tempo nella bottega profumata che quelle sorelle, vere artiste di pane, crescente e grissini, gestivano in via Frassinago.
Non appena il Pater scompariva di nuovo nel suo ufficio, aggiungevo particolari alla rappresentazione, inserivo stemmi e decorazioni sulle divise, o istoriavo le guaine dei coltellacci che i gurkha portavano in cintura.
Arrivava un punto in cui sul foglio restava pochissimo spazio libero: il disegno si poteva considerare finito per limiti tecnici, e mi prendeva vaghezza di sgranchirmi le gambe. Allora, piuttosto che impegnarmi in una seconda opera monumentale, preferivo cedere alla tentazione di dare un’occhiata allo shrapnel.
Lo chiamavo così solo io, a imitazione delle Sturmtruppen, ma in realtà era l’ogiva in plastica di un lacrimogeno della Celere piovuto attraverso la grata della finestra nei giorni turbolenti del marzo ’77. Era conservato scherzosamente dentro un armadio di metallo in un angolo dell’archivio, a testimonianza di giornate in cui la zona universitaria si era trovata in stato d’assedio.
La sola idea che fosse stata sparata da un fu...