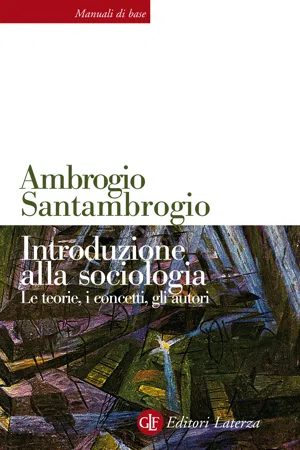Parte terza.
La modernità in questione
Premessa
La Grande Guerra segna una svolta epocale nella storia mondiale e fa da spartiacque anche per la riflessione sociologica. L’ottimismo tipico del positivismo e dell’evoluzionismo ottocentesco subisce un duro colpo. Mentre l’Ottocento è il secolo della fede nel progresso e nella scienza – la nascita della sociologia è anch’essa espressione di questa fede –, la fine della guerra lascia definitivamente intendere che a quell’ottimismo è meglio rinunciare. Agli orrori bellici seguono, infatti, le miserie del dopoguerra, che scuotono le società europee nelle loro fondamenta. Insieme alla crisi economica, che porta con sé disoccupazione e povertà, si sviluppa una più generale crisi sociale e politica dalle ripercussioni ancor più profonde e radicali. Alcuni fondatori della sociologia, come Durkheim e Weber, esprimono nelle loro teorie una profonda preoccupazione per i destini della società moderna. Essa appare ai loro occhi tutt’altro che la società positiva e perfetta che avrebbe liberato l’umanità da ataviche sofferenze e falsi miti, quanto piuttosto una struttura fragile, sottoposta a tensioni insostenibili, lacerata, divisa e intrinsecamente problematica. Il ruolo della scienza e della tecnica non è più scontato: è sempre più chiaro che la crescente razionalità del mondo delle macchine non implica che anche gli uomini usino maggiormente la ragione, e la stessa ragione non appare più come una facoltà oggettivamente definibile di cui l’uomo possa disporre liberamente e senza costrizioni.
La modernità appare ora un problema, piuttosto che una soluzione: lo sviluppo economico crea tensioni sociali imprevedibili e crisi ricorrenti; la democrazia liberale si mostra incapace di rispondere al desiderio di partecipazione dei ceti sociali emarginati; la sempre più forte spinta al cambiamento dissolve il vecchio ordine sociale e cancella tradizioni consolidate e abitudini antiche, ma lascia solo vuoto e disorientamento; le tradizionali élite sociali e politiche sono incapaci di far fronte alla situazione e appaiono nuovi capi populisti, che puntano sul risentimento e sullo sconcerto collettivi.
In questa situazione, la sociologia è costretta a fare i conti con le proprie ambizioni positiviste e progressive, sviluppando una metodologia e un atteggiamento verso la realtà molto più disincantati; inoltre, pone a se stessa un compito di comprensione, prima, e di ricostruzione, poi, della complessa e problematica articolazione che la realtà sociale sempre più rappresenta. Davanti alla complessità sociale, anche la sociologia si fa sempre più complessa e differenziata: da un lato, essa subisce un processo di specializzazione, così che si sviluppano, all’interno della disciplina, ambiti di studio e di ricerca delimitati e specifici; dall’altro, attraversa un processo di frantumazione in prospettive e modelli di ricerca tanto diversi da essere a volte tra loro in aperto contrasto. Il percorso che segue cerca di muoversi dentro questa complessità, presentando i modelli sociologici più significativi che caratterizzano l’evoluzione della sociologia nel Novecento e i loro interpreti migliori, e rimanendo così fedele all’idea che la sociologia è quello che i sociologi fanno.
1.
La Scuola di Chicago
e l’interazionismo simbolico
1.1. Introduzione
Non a caso iniziamo questo percorso della sociologia novecentesca partendo dagli Stati Uniti. La fine della guerra segna l’affermazione di questo grande paese come potenza mondiale e non può sorprendere che tutto ciò vada di pari passo con la sua crescita sul piano culturale e scientifico. Come vedremo più avanti, un sociologo americano, Talcott Parsons, riprende il grande progetto della sociologia europea, cercando di sintetizzare in un nuovo modello teorico i risultati da essa raggiunti.
Lo sviluppo della sociologia in America ha un grande impulso con la cosiddetta Scuola di Chicago, che ruota intorno al dipartimento di Sociologia e antropologia fondato a Chicago, tra gli altri, da Albion Small (1854-1926) nel 1892 e da lui diretto per più di trent’anni. Questa scuola, e il suo caratteristico approccio, influenzano fortemente la scienza sociologica americana sino agli anni Trenta del Novecento. Nel 1895, Small fonda la prima importante rivista sociologica americana, l’«American Journal of Sociology» e nel 1905 l’American Sociological Association. I principali sociologi che ruotano attorno alla scuola, oltre a Small, sono Robert Ezra Park (1864-1944), William Isaac Thomas (1863-1947) ed Ernest W. Burgess (1886-1966), anche se il pensatore più influente è George Herbert Mead, filosofo e psicologo sociale. Park introduce negli Stati Uniti la sociologia di Simmel, che ha un grande impatto su tutto il lavoro della scuola e, insieme a Burgess, pubblica alcuni importanti testi, tra cui Introduzione alla sociologia (1921) e La città (1925).
La sociologia della Scuola di Chicago è caratterizzata da alcuni elementi chiave. Sul piano teorico, essa costituisce un superamento dell’influenza che Comte e Spencer hanno sul mondo culturale americano: ora la sociologia non è più vista come la scienza del progresso umano e all’ottimismo tipico del darwinismo sociale – basato sulla fiducia in un progresso ottenuto con la selezione dei più abili – si sostituisce un atteggiamento più pragmatico e attento alla complessità e alle contraddizioni sociali. Da ciò deriva l’interesse ai problemi sociali, alla povertà, al disadattamento, alle diseguaglianze e al pluralismo delle culture, tutti aspetti che caratterizzano le grandi città americane e, naturalmente, anche Chicago, dove i processi di immigrazione dall’Europa provocano grandi speranze e altrettanto grandi delusioni. I sociologi di Chicago hanno una grande attenzione allo studio della città: proprio qui, in una delle città a più rapida crescita degli Stati Uniti, con i suoi problemi di immigrazione e di delinquenza, prende forma la sociologia urbana, sia dal punto di vista teorico che empirico. La centralità della ricerca empirica è infatti un altro elemento caratteristico della sociologia americana: i lavori più importanti sono ricerche sul campo – molte condotte con metodi qualitativi come l’osservazione partecipante, le interviste, l’analisi di documenti ecc. – che prendono in esame aspetti significativi della realtà che li circonda. Esempi concreti sono Il contadino polacco in Europa e in America (1918-21), di William I. Thomas e Florian Znaniecki, e Il vagabondo (1923), di Nels Anderson (1889-1986). Il primo libro è una ricerca sui contadini polacchi immigrati a Chicago condotta attraverso l’analisi delle loro lettere e la ricostruzione delle loro storie di vita; il secondo studia la condizione degli hobos, cioè di quei lavoratori saltuari e senza fissa dimora che caratterizzano l’America di questi anni. Secondo questi autori, infine, la sociologia deve avere uno scopo sociale: lo studio della realtà deve cioè servire a cambiarla, indicando riforme sociali concretamente percorribili e capaci di migliorare, in particolare, le condizioni di vita dei più svantaggiati.
Tali elementi si innestano sull’idea di base per cui la società è il risultato delle interazioni concrete tra individui all’interno di un contesto. Quest’ultimo non è una realtà indipendente e oggettiva, ma il risultato di un processo di costruzione sociale: la sociologia deve studiare il senso che gli uomini danno alle loro azioni e alle situazioni in cui si trovano ad agire. Come afferma Thomas, quando gli uomini definiscono una situazione come reale, essa lo diventa nelle sue conseguenze. Lo studio di Mead consente un approfondimento puntuale del concetto di interazione.
1.2. Mead e il concetto di interazione
1.2.1. La biografia e le opere
George Herbert Mead nasce a South Hadley, nel Massachusetts, nel 1863 e muore a Chicago nel 1931. Egli studia all’Oberlin College, dove suo padre, pastore puritano, insegnava omelia. Questo College, fondato nel 1833, era dominato da idee progressiste – fu tra i primi ad accettare i neri e a concedere alle donne il baccalaureato – che lo influenzarono profondamente. In seguito, dopo alcuni anni in cui lavora alla costruzione della ferrovia, Mead si iscrive a Harvard, dove si libera dal puritanesimo di Oberlin e, influenzato da William James (1842-1910), si «converte» alla filosofia pragmatista, la corrente filosofica americana dominante, che ha, oltre a James, in Charles S. Peirce (1839-1914) e John Dewey (1859-1952) i suoi esponenti principali. Dal 1888 al 1891 si reca in Germania, prima a Lipsia, dove studia con Wilhelm Wundt (1832-1920), un pioniere della psicologia sperimentale, la cui teoria del gesto ha un profondo impatto su di lui, e poi a Berlino, dove studia con Dilthey. Mead interpreta il pensiero di quest’ultimo – secondo il quale, come sappiamo, le scienze della società debbono avere un loro proprio metodo, diverso da quello delle scienze della natura – in una direzione del tutto specifica: per studiare il soggetto, occorre partire non dall’interno, dall’introspezione, ma dal contesto sociale in cui è collocato. Tornato in America, insegna per due anni all’Università del Michigan, dove stringe amicizia con John Dewey, e tre anni dopo insieme a lui si sposta nel Dipartimento di Filosofia di Chicago. Qui entra in sintonia con l’approccio della scuola sociologica: per Mead, infatti, gli stati mentali sono visti come fasi di un’azione diretta a un fine all’interno di un contesto sociale e non come qualcosa di indipendente dal contesto. Mentre l’amico Dewey fu uno scrittore prolifico e di grande successo, Mead fu un ottimo insegnante, ma scrisse pochissimo: non pubblicò mai un libro compiuto, ma solo articoli, il primo dei quali a quarant’anni. Tre anni dopo la morte, il suo allievo Charles W. Morris (1901-1979) pubblica una raccolta di appunti di Mead nella forma di libro con il titolo Mente, sé e società dal punto di vista di uno psicologo comportamentista. Questo testo costituisce il punto di riferimento fondamentale del pensiero di Mead. Anche se l’espressione «interazionismo simbolico» fu coniata dal sociologo americano Herbert Blumer (1900-1987) nel 1937, le idee principali di questo approccio sono tutte presenti nell’opera di Mead.
1.2.2. Il metodo
Mead è influenzato da John B. Watson (1878-1958), uno degli esponenti più noti della psicologia comportamentista, ma è un comportamentista piuttosto atipico. I termini del problema possono essere così riassunti: esiste la coscienza umana? E se sì, come la si può definire e studiare? Un approccio scientifico deve ovviamente abbandonare il riferimento all’anima, a un’entità che caratterizzi l’individuo sin dalla nascita. Una possibilità può essere offerta dall’introspezione, una forma di autoconoscenza tutta interna, una specie di viaggio interiore alla scoperta di se stessi. Il comportamentismo rifiuta anche questa via, perché i suoi passi non possono essere osservati: l’introspezione è un’avventura individuale nella soggettività. Partendo dallo studio degli animali – dove l’introspezione è impossibile –, per il comportamentismo oggetto di studio diventa allora la condotta esterna, la sola passibile di osservazione sperimentale, l’unico metodo capace di produrre una conoscenza obiettiva e scientifica. Cosa resta a questo punto delle esperienze interiori e soggettive? Per Frederik B. Skinner (1904-1990), il comportamentista più radicale, nulla: dal momento che esse non sono osservabili, tutto ciò che posso sapere della coscienza è ciò che appare attraverso gli atti esterni. Da qui la battuta per cui un comportamentista skinneriano quando incontra un amico gli chiede: «Oggi ti vedo allegro. E io come sono?». Per Watson, che non ha una posizione così radicale, il nostro pensiero, in quanto assume una forma linguistica, può essere ricondotto alla stessa logica del comportamento esterno. Il pensiero è un’esperienza interiore, ma può essere interpretato come una nostra osservazione su noi stessi, quindi pur sempre un’osservazione. Per Watson, la condotta è tale in quanto può essere osservata, e il pensiero è una «condotta» che può essere osservata solo da noi stessi: non c’è una differenza qualitativa tra agire e pensare, ma solo di accessibilità.
Mead critica questa impostazione: «osservare» il pensiero significa pur sempre pensare. Il pensiero cioè non può essere oggetto di se stesso. Bisogna allora chiarire bene il senso in cui la coscienza si costituisce, nella sua riflessività, facendosi oggetto di se stessa. Per prima cosa, se è vero che la psicologia non può essere coscienzialista, non può neppure evitare l’uso dell’introspezione. L’atto esterno che osserviamo è qualcosa che ha avuto inizio nell’interno: «una parte dell’atto risiede nell’organismo e solo in un secondo momento giunge all’espressione; questo è il lato del comportamento che, secondo me, Watson ha trascurato» (Mead 1966, p. 37). Non bisogna essere quindi né solo introspezionisti né solo comportamentisti: in entrambi i casi l’approccio sarebbe riduttivo. In secondo luogo, occorre sviluppare il comportamentismo in una direzione più matura e completa, portandolo allo studio della dimensione sociale: la comunicazione, il linguaggio, il mondo dei segni significativi acquistano un senso completo non nella semplice introspezione e neppure nell’osservazione in laboratorio, ma «nel più ampio contesto di cooperazione del gruppo [...]. Il significato appare all’interno di quel processo. Il nostro comportamentismo è un comportamentismo sociale» (ibid., corsivo mio).
Perciò la psicologia sociale studia il comportamento individuale in quanto parte di un contesto sociale e attraverso questa via trova una soluzione ai problemi della psicologia: «noi cerchiamo di spiegare la condotta dell’individuo nei termini della condotta organizzata del gruppo sociale [...]. Per la psicologia sociale, l’insieme (cioè la società) precede la parte (cioè l’individuo)» (ivi, p. 38). La psicologia è quindi comportamentista perché studia azioni osservabili, ma senza ignorare l’esperienza interna dell’individuo: «al contrario, essa si occupa del sorgere di questa ...