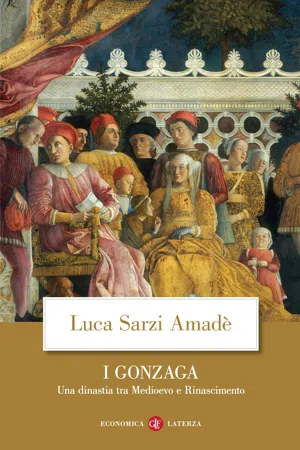IV.
Ritratto di famiglia nel Rinascimento
Il più rivoluzionario dei maestri
Il personaggio focale nell’epopea dei Gonzaga è Ludovico II. Egli però non sarebbe stato nessuno senza il suo maestro, Vittorino dei Rambaldoni. È ancora medioevo quando in Val Padana si affaccia – da Feltre, città alta sul Piave, e patria allora di figli eletti – questa figura di educatore mai vista prima di allora, di vero umanista che aborriva i castighi corporali e le discriminazioni, e che propugnava, a dispetto della scolastica imperante, il dialogo tra le varie discipline: finalmente l’Italia delle accanite dispute teologiche conosceva un innovatore che ammaestrava gli alunni mediante il gioco, l’allenamento fisico e mentale, in specie della memoria (grazie alle tecniche degli antichi), sui testi greci e latini, attraverso la compartecipazione, paritaria, di tutti, maschi e femmine, addirittura di nobili e plebei, adulti e bambini, schivando le pedanterie della grammatica. La presenza del montanaro non suscitava stupore tra noi perché la chiesa di Feltre dipendeva, come quella di Mantova, dal patriarca di Aquileia (anche il nome Feltrino, avrete notato, non è estraneo alla Casata).
La scena si sposta così accanto alla reggia dei Gonzaga, nella Casa Gioiosa (o Giocosa), che il penultimo capitano, il magnifico Francesco, aveva eretto per i propri svaghi, forse un poco paganeggianti, e che il pedagogo aveva convertito nella scuola più equa di tutti i tempi, un ginnasio dove, accanto allo studio libresco, si praticassero, come nell’antica Atene, il disegno, la musica, e non ultima quella che noi ancora oggi chiamiamo appunto “ginnastica”, affinché gli allievi fossero forgiati nel corpo e nella mente. E forse proprio perché in greco scholá vuol dir “tempo libero”, alle pareti erano affrescati innocenti giochi di fanciulli.
Qui, sotto i pergolati del giardino, educò, con l’intera prole del primo marchese, anche la nuora, Barbara di Brandeburgo, approdata a corte undicenne, e al tempo stesso la progenie di altri grandi signori – padani come ad esempio i conti di Correggio, e panitaliani quali invece quelli di Montefeltro –; e così pure i figli del suo maestro di greco, Guarino da Verona (il quale, pressoché suo coetaneo, aprì poi una scuola gemella in Ferrara, sotto l’egida estense), e persino fanciulli d’ogni ceto, accollandosene, quando necessario, le spese del vitto, eguagliandoli nell’abito e nel trattamento, sempre assecondandone però le differenti naturali inclinazioni.
Era una rivoluzione. Ad esempio, non si erano mai viste, nell’Italia ancora gotica, le donne parificate agli uomini. Proprio Cecilia, una donna, una figlia di Gianfrancesco, assimilò con tale rapidità, oltre al latino, il greco che all’età di otto anni lasciò interdetto il padre generale dei Camaldolesi, il dolcissimo Ambrogio dei Traversari, uno dei più alti ellenisti e uomini di Chiesa del suo tempo, anche lui montanaro, ma romagnolo, anche lui promotore dell’umanesimo femminile (ma soltanto nella quiete monastica). Lo stupore era giustificato, anche perché, a differenza delle sorelle (Lucia e Leonella, entrambe gobbe, predestinate dunque al chiostro), Cecilia era, oltre che intelligente e versata, visibilmente bella. Pisanello la ritrae ventunenne, unica donna, nella sua più celebre medaglia, coniata nel 1447 (e forse anche nella graziosa tavola oggi al Louvre).
L’ultimo capitano, ansioso di fare più grande la Dinastia, promise la sua migliore creatura a un pronipote del defunto papa Colonna, il bellissimo ma cinico Oddantonio di Montefeltro, che sarà poi, ancora imberbe, il primo duca di Urbino, terra strategica tra la Val Padana e Roma, tra l’Italia imperiale e lo Stato della Chiesa (il legame con i Montefeltro è presto spiegato, sia perché i conti erano intrecciati con i Malatesta, sia perché in questa casata era entrata Teodora, la coltissima Thora da Gonzaga, la figlia del nostro mitico Ugolino). Ma la più bella della Famiglia ambiva al chiostro, alla meditazione, al sapere. Insomma, sotto il fiero campanile matildico volarono stracci: da una parte il Socrate Cristiano, fermo nel difendere la libera scelta dell’alunna, fino a ventilare la punizione divina; dall’altra il marchese irremovibile. Un vero maestro non si fa comandare. Anche un condottiero però non si piega certo facilmente; e solo nel 1444, all’atto del testamento, il primo marchese assentì all’ingresso della figlia nel monastero (Santa Paola, lo stesso, fondato dalla moglie, dov’erano relegate le altre due), mentre lo sposo designato perdeva la vita diciassettenne in una congiura (e nello scempio del cadavere anche gli attributi virili). La bionda devota se la caverà un po’ meglio: morrà appena maggiorenne, ma, come l’anziana madre, in odore di beatitudine.
Finalmente, in un’Italia patriarcale, si vedeva un grammatico schierato dalla parte dei giovani! Il saggio montanaro, che presto aveva imparato ad apprezzare la sobrietà, li guidava al piacere di pensare e di comporre in latino; e a dispetto della consuetudine che, specie nelle corti, vedeva, nell’abbondanza dei cibi e nella pinguedine, un indice di prosperità, esortava gli alunni a mangiare poco e a bere molta acqua. E non fece eccezione con i giovani Gonzaga. Talvolta, per distogliere il suo piccolo Ercole dalla tavola (come egli chiamava l’undicenne Ludovico), lo induceva, al suono dei musici e dei cantori, a seguire gli artisti nei movimenti della danza, lontano dal desco ancora imbandito, aggirandone con finezza gli spigoli del carattere. Egli seppe così fare del principe ereditario, curvo e pingue, un provetto ginnasta, un politico saggio, un mecenate lungimirante. Sarà poi l’allievo che a sua volta farà della propria la corte forse più completa d’Italia.
E siccome, durante l’impero di Traiano, che fu il più vasto che Roma avesse conosciuto, Giovenale, il poeta satirico forse più sincero di tutti i tempi, propugnava una mens sana in corpore sano, egli raccomandava a sua volta agli allievi belle gite sui fiumi e sui laghi, dove immergersi per temperare l’arsura dell’estate, lunghe camminate sui monti, gagliarde corse nei boschi, e inoltre la pratica della scherma, del tiro con l’arco. Si tramanda che nel corso di una vogata – che i discepoli avevano affrontato ormai sotto la propria, autonoma responsabilità – forse nelle acque del Benaco (come il Poeta chiamava il nostro Garda), forse alla volta di Piétole, dove un tumulo ricordava la casa di Virgilio, uno di loro stentò a riemergere. Si chiamava, per ironia della sorte, Francesco Prendilacqua, e sarà lo stesso che, eroicamente salvato dai compagni, un giorno scriverà in latino la biografia del docente.
Vittorino attuò insomma la sua missione, di conciliare il sapere dei classici con la matematica (che lui aveva appreso da solo, sui testi di Euclide), e al contempo con lo spirito cristiano, e di creare uomini compiuti che, senza ambire al guadagno, dessero poi nella vita il meglio di sé a beneficio della collettività. Per questo motivo la sua scuola impiegava anche mani esperte nell’indispensabile copiatura, miniatura e legatura dei codici (arti praticate con enfasi a Firenze, nel monastero degli Angeli, guidato con sapienza dal Traversari, e frequentato con assiduità dai Medici). Ai contemporanei la Casa Giocosa parve così rinnovare l’accademia di Platone. Essa plasmò numerosi maestri, tra i quali Antonio Beccaria da Verona – il grecista che diffuse in latino, la lingua allora universale, la letteratura greca e la toscana nell’Inghilterra di Enrico V, il re mecenate forse imparentato con la Dinastia – e Bartolomeo Sacchi, da Piàdena, ampia terra a mezza via tra Cremona e Mantova (e che i Gonzaga, ricorderete, avevano perduto), e per questo motivo noto con il nome di Plàtina, il quale, venuto il suo turno, condurrà l’educazione dei figli del nostro Ludovico, prima che, molto tempo dopo, Sisto IV, un papa che sarà benigno alla Casata, lo chiami a forgiare la nascente Biblioteca Vaticana, allora la più grande del mondo.
Qui, sulle rive del Mincio, si formò nel cuore e nella mente, tra i più celebri capitani di ventura, anche il fratellastro (o il nipote segreto fatto passare per tale) di Oddantonio da Montefeltro, Federico, che certo ne fu il successore e, non se ne dubita, anche il carnefice (parliamo del personaggio immortalato nel celebre profilo da Piero della Francesca), il quale, armato cavaliere proprio a Mantova, sarà poi l’irriducibile antagonista del confinante, violento e geniale Sigismondo Pandolfo Malatesta (uno dei tre figli naturali di uno zio dei Gonzaga, il solito Pandolfo III il Grande); sarà ancora lui che nella sua Urbino creerà, quasi dal nulla, quella che proprio un cortigiano, e tra i più diletti, dei Gonzaga, il Castiglione, nel secolo successivo definirà “la più bella corte d’Italia”.
I fratelli rivali
Abbiamo visto che casa Gonzaga non fu immune dal salto generazionale, né dalla rivalità tra fratelli (non lo furono del resto gli Dei dell’Olimpo). Ludovico, ricorderete, si era sposato a ventun anni, nel 1433, con una fanciulla di undici, e come logico stentava ad avere figli. Il primo marchese però, come ben capirete, voleva al più presto un nipote; e nel 1437 ottenne a Carlo, il secondogenito, la debita sposa, Lucia, una delle due splendide gemelle di casa d’Este (l’altra invece toccò, manco a farlo apposta, proprio al succitato Sigismondo Pandolfo Malatesta: ne vedremo delle belle).
La scena è di nuovo quella di una commedia: Ludovico, primogenito, erede designato, ma improle, e Carlo, l’indomito, eroico condottiero che, sulla scia degli avi, brama rinnovare la gloria dei capitani dell’antica Roma. Del resto le condotte militari, non più semestrali, ma generalmente annuali, ora offrono un impiego più stabile (il che impedisce ai soldati di trovarsi senza paga nei mesi freddi, e dunque di dedicarsi a scorrerie a danno dei contadini, che poi, nella stagione delle battaglie, che è anche la stessa del raccolto, è bene avere invece dalla propria).
Insomma, l’inevitabile accadde: un giorno, a ventiquattro anni (1436), il maggiore dei due fratelli, avvilito dal primato dell’altro, fuggì a Milano a cercare l’agognata fama nelle schiere di Filippo Maria Visconti (ricordate? il nemico di Venezia, nelle cui file il babbo militava come capitano generale!): ottenne così di servire per un anno, per ora con le sue trecento lance a cavallo, a patto di non combattere contro il genitore, e secondo l’uso, di tenersi disponibile per un eguale periodo a rinnovare il contratto (il cosiddetto anno di rispetto è ormai una clausola di rito, imperativa ovunque).
Potete immaginarvi, in una famiglia di condottieri, l’ira del padre!
Il primo marchese della Casata, fiero del titolo appena guadagnato, esiliò il primogenito dai suoi dominii, comminò la morte a chiunque gli rivolgesse la parola, e ottenne dall’imperatore, in deroga all’investitura in corso, perfino la facoltà di diseredare il rampollo. Quindi, non pago, per cancellarne ogni traccia dalla patria, ne fece distruggere le insegne, e impose ai sudditi che si chiamavano Ludovico di mutare il nome in quello di Luigi. In quanto poi alla moglie del giovane (sebbene fosse la nipote del più alto monarca), dispose che d’ora in poi seguisse, anziché precedere, in pubblico, la consorte del secondogenito, appena entrata in famiglia, manifestando in questo modo la volontà di riservare a Carlo, e solamente a questi, la successione.
In un simile bailamme, l’unica forse in grado di placare le acque era la madre, religiosissima, e con lei l’ormai calvo don Vittorino. Celebri, in quell’occasione, le parole pronunciate dal Maestro: “Il figlio ha peccato contro il padre, ma il padre non deve peccare contro il figlio”.
Si vuole che intervenisse la mano di Dio: a pochi mesi dalle nozze, proprio Carlo, il prediletto, perse la bionda e graziosa moglie (la gemella sarà più fortunata, e sparirà solo tre anni dopo, si dice – ma non si sa il vero – per mano del marito). Ma forse a decidere fu solo la dinamica delle alleanze. Abbiamo già veduto come, sotto il cielo di san Marco, l’ultimo capitano cedesse anche lui, ormai stanco della politica, alle lusinghe dei Visconti, e nel 1438 lasciasse il doge per l’unico, vero duca della Val Padana, il deforme e sleale Filippo Maria. In quell’occasione fu finalmente chiaro a tutti che, in fin dei conti, quel birbante di Ludovico era stato solo un anticipatore. Oltretutto, pochi anni dopo, in capo a più di sette di matrimonio, questi diede ai genitori anche il sospirato erede, precedendo, questa volta, il fratello minore. Di più: nel corso dell’esilio il giovanotto, per non essere da meno di Carlo (che abbiamo ammirato all’impresa di Verona) aveva dato ampia prova di sé sotto un generale folle come il Piccinino, guadagnando, sulle colline lucchesi, le cui miniere erano tesoro dei fiorentini, le ferite e – pure lui, come il fratello – la prigionia, ma anche le carezze del vincitore, Francesco Sforza, disperatamente assoldato da Cosimo, il fondatore di casa Medici. E così anche il padre sbollì la collera, e alla fine il baldanzoso primogenito fu reintegrato alla grande nella successione.
D’altronde perché mai tanta ritrosia a servire i signori di Milano? Ricordiamo che un altro figlio dei Gonzaga, Gianlucido, un ventenne che collezionava monete romane, studiava a Pavia, nell’università che proprio i Visconti avevano fondato e avevano fatto grande e celebre. Ma, gobbo e malaticcio, non conosceva altri orizzonti che il sacerdozio. E dopo la morte di Vittorino (la quale seguì nel 1446, allo spirare dell’inverno) prese stanza proprio nella Casa Giocosa (dove, ai tempi del suo alunnato, il giovane aveva mandato a mente l’intera Eneide in latino), un paio d’anni prima di morire, all’inizio del 1448, ventiseienne, nel castello della sua piatta, grama Ceresara.
Ricomincia così la saga di Ludovico, anzi di Ludovico II. Come abbiamo veduto, anche lui è, a tutti gli effetti, un capitano di ventura. E che condottiero! Prima accetta la condotta settennale del duca di Milano, poi, travolto questi dai veneziani presso Casalmaggiore (proprio sulle rive del Po, che qui fa il suo ingresso nei domini gonzagheschi), passa dalla parte delle Repubbliche – Venezia e Firenze –, e a trentaquattro anni, sul far del 1447, è già alla testa, con lo stipendio di 600 fiorini al mese, di un esercito orgoglioso come quello fiorentino, da lui combattuto in gioventù, e con l’ambizione ora di renderlo eguale a quelli, ormai veramente grandi, di Milano e di Venezia. E forse proprio la sua intraprendenza, la sua prontezza sul campo (più che la barba da ribelle cresciutagli incolta dopo la fuga da casa) gli giovano la nomea di Turco, che a noi evoca la razza di cavalli da lui prediletta perché giudicata la più strepitosa in battaglia. Pisanello lo raffigura come capo degli armigeri in una sua celebre medaglia.
Il 1447 però, ad onta di tante acrobazie per mantenere unita almeno la famiglia, vede di nuovo i fratelli Gonzaga divisi: Ludovico con i veneziani, Carlo con gli aragonesi che quell’estate rivendicano al re di Napoli la corona di Milano, dove il duca, ultimo dei Visconti, è appena morto (e senza figli maschi: un’occasione d’oro per parenti e amici!). Un insuccesso: Milano, dopo centosettant’anni di vipera gentile, ha proclamato anch’essa, su modello di Stati allora in ascesa, la sua brava repubblica, e – grazie alle armi di Francesco Sforza, assoldato in fretta e furia con un ricco stipendio – si difende a dovere. Repubblica agognata, ma fragile (imploderà dopo appena tre anni di confusione, complice – al solito – la fame, nel 1450).
In questo periodo Carlo combatte sotto lo Sforza, per i milanesi, alla testa di millecinquecento cavalli (eguagliando nel numero il marchese del Monferrato, un collaterale della casa imperiale bizantina!); Ludovico invece – manco a farlo apposta – con i veneziani. Quest’ultimo già assapora la rivincita sul fratellino quando, nell’estate del 1448, soltanto un anno dopo l’uscita di scena di Filippo Mari...