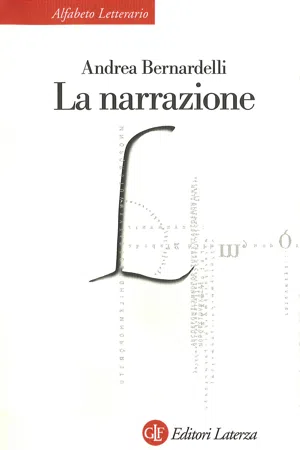1. Elementi per una definizione
‘In principio...’
Per avere una narrazione è sufficiente che ci sia un narratore, una storia e qualcuno a cui raccontarla. In sintesi, si può dire che narrare sia un’attività necessaria all’uomo per comunicare ad altri uomini la conoscenza di eventi, cose e persone. Un narratore infatti, disponendo in un determinato ordine informazioni a lui solo note, può rendere partecipi della propria personale esperienza anche altri individui. La narrazione è dunque genericamente uno degli strumenti utili alla compartecipazione dell’esperienza dei singoli con una più ampia comunità. Mediante la narrazione si viene così a costituire una parte rilevante di quel patrimonio di memorie e di esperienze che definiscono un’intera tradizione culturale.
Dovendo affrontare il problema di definire il concetto di narrazione, la prima questione che si pone in evidenza è quella delle sue differenti forme o modalità di espressione. La comune esperienza ci insegna che una delle principali forme della narrazione – in cui siamo quotidianamente coinvolti – è quella che viene definita come verbale o orale. In ogni nostro dialogo viviamo infatti la diretta esperienza della narrazione sotto forma di una costruzione linguistica, vale a dire come una comunicazione compiuta utilizzando i suoni del linguaggio articolato.
Il Vangelo di Giovanni, ad esempio, ci ricorda che «In principio era la Parola», e la parola è stato proprio il primo e il più antico strumento della narrazione. Il mito, la leggenda e il racconto popolare, ma anche l’epica e la fiaba, sono tutte forme di narrazione la cui esistenza e la cui struttura è determinata dal fatto di essere state trasmesse secondo una modalità di comunicazione orale. Nelle culture arcaiche, infatti, il modo corrente di trasmettere racconti, informazioni e conoscenze era quello della narrazione mediante la parola. Essendo allora ignota o scarsamente utilizzata la scrittura, la conservazione delle informazioni essenziali per l’istruzione delle nuove generazioni – la memoria storica di una cultura o di una società – era legata alla continua ripetizione di una serie di racconti che divenivano in tal modo tradizionali. Il narratore orale doveva essere necessariamente in grado di ripetere, nei limiti concessi dalla propria memoria, il testo del racconto, cercando di preservarne l’integrità e mantenendone la coerenza con la tradizione.
Il mito in particolare sembra incarnare l’essenza di questa modalità di conservazione e trasmissione del sapere. I racconti delle gesta e delle imprese di dèi e di eroi narrati dagli anziani del villaggio o da narratori itineranti specializzati sono, ancora oggi in alcune culture dette «primitive», il veicolo di una serie di istruzioni fondamentali per la vita del singolo, sia in rapporto al mondo naturale che lo circonda, sia in relazione ai suoi simili con cui deve convivere.
Il ruolo dei cantori, cantastorie o aedi – così come venivano denominati i narratori orali nell’antichità – risulta essere in tal modo essenziale alla sopravvivenza di una cultura. Non essendo possibile conservare le proprie conoscenze su di un supporto fisso e duraturo come quello garantito dall’uso esteso della scrittura, solo la continua ripetizione dei racconti può permettere la sopravvivenza dell’«enciclopedia» di una cultura. Da questo fatto deriva anche l’importanza e il valore attribuito alle funzioni e alla figura stessa del cantore nelle società in cui l’oralità sia la forma prevalente di comunicazione. In questo modo, ad esempio, carico di rispetto e di attese, Ulisse nell’Odissea si rivolge al cantore Demòdoco invitandolo a continuare il racconto dell’assedio di Troia:
Demòdoco, io t’onoro al di sopra di tutti i mortali.
Certo Apollo o la Musa, figlia di Zeus, t’istruirono,
perché troppo bene cantasti la sorte degli Achei,
quanto subirono e fecero, quanto penarono gli Achei,
come se fossi stato presente o te l’avesse narrato qualcuno.
Continua, dunque, e lo stratagemma del cavallo raccontaci,
del cavallo di legno, che Epèo fabbricò con Atena,
l’insidia che sull’acropoli portò Odisseo luminoso,
riempita d’eroi, che distrussero Ilio.
Se questo pure saprai perfettamente narrarmi,
certo dirò fra gli uomini tutti,
che un nume benigno t’ha dato il canto divino.
Con l’estendersi dell’uso della scrittura come strumento di comunicazione e di conservazione del sapere tradizionale, si è stabilito anche un sempre più stretto legame tra le forme della narrazione e il concetto di letteratura. La letteratura è per definizione una forma di comunicazione scritta, in quanto composta di caratteri o lettere, ma alla sua origine si trova un lento e spesso oscuro processo di assorbimento di precedenti tradizioni orali. Esistono così delle forme di narrazione scritta che mantengono ancora alcune caratteristiche tipiche delle forme espressive orali da cui sono derivate. La fiaba, l’epica, ma in buona parte anche la tradizione teatrale, possono ancora oggi essere ritenute forme miste di narrazione, che portano con sé caratteristiche della loro originaria oralità.
La forma narrativa letteraria oggi dominante è certamente quella incarnata dal romanzo. Ma al genere romanzo così come noi lo conosciamo si è comunque giunti attraverso un lungo percorso che, dalle forme ancora prossime all’oralità della novella tardo medievale e del poema cavalleresco rinascimentale, fino al genere più prettamente «letterario» del romanzo epistolare settecentesco, ha portato alla narrazione romanzesca.
Un po’ di spazio andrebbe anche riservato a quelle forme di narrazione che si possono genericamente definire «per immagini». Dalle primitive incisioni rupestri fino alle più complesse forme delle arti figurative di età medievale e moderna, le immagini hanno infatti svolto un fondamentale ruolo di supporto alla narrazione. Nel Medioevo ad esempio – in un’epoca in cui l’alfabetizzazione era ancora scarsa – i predicatori, come ausilio alla comprensione e al ricordo dei racconti biblici, usavano indicare agli uditori le immagini e le statue di cui erano ornati i portali e le facciate delle chiese. Ma le arti figurative non si sono sempre limitate a svolgere la funzione di semplice supporto alla narrazione sotto la forma ausiliare di una «immagine di memoria» o di una illustrazione. Molte opere figurative infatti, nella loro apparente fissità, «raccontano» una storia. Spesso, attraverso la ricchezza dei particolari e dei riferimenti ad altri testi figurativi e non (intertestualità), alcune opere figurative portano a una vera e propria esperienza di «lettura» delle immagini proposte, che in tal modo vengono caricate dello spessore temporale necessario allo svilupparsi di una narrazione. Nel mondo contemporaneo una delle principali forme del «racconto per immagini» è il popolare fumetto – composto da una commistione di scrittura e di immagini –, ma anche i più complessi media elettrico-elettronici – cinema, televisione e «Internet» – offrono un ottimo esempio di come la narrazione possa essere veicolata anche dall’unione della parola e delle moderne immagini «in movimento».
Si può così provvisoriamente definire la narrazione come ogni forma testuale di racconto – orale, scritta o visiva (che raccoglie pittura, fotografia, cinema e televisione) – attraverso cui qualcuno ci narra una storia.
Storia, racconto e narrazione
In queste prime pagine abbiamo impiegato con una certa disinvoltura e indifferenza i termini racconto, storia e narrazione, come se si trattasse di sinonimi, o comunque di espressioni la cui reciproca definizione non ponesse alcun problema. Gérard Genette (n. 1930) ha cercato di mettere un poco d’ordine nella terminologia della teoria letteraria o narratologia, intesa come lo studio teorico delle forme del racconto. Genette muove dall’ambiguità implicita nell’uso corrente del termine racconto, distinguendone almeno tre principali accezioni di senso:
1) mediante il termine racconto si indica in primo luogo l’enunciato narrativo, il discorso orale o scritto che riporta la relazione di un avvenimento, o di una serie di avvenimenti. Si tratta del singolo e concreto prodotto di un atto di enunciazione;
2) in secondo luogo per racconto si intende la sequenza di avvenimenti, reali o fittizi, che costituiscono l’oggetto del discorso, così come le diverse relazioni di concatenamento, opposizione e ripetizione tra gli eventi riportati;
3) la terza accezione del termine racconto indica la concreta situazione in cui qualcuno racconta qualcosa, l’atto di narrare in se stesso. Si tratta del racconto inteso come atto di enunciazione.
La narratologia, secondo Genette, deve occuparsi in particolar modo della prima accezione della nozione di racconto, quella relativa al suo aspetto di discorso o di testo narrativo. Ma in tale studio si presuppone sempre e in ogni caso il costante riferimento agli altri due aspetti del racconto, quello che lo vede come un atto enunciazionale e quello che lo intende come un’astratta sequenza di eventi. Così Genette propone una diversa scelta terminologica utile a conservare distinte le tre accezioni, nonostante la loro continua interrelazione:
1) con racconto si indicherà ora il solo aspetto di superficie, il significante, l’enunciato, il discorso o testo narrativo in sé considerato;
2) mediante il termine storia si indicherà il significato o contenuto narrativo, l’oggetto del racconto costituito dalla successione degli avvenimenti riportati;
3) e, infine, con il termine narrazione si indicherà l’atto narrativo produttore e l’insieme della situazione reale o fittizia in cui esso viene collocato.
Evidentemente uno studio del racconto non può fare a meno di tenere conto di un’analisi della storia da esso veicolata, così come dei tratti o elementi della narrazione – del suo contesto e della sua dinamica – che vengono rispecchiati o riportati nel discorso. Il primo dei tre aspetti identificati che si impone all’attenzione del fruitore di un «racconto» è infatti il solo discorso narrativo, la catena degli enunciati che ne costituiscono la superficie significante. Solo in un secondo tempo sarà possibile identificare e mettere in evidenza gli altri due piani costitutivi del racconto: da un lato l’ossatura degli eventi narrati, dall’altro le tracce – reali o fittizie che siano – del suo atto di produzione.
Due parole andrebbero spese riguardo al concetto di storia. Gli avvenimenti riportati in un racconto possono infatti appartenere a due ben distinte categorie: si può trattare di eventi reali o storicamente documentati, oppure di avvenimenti e azioni che siano il frutto della fantasia o della creatività del singolo autore. In questo modo si sono delineate diverse forme di classificazione del racconto fondate sul differente statuto – reale o di finzione – degli eventi narrati. Sul versante della realtà si collocano abitualmente tutti i racconti attribuibili alla cronaca («i fatti del giorno») e alla storia (intesa come scrittura professionale degli eventi storici o storiografia). Sull’altro versante, quello della finzione, si collocano tutti i generi di discorso definiti letterari, dalla poesia al romanzo. In realtà la situazione è molto meno chiaramente delineata e, più che una contrapposizione tra due territori, il rapporto tra reale e finzionale sembra disegnare un arco continuo di generi e tipologie di racconto. Un tipico esempio di commistione tra realtà e finzione è dato dal romanzo storico, un genere letterario in cui personaggi di finzione «vivono» sullo sfondo di una realtà storicamente documentata. D’altronde anche quel particolare genere di racconto identificabile nelle biografie di personalità storiche non si può negare che sia fortemente intriso di finzione e di «letterarietà». Ma ogni personaggio, storico o di finzione che sia, una volta intrappolato in un racconto deve vivere la realtà «limitata» di quel mondo di carta e di parole.
La creazione di ‘mondi’
Ogni narratore, quando dà inizio a un nuovo racconto, è investito del difficile compito di creare un mondo narrativo. Come si dice abitualmente, egli deve «ambientare» il racconto. La storia di un racconto è infatti principalmente composta da personaggi, oggetti ed eventi. Ma questi elementi resterebbero di per sé slegati e sconnessi se non venissero di volta in volta collocati all’interno di ben definite coordinate spaziali e temporali. Se un personaggio infatti si muove o agisce è necessario che sia stato descritto, anche se in termini minimali, uno spazio in cui possa compiere i propri spostamenti e azioni. Allo stesso modo l’azione del personaggio dovrà essere stata collocata temporalmente per poterne definire la posizione e la relazione rispetto alle azioni di altri personaggi o ad altri eventi descritti.
Ogni narrazione si apre quindi con la determinazione degli assi spaziali e temporali secondo cui scorrerà il racconto. In questo modo, ad esempio, Victor Hugo (1802-1885) delimita lo spazio e il tempo del proprio racconto nel romanzo Notre-Dame de Paris (1831):
Son oggi trecentoquarantotto anni sei mesi e diciannove giorni dal dì che i parigini si svegliarono al frastuono di tutte le campane suonanti a distesa nella triplice cinta della Cité, dell’Université e della città intera.
Tuttavia, il 6 gennaio 1482 non fu un di quei giorni che la storia ricorda. Niente di memorabile nell’avvenimento che scuoteva così, fin dal mattino, le campane e i borghesi di Parigi.
In queste poche righe veniamo a sapere l’esatta collocazione geografica degli eventi narrati e la precisa determinazione del momento in cui hanno inizio. L’autore, quasi a volere rimarcare l’autenticità e la storicità di quanto riportato, ricollega la temporalità d...