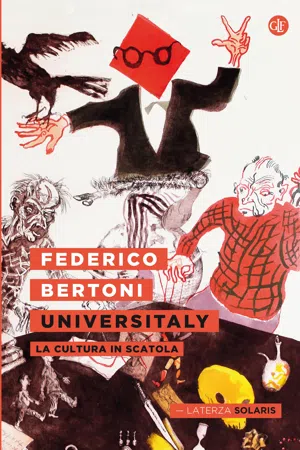1.
Esperienza
1. La giornata di un professore
Non amo affatto Michel Houellebecq, mi irrita da morire. Segno forse che è un vero scrittore, perché lo scopo primario della sua scrittura sembra proprio quello di irritare il lettore (e ancor più la lettrice). Ma c’è un dettaglio che mi ha colpito molto in Sottomissione, a parte gli astuti e tendenziosi richiami alla situazione che sta sgretolando il nostro (?) mondo. Qualunque cosa accada, nota a più riprese Houellebecq, l’Amministrazione non ti lascia in pace: ti bracca, ti raggiunge ovunque. Può esserci il panico, la rivoluzione, la guerra civile o lo stato di emergenza, ma a un certo punto torni a casa e trovi una bolletta delle tasse o una multa non pagata. Mi viene anche in mente, su un registro molto diverso, un capitolo esilarante del Pensatore solitario di Ermanno Cavazzoni, in cui si descrivono le peripezie di un ipotetico eremita dei nostri giorni, che prima di potersi dare a una vita di sacrosanta solitudine e ascetiche meditazioni nel deserto dovrebbe fare i conti con Equitalia, il commercialista, la tassa dei rifiuti, l’avvocato dell’ex moglie e via dicendo.
Figurarsi uno come me, che non pensa (più) a fare il rivoluzionario o l’eremita ma che ha un posto ben integrato nel sistema universitario del nostro Paese, e che vorrebbe solo fare il lavoro per cui viene pagato con denaro pubblico, cioè studiare e insegnare nel migliore dei modi, pretese ormai velleitarie e antisociali in un mondo che regolamenta anche il dissenso e che cerca di parametrare ogni singola azione. Mai come in questi casi, del resto, si avverte uno scarto più grottesco tra le parole e le cose, tra procedimenti di definizione e controllo sempre più formalizzati (che poi finiscono nei grafici e nelle percentuali, e soprattutto negli articoli dei giornali) e un’esperienza concreta che svanisce come un rivolo d’acqua tra le crepe dei nostri corpi, le ore di fatica sui libri, i dialoghi con gli studenti, le lezioni preparate con cura, le tesi corrette virgola per virgola, tutta roba troppo umana e volatile per essere contabilizzata dagli indicatori, e che quindi non esiste.
Se avete un’idea generica dell’università, toglietevi dalla testa l’immagine dello scienziato pazzo chiuso in laboratorio o in biblioteca e perfino del barone che veleggia in corridoio con il codazzo di allievi, come il dottor Tersilli. Ecco quello che ti può capitare in una giornata-tipo.
Apri il computer la mattina e commetti l’errore fatale di controllare la posta: trovi l’ennesimo, sempre più minatorio messaggio dell’Area della Ricerca – corredato da un richiamo del direttore del dipartimento – che ti ricapitola modalità e tempistica della prossima Vqr (Valutazione della Qualità della Ricerca), operazione che dovrai compiere dopo esserti registrato nell’apposita banca dati – che naturalmente sostituisce le precedenti – ed esserti dotato del codice Orcid (questo, giuro, non so cosa significa). La prima cosa che borbotti è: vi supplico, una moratoria sugli acronimi! Poi, con un mezzo sorriso, ricordi quella volta in cui si doveva ribattezzare il dipartimento nato dalla fusione dei due precedenti, in seguito all’applicazione della Legge Gelmini, e uno dei nomi ipotizzati produceva l’acronimo «Ficam» – nell’Italia berlusconiana sarebbe stato un trionfo. Quindi ti muore il sorriso in bocca perché sai che queste procedure di valutazione, mascherate dietro la retorica del merito e dell’eccellenza, servono solo a legittimare i tagli finanziari, condizionano pesantemente la libertà di ricerca, aumentano le sperequazioni tra le varie università (e poi tra le regioni del Paese, e infine tra i singoli cittadini, in barba alla Costituzione) e soprattutto fanno tutte queste schifezze senza avere alcuna effettiva attendibilità.
Mezz’ora dopo arriva un messaggio dalla redazione di una rivista, ovviamente di «classe A», che in quanto tale pratica con zelo fanatico la peer review: ogni articolo da pubblicare deve passare al vaglio di due esperti che lo giudicano in forma anonima, riportando la valutazione in macchinose schede con criteri tipo «originalità», «rigore metodologico» o «completezza bibliografica». Che si tratti di etichette opache e pseudo-scientifiche è evidente a chiunque abbia un’esperienza minima di questo mestiere. E solo un pazzo (o un bugiardo), chiamato a valutare un articolo – mettiamo – su Marcel Proust, potrebbe millantare di conoscere la bibliografia completa su Proust, impresa paradossale e tecnicamente impossibile di cui ha parlato uno dei più grandi studiosi dell’opera proustiana, Mario Lavagetto1. Qui poi il caso è delicato: devi fare da arbitro tra due giudizi opposti: uno dei revisori pensa che l’articolo sia buono, pubblicabile con pochi emendamenti, mentre l’altro pensa che l’autore sia una capra, lo strapazza con sadica ferocia (ma che t’ha fatto la vita!?) e gli consiglia sprezzantemente di leggersi quattro lustri di riviste specializzate e almeno una trentina di contributi imprescindibili. Fai un gran sospiro, pensi che questi sono pazzi e che anche il ragionevole esercizio della peer review, ormai sport nazionale degli accademici, sta prendendo una piega completamente distorta rispetto agli obiettivi e ai criteri con cui dovrebbe essere praticato. Ma cosa non si farebbe pur di giocare in serie A?
Un’altra mezz’ora e un altro messaggio dalla redazione di una rivista online, anche questa di classe A: ricordi quel saggio che hai pubblicato due anni fa? Bene, ci serve l’abstract. Ci serve in italiano e in inglese, perché dobbiamo accreditarci presso vari database internazionali. E non dimenticarti le keywords. E poi, scusaci, potresti piantarla di scrivere in italiano? (Questo non lo dicono, ma un po’ me lo immagino). Potresti piantarla di scrivere questi saggi scimmiottando ancora Barthes o Debenedetti? Sei veramente antico. Ormai si scrivono solo papers, con un bell’abstract all’inizio, esposizione netta della tesi, illustrazione, conclusione, quod erat demonstrandum. Si legge a chiare lettere anche nei «criteri per la valutazione dei prodotti della ricerca» emanati dal Gev 10, il Gruppo di Esperti della Valutazione per l’area artistico-letteraria, alla voce «rigore metodologico»: «da intendersi come il livello al quale il prodotto presenta in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e lo stato dell’arte nella letteratura, adotta una metodologia appropriata all’oggetto della ricerca e dimostra che gli obiettivi sono stati raggiunti». Il paradosso è che in realtà tu scrivi chiaro, sei sempre leggibile, non getti fumo negli occhi ma sei convinto che il vero pensiero (e il vero linguaggio) proceda per accumulazione progressiva di complessità, seguendo a volte giri tortuosi, andirivieni logici, invenzioni metaforiche, snodi argomentativi che conducono il lettore dove non si aspettava di giungere, grazie alla bussola della curiosità e non di uno sterile e standardizzato rigore2. Calvino diceva che il più grande scrittore italiano è in realtà uno scienziato, Galileo, che «usa il linguaggio non come uno strumento neutro, ma con una coscienza letteraria, con una continua partecipazione espressiva, immaginativa, addirittura lirica»3. Così ti metti al lavoro e intanto pensi a quanto detesti gli abstract, il gergo scientifico usato come maschera di una scienza fasulla, i papers di critica letteraria costruiti come pseudo-dimostrazioni di teoremi matematici: «In this paper I will point out…». E ti dici che in questo mondo uno come Lukács è ormai un marziano, quando descriveva la forma del saggio come un percorso di esplorazione e scoperta, una tensione verso una meta non ricercata, perché «il saggio tende alla verità, esattamente, ma come Saul, il quale era partito per cercare le asine di suo padre e trovò un regno»4.
Il tempo che butti a scrivere l’abstract è fatale. Quando hai finito trovi una colonna di cinque messaggi no-reply di altrettante università in cui uno dei tuoi studenti ha fatto l’application, segnalandoti come referee per inviare una lettera di presentazione. Di nuovo chini il capo paziente, vai a spulciare nella cartella del computer in cui hai salvato qualche centinaio di lettere simili, fai un po’ di pastiches e collages e alla fine spedisci, o meglio fai l’upload, dopo avere valutato in termini percentuali le abilità dello studente e avere risposto a varie domande sulla sua maturità emozionale, le motivazioni psicologiche o la capacità di leadership. Anche qui l’automazione delle pratiche ha espropriato completamente il significato di quello che fai, fasciando in un bozzolo di stupidità docimologica e burocratica il giudizio critico e la drammatica realtà dell’esperienza (centinaia di lettere nel mio computer dicono che ci sono migliaia e migliaia di studenti, spesso i migliori, costretti a cercare fortuna all’estero perché questo sciagurato Paese non offre nulla). Più che altro ti rammarichi di non essere un bravo informatico, perché in tal caso metteresti a punto un software per generare automaticamente lettere di presentazione, ormai lavoro da catena di montaggio, prodotto da industria pesante, immettendo solo nome e cognome dello studente, date, titolo della tesi e via dicendo.
Quando arriva la bozza di un progetto di ricerca del network internazionale in cui non ricordavi di essere stato incluso, 78 pagine fitte fitte con tabelle e citazioni di ranking internazionali per chiedere il finanziamento di un libro e di un paio di convegni, beh, a quel punto scendi al bar sotto casa e ti ubriachi…
2. La vendetta di J. Evans PriTchard
Ora, che cos’hanno in comune queste cose, a parte la patetica irrilevanza per il resto del genere umano? Il tratto più evidente è la falsa pretesa di scientificità, come se la crisi dei paradigmi epistemologici in tutti i campi del sapere fosse compensata da un’istanza neopositivista che, in mancanza d’altro, colonizza le pratiche gestionali e organizzative della ricerca. Tutti gli episodi che ho descritto, rigorosamente veri, coniugano un massimo di giudizio soggettivo e inverificabile con un massimo di (finta) oggettività, come se la tragica imperfezione della conoscenza umana potesse essere riscattata dai numeri, dalle percentuali, dai criteri formalizzati o dal gergo anglicizzante (d’ora in poi il coordinatore dei progetti di ricerca si chiamerà Principal Investigator, abbreviato P.I., come Magnum, che è obiettivamente tutta un’altra cosa). Effetto tanto più grottesco, e imbroglio tanto più grande, nell’area dei saperi umanistici, dove la finzione di oggettività è moltiplicata dallo statuto ancora più aleatorio degli strumenti, dei paradigmi e degli stessi oggetti di indagine.
C’è una scena molto famosa all’inizio dell’Attimo fuggente: la classe pronta per la lezione e il professor Keating (Robin Williams) che chiede a uno studente di leggere il primo paragrafo della prefazione al libro di letteratura, Comprendere la poesia, di Jonathan Evans Pritchard, Professore Emerito:
Per comprendere appieno la poesia dobbiamo anzitutto conoscerne la metrica, la rima e le figure retoriche e poi porci due domande: uno, con quanta efficacia sia stato reso il fine poetico e due, quanto sia importante tale fine. La prima domanda valuta la forma di una poesia, la seconda ne valuta l’importanza. Una volta risposto a queste domande, determinare la grandezza di una poesia diventa una questione relativamente semplice. Se segniamo la perfezione di una poesia sull’asse orizzontale di un grafico e la sua importanza su quello verticale, sarà sufficiente calcolare l’area totale della poesia, per misurarne la grandezza. Un sonetto di Byron può avere valori alti in verticale, ma soltanto medi in orizzontale. Un sonetto di Shakespeare, d’altro canto, avrà valori molto alti in orizzontale e in verticale, con un’imponente area totale che di conseguenza ne rivela l’autentica grandezza. Procedendo nella lettura di questo libro esercitatevi in tale metodo di valutazione. Crescendo così la vostra capacità di valutare la poesia, aumenterà il vostro godimento e la comprensione della poesia.
Memorabile il commento del professor Keating, che nel frattempo ha disegnato con ironico zelo un grafico cartesiano alla lavagna, ricopiato con il righello dall’antipatico secchione della classe: «Escrementi! Ecco cosa penso delle teorie di J. Evans Pritchard. Non stiamo parlando di tubi, stiamo parlando di poesia. Ma si può giudicare la poesia facendo l’hit parade?».
Quando vidi il film, nell’autunno del 1989, avevo gli occhi dello studente appena iscritto alla Facoltà di Lettere di Bologna e la memoria degli anni di scuola trascorsi a pentirmi di avere fatto il liceo scientifico. Ovviamente la lezione del professor Keating ebbe il potere travolgente delle rivelazioni. Solo più tardi capii che la scena metteva in parodia, con un po’ di faciloneria neoromantica ma indiscutibile efficacia retorica, alcuni metodi critici che sono stati egemoni nella fase centrale del Novecento, tra il new criticism americano e lo strutturalismo di matrice europea, soprattutto francese. In realtà quei metodi avevano spazzato via la ferraglia empirica e l’armamentario polveroso della vecchia critica biografica, storica e impressionistica, nel miraggio di istituire una scienza “forte” della letteratura che trovasse il suo fondamento epistemologico nella disciplina-chiave del sapere novecentesco, la linguistica (di questo «miraggio linguistico» Thomas Pavel ha tracciato una lucida ricognizione già nel 1988)5. Poi forse hanno un po’ esagerato. L’utopia illuminista di una mathesis universalis che potesse ricomprendere e integrare tutte le scienze umane si è ribaltata spesso in una forma di cecità dogmatica, in una furia tassonomica e nomenclatoria con cui imbrigliare la complessità del fatto letterario in tabelle, tipologie, schemi logici, grammatiche narrative, strutture astratte e quadrati semiotici. Quel che sfuggiva alle griglie della formalizzazione era proprio l’oscuro oggetto del desiderio critico, la letterarietà, «ciò che di una data opera fa un’opera letteraria»6. Lo aveva intuito subito uno dei protagonisti più geniali di quella stagione, Roland Barthes, che in un saggio decisivo del 1966 auspicava l’avvento di una nuova «scienza della letteratura» fondata sul paradigma linguistico, capace di sottoporre il testo letterario «ad analisi sicure», ma solo p...