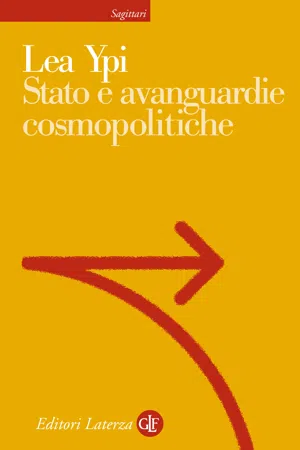
- 336 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Stato e avanguardie cosmopolitiche
Informazioni su questo libro
Gli autori che si rifanno al cosmopolitismo iniziano la riflessione da una visione ideale di come le leggi dovrebbero essere, ma omettono di considerare gli individui come essi sono; per contro, gli autori statisti perlopiù partono da un'analisi realistica della società ma tralasciano di considerare le potenzialità di trasformazione radicale delle leggi. In questo libro si propone una versione di cosmopolitismo concepito come agire politico di avanguardia. L'analisi è radicata in una concezione dialettica della giustizia sociale e dimostra come sia possibile promuovere la desiderabilità normativa dell'ideale cosmopolitico di eguaglianza grazie al contributo di forze politiche progressiste contenute nello Stato.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Stato e avanguardie cosmopolitiche di Lea Ypi in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Filosofia e Filosofia politica. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
FilosofiaCategoria
Filosofia politica1.
La controversia storica
1.1. Può un cosmopolita essere un buon cittadino?
«Un cosmopolite n’est pas un bon citoyen». Questo il giudizio netto che si legge nella quarta edizione del Dizionario dell’Accademia Francese, stampata nel 1762. Più misurata nella forma, ma non meno categorica nella sostanza, la definizione riportata nell’Enciclopedia di Diderot e D’Alembert: «Alle volte usiamo questo termine per scherzo, riferendoci a un uomo senza fissa dimora, un uomo cioè che non è straniero in alcun luogo»5. Entrambe le definizioni suggeriscono che, contrariamente a quanto si crede, l’Illuminismo non è stato solo il periodo di auge del cosmopolitismo, ma anche della sua negazione6.
In questo capitolo mi soffermerò sulle radici storiche della controversia tra cosmopolitismo e statismo, così come essa si sviluppò durante il periodo dell’Illuminismo7. Lungi dal cercare di fornire al lettore un resoconto esaustivo e storicamente impeccabile di tutte le posizioni che emersero nel corso del dibattito, lo scopo di questo capitolo è di fornire una ricostruzione della genesi di concetti e argomentazioni che verranno analizzati in modo più dettagliato nei capitoli seguenti. La riflessione su alcune figure di rilievo del panorama intellettuale dell’epoca dei Lumi mostra come il disaccordo tra intellettuali che associamo alle contrapposte posizioni statiste e cosmopolitiche è ascrivibile in larga parte a una sotto-teorizzazione del nesso tra principi normativi e agire politico, una relazione che ancora oggi sembra marginalizzata dalla teoria politica contemporanea. Partire con un’analisi storica di questa relazione è fondamentale per confrontare e valutare le diverse teorie della giustizia globale, così come per elaborare una nuova interpretazione del problema che tenga conto dei pro e dei contro delle diverse prospettive per generare una proposta normativa originale e plausibile.
La prima parte del capitolo introduce due accezioni del termine «cosmopolita» diverse e incompatibili tra loro, diffuse tra gli intellettuali durante il secolo dei Lumi e che ancora oggi caratterizzano il dibattito sul cosmopolitismo – informando sia le posizioni critiche, sia quelle a favore. A un significato negativo, associato con l’attitudine di cittadini che ignorano la centralità di specifiche istituzioni che regolano la vita associata e che restano indifferenti davanti a diversi ordini legislativi, si affianca un significato più positivo, associato con l’attitudine del «saggio», la cui lealtà verso una certa comunità politica è condizionale alla rispondenza di quest’ultima a un ideale universale di uguaglianza. Il fatto che di volta in volta una di queste due concezioni prevalga nel pensiero politico ha prodotto un’oscillazione continua tra una valutazione del cosmopolitismo talvolta venata di scetticismo o di ostilità, come nel caso di autori quali Voltaire o Rousseau, talaltra caratterizzata da un’accettazione entusiasta, come per Leibniz e Diderot. L’analisi delle loro argomentazioni filosofiche mostra come la tensione tra l’interpretazione positiva e quella negativa del cosmopolitismo nasce dal fatto che nell’ambito della riflessione filosofica si tende a trascurare la possibilità che la relazione tra principi normativi e capacità di azione politica non sia necessariamente di reciproca negazione e che quindi le istanze dei fautori del cosmopolitismo e dello statismo possano trovare una mediazione proficua sotto un punto di vista normativo.
Questo problema verrà approfondito nella seconda parte del capitolo. Qui, soffermandomi in particolare su Rousseau, uno degli autori invocati più spesso dagli scettici del cosmopolitismo, condurrò un’analisi di come la critica al cosmopolitismo si sia evoluta a partire dal Discorso sull’origine e i fondamenti della disuguaglianza (il suo Secondo Discorso) per arrivare al Contratto sociale. Mentre in una prima fase della sua opera Rousseau giudica l’idea del cosmopolitismo in maniera sostanzialmente positiva, più tardi egli giunge invece a considerarla indeterminata da un punto di vista morale, o, ancor peggio, potenzialmente catastrofica da un punto di vista politico. Infatti, il cosmopolitismo potrebbe essere sia l’atteggiamento di un eroe buono ma naïf, sia quello di un cittadino indifferente rispetto alla propria comunità politica. In entrambi i casi, nell’essere un’attitudine – più o meno lodevole – meramente individuale, il cosmopolitismo appare poco promettente per realizzare il fine (rilevante per l’intera comunità dei cittadini) di riformare le istituzioni politiche.
La terza parte del capitolo, infine, mostra come, nella riflessione politica di Kant, la persistenza di questo genere di argomentazioni e l’oscillazione tra un significato positivo e uno negativo di cosmopolitismo hanno prodotto una vera e propria svolta concettuale. Infatti, concentrandosi sulla filosofia della storia kantiana così come sulla sua teoria del diritto, si può notare come il cosmopolitismo, un concetto che alla metà del diciottesimo secolo appariva astratto e vago, viene inserito nel contesto di un’analisi ben più elaborata del rapporto tra principi normativi e capacità d’azione politica. Leggendo le vicende storiche alla luce della dinamica del progresso morale, Kant è dunque il primo a intravedere la possibilità di riconciliare cosmopolitismo e statismo, ponendo le premesse per una sintesi fruttuosa tra una concezione globale di uguaglianza e la dimensione morale delle relazioni politiche di natura associativa che genera la coesione sociale e quindi la stabilità del sistema politico statale. Chiarendo la rilevanza dell’approccio statista-cosmopolitico di Kant nel contesto della storia del pensiero politico, perciò, questo capitolo introduce i lettori al tema sviluppato nel resto del volume, in cui delineo e difendo un’interpretazione simile a quella kantiana.
1.2. Cosmopolitismo positivo e negativo
«Interrogato sulla sua patria, rispose: ‘cittadino del mondo’». I commentatori latini e greci hanno normalmente attribuito la paternità del termine kosmopolites a Socrate o a Diogene il Cinico8. Ma lo spirito con cui i due filosofi avrebbero potuto pronunciare il termine sarebbe stato piuttosto differente. E differenti furono anche i modelli di cosmopolitismo che ispirarono durante il periodo dei Lumi.
Gli insegnamenti di Socrate miravano a spingere ogni persona a pensare con la propria testa, una massima che più tardi Kant fece propria, proponendola come il principio fondante dell’Illuminismo9. Per Socrate, ogni persona possiede uno status morale uguale a quello di ogni altra persona, a prescindere dalla propria identità e provenienza. Perciò il cosmopolitismo, come attitudine positiva dei cittadini che hanno a cuore il benessere di tutti gli esseri umani senza alcuna distinzione, era associato a un’imprescindibile lealtà alle istituzioni politiche della comunità a cui ognuno apparteneva dalla nascita10.
Nel caso di Diogene il Cinico – un personaggio che Platone avrebbe caratterizzato come «il Socrate pazzo»11 – ci troviamo davanti a un significato completamente diverso di cosmopolitismo. La rivendicazione di Diogene di essere cittadino del mondo, infatti, non aveva alcunché di positivo: con essa, anzi, egli non riconosceva alcun legame con nessun altro individuo al mondo, rifiutava di obbedire alle leggi della propria comunità politica, e infine rigettava la stessa idea di politica come attività collettiva. La lealtà al mondo – kosmos –, in opposizione a una particolare comunità politica – polis –, rivestiva una valenza decisamente negativa, a cui non corrispondeva alcuna assunzione di responsabilità in positivo: non si aveva, perciò, alcuna estensione degli obblighi civico-politici dalla polis al kosmos. Secondo Diogene, infatti, il vivere in armonia con le leggi della natura era l’unica filosofia morale possibile; ma, pur convinto di ciò, egli non cercò mai di diffondere una simile dottrina. Nell’ottica di contestare ogni obbligo positivo e ogni legame verso gli amici, la famiglia, o la propria comunità politica, la sua enfasi sull’essere «cittadino del mondo» serviva esclusivamente a farsi beffe dell’idea che esistesse una qualunque responsabilità civica.
Entrambe le versioni del cosmopolitismo – una positiva, l’altra negativa – sono riemerse durante il periodo dei Lumi. Durante il diciassettesimo e il diciottesimo secolo, l’Europa si scopriva drammaticamente lacerata da conflitti politici che discendevano dallo scontro tra dottrine politiche e religiose diverse e apparentemente inconciliabili. Un nuovo mondo aveva cominciato a emergere dalla crisi delle istituzioni politiche che, avendo perso la propria stabilità, sfruttavano le ostilità confessionali per assicurarsi la sopravvivenza. La crisi della res publica cristiana, l’emergere degli ideali rinascimentali e un rinnovato interesse per lo studio dei testi latini e greci dell’antichità portarono a una comprensibile riscoperta del cosmopolitismo. In particolare, l’ideale socratico sembrava funzionale per rispondere alle necessità della nuova epoca, dal momento che prometteva di conciliare l’idea di una morale universale con l’indipendenza individuale, e promuoveva la solidarietà come virtù svincolata dalle dottrine religiose e la tolleranza come precetto della vita associata. Allo stesso tempo, il significato negativo di cosmopolitismo non scomparve; esso continuava a manifestarsi nell’atteggiamento irriverente di individui che si dichiaravano cittadini del mondo con il solo fine di evitare ogni assunzione di responsabilità entrando nel merito di una qualunque controversia politica.
Leibniz fu uno dei primi filosofi a riprendere – implicitamente – il significato positivo di cosmopolitismo di derivazione greca. La giustizia, secondo lui, è la virtù che guida l’affetto dell’uomo per gli altri esseri umani e coincide con la «carità del saggio»: i greci la chiamavano filantropia, indicando così una disposizione benevola propria dell’uomo saggio, «cioè di chi segue i dettami (dictata) della saggezza»12. L’esercizio della giustizia, perciò, dovrebbe essere considerato indipendente dalle convenzioni proprie di ogni Stato e in particolare dalle specifiche circostanze politiche di ogni comunità perché, secondo Leibniz, «fintanto che sia possibile compiere un’azione che porti benefici, per me non vi è differenza se essa viene compiuta in Germania o in Francia: a me preme soltanto e soprattutto il bene della razza umana»13.
Questo senso cosmopolitico di giustizia, nell’interpretazione di Leibniz, si risolve in un istinto universale di compassione, un sentimento di socievolezza che è insito in ogni essere umano e che l’esercizio della ragione ha il dovere di rischiarare ogni volta che esso venga oscurato da convenzioni che vi si oppongono o da inclinazioni egoistiche14. Leibniz vedeva bene che l’atteggiamento filantropico dei singoli individui non era di per sé sufficiente per garantire lo sviluppo di progetti cosmopolitici a livello mondiale. Per fare ciò, era necessario iniziare da qualche parte: cercare il supporto di questo o quel sovrano, lavorare per costruire relazioni sociali capaci di generare influenza, e sondare il potenziale delle idee cosmopolitiche in contesti politic...
Indice dei contenuti
- Ringraziamenti
- Introduzione
- Parte prima. Storia e metodo
- 1. La controversia storica
- 2. Teoria politica attivista e avanguardia
- Parte seconda. Difesa dello Stato e difesa del cosmopolitismo
- 3. La politica e le relazioni associative
- 4. Egualitarismo globale
- Parte terza. Il cosmopolitismo statista
- 5. Principi
- 6. La dimensione dell’agire
- 7. Avanguardia cosmopolitica
- Conclusione
- Bibliografia