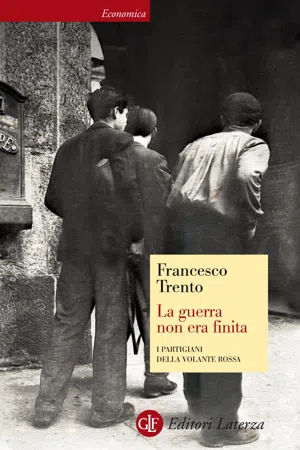1.
Un dopoguerra armato
Milano, 10 agosto 1944.
I corpi di quindici partigiani giacciono sul selciato di piazzale Loreto. Sono stati fucilati all’alba, una strage decisa dal capitano nazista Theodor Saevecke in seguito al bando emanato nel giugno da Kesselring. Due giorni prima un attentato ha colpito un mezzo militare tedesco in viale Abruzzi. L’autista ha riportato qualche ferita e non ci sono vittime naziste. Tuttavia, Saevecke non ha dubbi: compila di suo pugno la lista dei “banditi” che dovranno morire per rappresaglia. I quindici vengono prelevati dal carcere di San Vittore. A ognuno di loro viene data una tuta da lavoro, perché pensino di essere destinati al trasferimento in Germania. Vengono invece uccisi da un plotone d’esecuzione della legione Muti.
I loro corpi rimangono esposti al sole, coperti di sangue e di mosche, per l’intera giornata: Milano deve sapere cosa succede a chi si ribella ai nazisti. In mezzo ai cadaveri gettati contro lo steccato, i repubblichini piantano un cartello che li chiama assassini.
Una folla di persone si avvicina al luogo della strage: uno degli uccisi è caduto con una mano sul viso, come a proteggersi dalle raffiche. Un altro ha perso una scarpa. Nessuno ha ricomposto i loro corpi, che giacciono in pose innaturali, come marionette disarticolate. Pochi centimetri sopra le loro bocche, spalancate nell’ultimo disperato tentativo di mandare aria ai polmoni, alcuni manifesti teatrali strillano a grandi lettere: “Novità”; “Il più grande successo comico del giorno”.
Poche ore e il caldo di agosto aggredisce i corpi rendendo l’aria irrespirabile. I parenti delle vittime piangono e gridano, insultati dai militi repubblichini che gli impediscono di avvicinarsi “a quel mucchio di immondizia”. Lo spettacolo è talmente raccapricciante che alcune donne svengono.
In piazza, giunto col tram da Lambrate assieme a un compagno di brigata, c’è anche un giovane partigiano della 118ª Garibaldi. Ha 18 anni, deve compierne 19 a settembre, e probabilmente si chiede se ci arriverà vivo. Il ragazzo guarda i corpi martoriati dei suoi compagni di lotta, ascolta le grida dei loro assassini. Serra i pugni e rimane a fissarli con odio. Non c’è altro che possa fare, oggi, ma promette a se stesso che un giorno i fascisti la pagheranno cara.
Il ragazzo si chiama Giulio Paggio. Nel dopoguerra, ogni fascista conoscerà il suo nome1.
Non è ancora tempo di pace
Il 25 aprile del 1945, l’Italia è finalmente libera. Ma la guerra, per molti, non è ancora finita. Vendetta e giustizia sono divenuti sinonimi per un popolo che ha vissuto negli stenti e nel terrore, un popolo torturato e sfruttato che ora rinasce e odia, e crede sia giunto il momento di saldare i conti.
Così, all’indomani della Liberazione, la preoccupazione principale del Partito comunista sembra essere quella di tenere a freno gli slanci estremistici della sua base: sono in molti a pensare di poter trasformare l’insurrezione in atto rivoluzionario, fare “come in Russia”, dare l’assalto al cielo. Tantissimi, soprattutto, chiedono una drastica epurazione. In assemblee infuocate, gli ex partigiani e i militanti che hanno rischiato la vita durante la Resistenza “invocano il mitra e propongono soluzioni illegali a problemi di lotta”2.
Il partito di Togliatti è costretto spesso a gettare acqua sul fuoco, tentando di gestire il “passaggio dall’illegalità alla legalità”3. Un compito ingrato, reso ancor più difficile dalle durissime condizioni sociali dell’Italia del dopoguerra.
Tra la primavera e l’estate del 1945 la disoccupazione è a livelli di guardia, e arriverà a toccare addirittura il 40% delle forze lavorative. La ricostruzione non decolla, e nelle campagne si apre una dura stagione di lotte. Inoltre, il rientro alla vita civile di soldati, ex partigiani e prigionieri di guerra crea nuove drammatiche tensioni tra la massa dei disoccupati e le donne o i giovani subentrati, durante il conflitto, nei posti di lavoro.
Tornano anche i sopravvissuti dai campi di concentramento, coi loro racconti dell’orrore nazista. E i partigiani sentono ancora di più che non si può tirare una riga su tutto quel che è successo, far finta di nulla, tornare alla vita civile senza che coloro che hanno compiuto quei crimini vengano puniti.
C’è inoltre il problema delle armi: l’ordine di riconsegnarle viene vissuto dai partigiani come una spoliazione ingiustificata, un affronto da parte degli Alleati con cui hanno condiviso la stessa battaglia, combattuto lo stesso nemico. Imponendogli di separarsi dalle armi con cui hanno affrontato e vinto i tedeschi, “il governo li priva del più ambito segno di riconoscimento della loro guerra, li esautora, sottrae loro il ruolo sociale guadagnato a costo della vita”4.
Soprattutto, i partigiani temono un ritorno del fascismo. Perciò quasi dappertutto vengono consegnati solo i ferri vecchi, fucili della prima guerra mondiale come i Mauser e i Carcano ’91. Mentre le armi più nuove, i Thompson e gli Stein, finiscono in depositi clandestini, nascosti nelle soffitte, negli scantinati, a volte addirittura sottoterra, oliati e ben protetti: pronti per l’uso in caso di bisogno.
Ma intanto qualcuno, stanco dei ritardi della giustizia nel punire i fascisti, quelle armi decide di usarle. Così, le “tre guerre” (patriottica, civile, di classe) di cui lo storico Claudio Pavone5 compone il fenomeno resistenziale non finiscono tutte il 25 aprile. Nei mesi successivi alla Liberazione si continuano a raccogliere morti per le strade. Fenomeni di giustizia popolare, di vendetta personale o di classe, sono all’ordine del giorno in tutto il Nord Italia.
Del resto, la carica d’odio lasciata in eredità dalla guerra è impressionante, ed emerge sin nel racconto di chi, come Nuto Revelli, si oppone all’utilizzo del termine “guerra civile” in riferimento alla Resistenza:
Non fu una guerra civile nel senso pieno del termine perché i fascisti per noi erano degli stranieri come e forse più dei tedeschi, li odiavamo più di quanto odiassimo i tedeschi. [...] Era inconcepibile che degli italiani si degradassero fino a terrorizzare, torturare, ammazzare gente che aveva le stesse radici, con la quale erano cresciuti assieme6.
Vendicarsi, lavare nel sangue i torti subiti, diviene a volte unico motivo di vita. Esemplare, in questo senso, è la vicenda di Giuseppe Bonfatti, il partigiano “Remo”. Durante la Resistenza, l’11 novembre del 1944, la sua famiglia subisce una dura rappresaglia a Viadana, in provincia di Mantova. Bonfatti, che dopo la guerra è emigrato in Brasile, torna in Italia sul finire degli anni Ottanta. E l’8 novembre 1990, dopo aver riconosciuto in un bar di Viadana uno di quelli che gli hanno bruciato la casa, lo uccide a colpi di piccone. Poi si consegna ai carabinieri. “È la cosa più bella che ho fatto al mondo e non sono pentito”, dirà poi al processo. “Era un obbligo verso i miei parenti e anche verso il mio ideale”7.
Se c’è chi aspetta quasi cinquant’anni per farsi giustizia, a Milano c’è qualcuno che non intende rimandare: Giulio Paggio, il ragazzo di diciott’anni che ha giurato vendetta davanti alla strage di piazzale Loreto.
Sono passati quasi nove mesi, e quel ragazzo è diventato un uomo. Ferito al braccio destro nel settembre 19448, si è poi distinto in pericolose azioni partigiane come l’assalt...