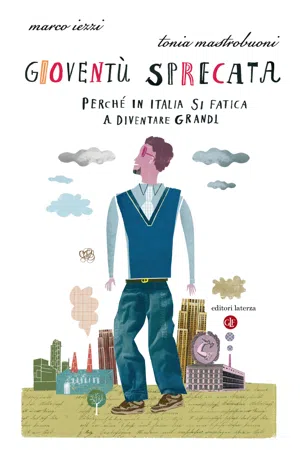1. Ultimi a scuola
Nella patria di Maria Montessori, miriadi di maestri e professori continuano a fare il loro lavoro con abnegazione, nonostante gli stipendi da fame, il peso fiscale enorme, scuole fatiscenti e una gavetta mediamente lunga da precari. Ma evidentemente non basta. Nel nostro paese manca ancora, incredibilmente, un sistema complessivo di valutazione della scuola che restituisca periodicamente un quadro chiaro dei processi organizzativi, della didattica e della spesa. È difficile, dunque, capire a fondo perché gli alunni dei licei e degli istituti tecnici italiani stiano perdendo di anno in anno conoscenze e competenze, rispetto ai loro coetanei svedesi, francesi o inglesi. Tuttavia, la tendenza a un netto peggioramento dell’istruzione e della formazione è in atto da anni, nel nostro paese. E i principali indiziati sono indubbiamente la didattica e una allocazione delle risorse totalmente squilibrata che sconta, come si legge in un approfondito studio interministeriale del 2007, il Quaderno bianco sulla scuola, un «livello insufficiente della spesa in conto capitale, per attrezzature e strutture».
Il documento sottolinea anche che sul rendimento degli studenti incide in maniera «assai rilevante il peso del combinato disposto di talento e impegno dei singoli insegnanti» che non è purtroppo riconducibile «ad alcuna caratteristica misurabile». Per dirla con Claudio Cremaschi, un insegnante ed ex preside che ha scritto un libro dal titolo eloquente, Malascuola,
oggi c’è un patto implicito, nel rapporto di lavoro tra gli insegnanti e lo Stato. Bassa remunerazione, scarso prestigio sociale; un semilavoro, un’attività che può essere impegnativa, se uno la prende sul serio, ma che può essere anche gestita a discrezione. Nessuno controllerà più di tanto.
Ma la discrezionalità che deriva da questo patto implicito, basato in sostanza sul binomio «stipendio da fame ma posto fisso e pensione assicurata», contribuisce alla decadenza della scuola. Nell’ultimo Rapporto giovani realizzato dall’istituto Iard si legge che la maggioranza degli alunni italiani (63,3%) imputa agli insegnanti una scarsa capacità di relazionarsi a loro. I dati si riferiscono al 2004: la metà (50,5%) ritiene i propri professori poco stimolanti e uno su tre (37,1%) pensa «che manchi addirittura la competenza rispetto alla materia insegnata». Sempre circa un terzo degli studenti italiani pensa che i propri insegnanti siano troppo diffidenti verso l’innovazione tecnologica, mentre oltre la metà li ritiene troppo severi (26,6%) oppure, al contrario, troppo accondiscendenti e arrendevoli (26,5%). Un dettaglio interessante è che la percezione di una eccessiva arrendevolezza è aumentata quasi del 10%, negli ultimi anni. Nel 1984 era il 17,9%. E si tratta di dati che, oltretutto, fanno a pugni con le aspettative degli studenti: oltre due terzi (68,1%) reputano l’istruzione scolastica «molto importante», la ritengono un valore imprescindibile.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti. A maggio del 2006, nelle sue prime Considerazioni finali da governatore della Banca d’Italia, in occasione dell’assemblea annuale dell’istituto, Mario Draghi intitolò un paragrafo Azioni per il rilancio. Non conteneva solo valutazioni sul fisco, sul lavoro o sulla produttività, sugli ormai classici «talloni di Achille» della nostra economia. Per Draghi (Banca d’Italia, 2006), uno dei problemi più gravi dell’Italia è che negli ultimi dieci anni «ha ridotto il divario rispetto ai paesi avanzati nella diffusione dell’istruzione tra i giovani»: un ritardo accumulato che secondo il governatore della Banca d’Italia «peserà ancora a lungo sul livello medio del capitale di istruzione degli italiani».
In particolare, con riferimento al 2003, Draghi ricordava gli ormai drammatici dati sull’abbandono scolastico e universitario. In Italia solo un terzo delle persone tra i 25 e i 64 anni è diplomato e soltanto una persona su dieci è laureata, contro una media dei paesi dell’Ocse, rispettivamente, del 41% e del 24%. Il problema, tuttavia, non è solo quella che in gergo viene definita la «dispersione». Il dramma è che la qualità dei risultati ottenuti a scuola presenta ormai «aspetti critici». In particolare, notava Draghi,
a quindici anni gli studenti italiani hanno accumulato un ritardo nell’apprendimento della matematica equivalente a un anno di scuola: secondo un’indagine dell’Ocse, l’Italia figura al ventiseiesimo posto su ventinove paesi. A questo difetto di efficacia se ne aggiunge uno di equità: la variabilità nei livelli di apprendimento dei quindicenni colloca il nostro paese al ventitreesimo posto dell’Ocse; il successo scolastico nella scuola superiore e all’università è fortemente correlato alle condizioni della famiglia di provenienza.
Pochi mesi dopo quelle Considerazioni finali, a dicembre del 2006, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno emanato una raccomandazione (2006/962/CE) che definisce le «competenze chiave per l’apprendimento permanente». In cima alla lista figuravano la matematica, le scienze e l’informatica. In questi campi, come aveva sottolineato Draghi, e come testimoniano puntualmente le indagini periodiche Ocse-Pisa, gli studenti italiani continuano a perdere posizioni, nel confronto internazionale. Leggendo le competenze dei ragazzi di 15 anni che frequentano gli istituti tecnici, rilevate dall’indagine Ocse-Pisa del 2006, i giudizi riferiscono che i giovani si mostrano carenti nelle materie scientifiche.
Entrando nel dettaglio di quell’indagine, salta agli occhi che le conoscenze nozionistiche degli studenti italiani, misurate dal Pisa (Program for International Student Assessment), si attestano a 475 punti, rispetto a una media dei paesi Ocse di 500. Al vertice della classifica i finlandesi, con 563 punti. Questo divario, che a una prima lettura potrebbe sembrare minimo, in realtà non è trascurabile perché si riferisce a confronti tra dati medi. Divari anche più ampi, intorno ai 30 punti, si riscontrano nelle competenze in matematica e nella lettura e comprensione dei testi. Secondo gli standard dell’Ocse sembra ancora più preoccupante il fatto che nel nostro paese sono ancora tanti i quindicenni che non raggiungono un livello di cognizione negli studi considerato sufficiente. Si tratta del 22,5% nel caso delle scienze, del 28,7% in matematica e del 26,2% in lettura e comprensione dei testi.
La conseguenza è lapalissiana. Chi conclude gli studi è sempre meno adeguato, rispetto a un diplomato francese, inglese o finlandese, ad affrontare le sfide del mondo del lavoro. Una Indagine sulle imprese industriali e dei servizi della Banca d’Italia del 2007 ha messo in evidenza come, su un campione di oltre 4.200 imprese, gli imprenditori dessero un giudizio tutt’altro che positivo sulla scuola secondaria superiore e, in particolare, sui diplomati degli istituti tecnici e professionali. In quell’indagine, molti imprenditori valutavano gli apprendimenti di questi giovani assolutamente insufficienti.
Da oltre due anni si discute sulle misure introdotte nell’ambito scolastico dal ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini, dettate più da esigenze di contenimento della spesa pubblica che da impulsi riformatori. Al di là di misure spot come il maestro unico, il 5 in condotta e l’inglese potenziato alle medie, la sostanza del provvedimento sta nelle misure di razionalizzazione dei costi. Gli obiettivi sono l’accorpamento di 350 istituti e una riduzione di 42.000 docenti, che dovrebbero far risparmiare allo Stato 1,6 miliardi di euro negli anni 2009-2010 e altri 3,2 miliardi nel triennio successivo. I maggiori tagli di personale per aree territoriali sono previsti in Campania (–6.100 docenti), in Sicilia (–5.000), in Lombardia (–4.800), in Puglia (–4.000) e in Calabria (–2.700). In totale la previsione è di 37.000 posizioni ridotte in «organico di diritto», ovvero di posti definiti in base alla previsione degli iscritti. Ulteriori 5.000 posti dovrebbero essere tagliati «sull’organico di fatto», quello cioè che considera le effettive immatricolazioni di settembre. E le scuole con meno di 600 alunni dovranno essere accorpate. Una riorganizzazione draconiana, che in tre anni dovrebbe portare all’esodo di 133.000 insegnanti e a un taglio di circa 6 miliardi di euro.
Un’altra conseguenza dei tagli del ministro è la riduzione dell’orario delle lezioni. Secondo il segretario generale della Flc-Cgil, Mimmo Pantaleo, la decisione di ridurre l’orario nelle classi successive alla prima e nei soli istituti tecnici e professionali rischia però di «accentuare la separatezza tra i diversi segmenti, producendo nei fatti una divisione sociale grave e inaccettabile tra i giovani sulla base del censo e delle condizioni sociali e culturali di partenza».
A febbraio del 2010, dopo il via libera del Consiglio dei ministri, il ministro Gelmini ha definito in particolare la sua riforma dei licei e delle scuole secondarie «epocale» e «attesa da cinquant’anni». Nelle sue intenzioni, uno sfoltimento drastico degli attuali corsi e indirizzi dovrà portare a soli sei licei, due istituti tecnici con undici indirizzi e due professionali con sei indirizzi. Tranchant, anche qui, il giudizio di Pantaleo: «ciò che il governo ha approvato non è una riforma ma solo una rigorosa applicazione dei tagli decisi dal ministro Tremonti» (Intravaia, 2010).
È vero che gli stipendi del milione e trecentomila dipendenti che lavorano nelle scuole italiane assorbono il 97% delle risorse disponibili e non è sbagliato, evidentemente, incidere sul numero. Nel rapporto annuale sull’istruzione del 2007, l’Ocse sottolineava come in Italia, per la scuola primaria, si investano più risorse della media dei paesi più avanzati, 6.835 dollari per alunno contro 6.252 dollari. Sempre l’organizzazione parigina, nel rapporto Education ad a Glance del 2007, notava che «il costo più elevato dell’istruzione italiana è dovuto al rapporto insegnante per studente. In Italia, infatti, vi sono 9,6 insegnanti ogni 100 studenti rispetto ai 6,5 nell’area Ocse». In Italia, osservava, avviene esattamente il contrario di quanto accade in un paese come la Corea del Sud, dove ci sono pochi docenti ben pagati.
D’altra parte, nello stesso documento si legge che la spesa in conto capitale riflette una mancanza di investimenti in infrastrutture scolastiche soprattutto nel Sud del paese. Anche i risparmi previsti dalle ultime leggi finanziarie per la scuola, prima delle misure introdotte dal ministro Gelmini, sono stati fatti con il fine di razionalizzare la spesa. Dunque, alla cieca. I cosiddetti «tagli orizzontali» sono stati applicati pro quota, senza un criterio analitico, e interessano a pioggia una molteplicità di settori. In questo modo vengono tagliate indistintamente attività che risucchiano inutilmente risorse, ma anche attività proficue, che arricchiscono gli studenti. Per l’economista Francesco Giavazzi, il verdetto è chiaro. Come scrisse nel 2008 dalle colonne del «Corriere della Sera», «tagliare senza riorganizzare, spesso equivale a non tagliare».
Ma il tasto dolente, forse, è un altro. Gli stipendi degli insegnanti italiani sono talmente bassi, nel confronto internazionale, da far sorgere il dubbio che la qualità in picchiata degli studenti sia frutto anche della scarsa motivazione dei docenti, mal pagati, spesso alle prese con strutture fatiscenti e sempre più precari. Sempre lo studio dell’Ocse Education at a Glance del 2007, sui salari nella scuola media pubblica indicava gli insegnanti italiani, dopo 15 anni di carriera, al terzultimo posto tra i paesi industrializzati. Leggendo i dati a inizio e fine carriera degli insegnanti dei maggiori paesi europei della scuola primaria e di quella secondaria di I e II grado le cose non cambiano. Nel confronto tra i salari europei, gli insegnanti italiani sono quelli che guadagnano di meno, considerati nelle scuole di ogni grado. E le buste paga crescono anche molto più lentamente che negli altri paesi Ocse. Tra il 1996 e il 2006 sono aumentate dell’11%, mentre nei paesi industrializzati l’incremento medio è stato del 15%. Inoltre, in nessun altro paese gli insegnanti sono gravati da un’imposta sui redditi così pesante. Né in Germania, né in Svezia o in Francia le tasse sui redditi della generalità dei lavoratori dipendenti (15.000-28.000 euro all’anno) raggiungono l’aliquota Irpef del 27% in vigore in Italia.
Infine, sono sempre più spesso impiegati a tempo. Nel 1998-99 gli insegnanti a tempo indeterminato erano 726.000 contro i 65.000 con un contratto a termine, rispettivamente il 91% e il 9% del totale. In dieci anni la percentuale dei lavoratori flessibili è quasi raddoppiata: nel 2007-2008 i professori stabili erano 701.000 contro i 142.000 con una scadenza scritta sul contratto, l’83% contro il 17%. Ed è proprio qui, a scuola, che è nato il termine «precario»: molti insegnanti restano impiegati a tempo per oltre dieci anni.
Nel luglio del 2009 la Corte costituzionale ha in parte bocciato la riforma del ministro dell’Istruzione, perché né lo Stato né il ministero in questione possono ridimensionare la rete scolastica sul territorio che è di competenza delle Regioni. I punti del decreto sullo sviluppo economico che non hanno passato il vaglio dei giudici della consulta sono due. Il primo riguarda la definizione attraverso un regolamento ministeriale di criteri, tempi e modalità per ridimensionare la rete scolastica; il secondo punto considera l’attribuzione anche allo Stato, oltre che alle Regioni e agli enti locali, delle misure necessarie a ridurre i disagi causati dalla chiusura o dall’accorpamento di scuole nei piccoli comuni. La Consulta ha restituito in sostanza alle Regioni l’opportunità di fare una razionalizzazione più analitica della scuola.
Un altro problema che attanaglia la scuola italiana è l’invecchiamento del corpo docente. La Fondazione Giovanni Agnelli nel Rapporto sulla scuola in Italia 2009 ha stimato che nei prossimi dieci anni circa 300.000 docenti lasceranno l’insegnamento per limiti di età. Il grande esodo è dovuto al fatto che oggi gli insegnanti italiani sono fra i più vecchi del mondo. La loro età media supera i 50 anni. Il valore oscilla tra i 47 anni della scuola primaria e i 51 anni della scuola secondaria inferiore, mentre nella secondaria superiore l’età media supera i 53 anni di età. Così, gli insegnanti con più di 50 anni sono oltre il 55% del totale. Questo valore non trova riscontro in nessun altro paese europeo. Nel Regno Unito, ad esempio, gli insegnanti con più di 50 anni sono soltanto il 32%, mentre in Francia sono il 30% e in Spagna solo il 28%.
In Italia manca anche un sistema di valutazione della scuola, ogni iniziativa viene demandata all’organizzazione spontanea degli istituti. Non c’è una raccolta stutturata dei dati di sistema sull’offerta scolastica, sui processi organizzativi e didattici, sulla spesa; manca in particolare un monitoraggio in grado di verificare l’andamento del sistema scolastico nel suo complesso, così come avviene in molti altri paesi. Le stesse banche dati del ministero della Pubblica istruzione per lungo tempo sono state incomplete; anche dopo l’acquisizione delle rilevazioni statistiche nazionali, infatti, non erano compresi i dati delle scuole non statali. Per una seria riorganizzazione della scuola non si può continuare a prescindere da una metodologia che consideri la valutazione del sistema educativo, l’autovalutazione delle scuole, l’analisi esterna, i livelli di dispersione e i rapporti con il mondo del lavoro. In altre parole, è necessario stabilire un sistema di valutazione condiviso della scuola italiana in grado di aiutare la crescita degli istituti, favorire il lavoro dei docenti, indirizzare le risorse nel modo più opportuno e, dunque, fare in modo che si possano monitorare i risultati ottenuti. Negli Stati Uniti, dove le scuole operano in completa autonomia, sono stati preparati dei sistemi standardizzati di test dell’Educational Testing Service in grado di valutare in modo comparabile studenti di scuole diverse e i loro insegnanti senza comprometterne autonomia e indipendenza. Probabilmente un tipo di test simile a questo potrebbe essere utile anche in Italia per avere un metro comune in grado di considerare l’efficacia delle riforme adottate e di valutarne gli effetti.
È indubbio, come ha scandito il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico 2008/2009, che il sistema scolastico richiede «scelte coraggiose di rinnovamento»: la pura difesa dell’esistente «non è sostenibile». Napolitano ha avuto parole chiare, sulla scuola. Non si tratta solo di incidere sulla spesa, né «di ripartire da zero ogni volta che con le elezioni cambia il quadro politico». L’obiettivo di un abbattimento dei costi – ha sottolineato – «non può prevalere su tutti gli altri», va invece formulato «punto per punto, ...