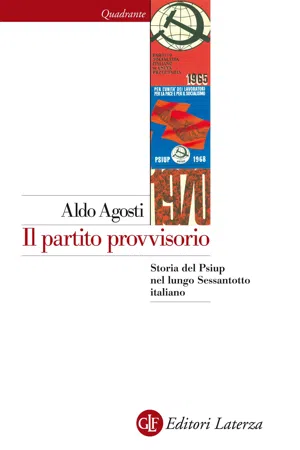1. Due partiti in uno
1. La tradizione di sinistra e il partito morandiano
Il Partito socialista italiano ha sempre avuto al suo interno una componente di sinistra, a più riprese prevalente, che ne ha fatto a lungo un’eccezione significativa nell’ambito del movimento operaio europeo. In un saggio ancora insuperato per acutezza interpretativa, Leonardo Rapone considera «il rapporto con le vicende del socialismo internazionale, la memoria storica del movimento italiano, le condizioni della lotta politica all’interno del paese» i tre elementi chiave per un’analisi storica di questa diversità. In effetti, anche a voler prescindere dalla svolta del 1911-12, che porta alla direzione del Psi un gruppo dirigente dichiaratamente antiriformista e provoca la prima di una lunga catena di scissioni, già allo scoppio della prima guerra mondiale la posizione del Psi si differenzia dal «socialpatriottismo» prevalente nella Seconda Internazionale per un richiamo forte ai valori dell’internazionalismo. E una marcata connotazione di sinistra caratterizza il socialismo italiano anche nella crisi del dopoguerra. Tra i primi partiti ad aderire all’Internazionale comunista, il Psi – diretto dalla corrente massimalista – indietreggia poi di fronte alla rinuncia alla propria identità che Mosca gli chiede, finendo lacerato da tre successive scissioni: il ceppo che sopravvive resta fedele però a un’immutata intransigenza rivoluzionaria, solo stemperata dalla riunificazione nel 1930 con il Psu di Turati e Treves, il cui riformismo gradualista è comprensibilmente reso inattuale dalla dittatura fascista. La leadership di Nenni – il quale ha sempre conservato un profilo più vicino al massimalismo che al riformismo – asseconda, già prima della comparsa di quel legame politico tra socialisti e comunisti che si concreterà tra il 1934 e il 1939 in un patto di unità d’azione, il ritorno a un orientamento classista e rivoluzionario.
Sempre più chiara emerge anche l’appartenenza del socialismo italiano a una specie particolare di «socialismo di sinistra» che ha nell’austromarxismo il suo centro d’irradiazione, con agganci significativi all’emigrazione menscevica russa e a correnti importanti del socialismo francese e spagnolo. Tale appartenenza è connotata da una triade di valori ben riconoscibili: un forte classismo, cioè l’individuazione nella classe operaia del principale fattore di progresso della società, investita della missione del suo totale rinnovamento; una predisposizione, come conseguenza di ciò, a stabilire rapporti unitari con l’altro partito della classe operaia, quello comunista, che persegue – sia pure con metodi diversi – lo stesso obiettivo del superamento del sistema capitalistico; e un robusto internazionalismo, fondato sia sul riconoscimento della Rivoluzione d’ottobre come grande fatto di emancipazione degli sfruttati e motore di una società socialista in costruzione, sia sulla fiducia nel ruolo giocato dall’Unione Sovietica nella sfida che contrappone sul piano europeo fascismo e antifascismo.
Questo modo di sentire non costituisce, fino alla seconda guerra mondiale, un’anomalia in Europa: pur rappresentando una posizione di minoranza, si inserisce nella dialettica tra le diverse anime socialiste e ne appare una componente del tutto legittima. Il fatto notevole è che, mentre dopo la guerra il socialismo di sinistra si dissolve come fenomeno internazionale, questi suoi principi ispiratori – ormai largamente incompatibili con l’orientamento delle altre forze del socialismo europeo – rimangono alla base dell’azione politica dei socialisti in Italia almeno per un altro decennio. Un tale radicamento e una tale continuità nella cultura politica e nella constituency sociale del Psi rinviano al secondo dei fattori messi in luce da Rapone, la memoria storica. In questa pesa certamente l’esperienza della dittatura fascista, e la coscienza che la divisione della classe operaia italiana le ha spianato la strada: ma un’esperienza simile e anche più drammatica ha vissuto il movimento operaio tedesco, che ne trae, alla fine, una lezione opposta. Conta quindi in Italia soprattutto l’influsso nel lungo periodo della tradizione massimalista, che durante il regime sopravvive, ripiegata su sé stessa ma forse più vitale di quella riformista, non esente da sporadiche tentazioni di compromesso con il fascismo. E i caratteri assunti dalla lotta politica in Italia durante la seconda guerra mondiale favoriscono «la permanenza e anche il rinvigorimento di quell’indirizzo radicale che plasmava la memoria storica del socialismo italiano». Il Psi, che è stato uno degli ultimi partiti a rompere con i comunisti dopo il patto tedesco-sovietico, è anche uno dei primi a riallacciare i contatti con loro fin dal 1941, e a rinnovare con il Pci un patto di unità d’azione nel 1943.
Quando nell’agosto di quell’anno riprende la guida del ricostituito Partito socialista in Italia, Nenni deve la sua investitura alle forze socialiste dell’interno, e tra queste non solo e non tanto alle più giovani e alle più radicali, provenienti dal Centro interno di Morandi, dal Movimento di unità proletaria di Basso, o dalle nuove leve giovanili dei cosiddetti «giovani turchi» (Corona, Vassalli, Vecchietti), quanto e ancor più agli esponenti della generazione più anziana, formatasi politicamente prima del fascismo (i Lizzadri, i Vernocchi, i Mancinelli), fortemente permeata di cultura massimalista. Durante la lotta di liberazione, gli equilibri politici del Regno del Sud e la presenza nel Comitato di liberazione nazionale di influenti partiti moderati collocano naturalmente i socialisti a sinistra: alle volte, sulle questioni istituzionali e di principio, addirittura più a sinistra del prudente realismo di Togliatti, anche se la preoccupazione di non rompere il rapporto con il Pci ha in Nenni sempre il sopravvento. Meno rappresentati degli altri partiti di sinistra nella resistenza armata al Nord, dove un gruppo dirigente di grande prestigio deve talvolta vincere le tendenze attendiste di una base sfiduciata e passiva dopo vent’anni di dittatura, i socialisti arrivano comunque all’appuntamento del 25 aprile come una forza di tutto rispetto, che si svilupperà fino a contare 685.000 iscritti alla fine del 1945.
Anche dopo la Liberazione la scelta classista e unitaria della maggioranza del gruppo dirigente socialista non solo viene confortata da un imprevisto successo elettorale, ma è sostenuta dalla larga approvazione dei militanti nel partito e nel sindacato, a dimostrazione del fatto che risponde alla sensibilità e alle aspettative di forze reali della società. Mano a mano però che si esaurisce la spinta della Resistenza e che, favorite dalle prime avvisaglie della guerra fredda, prevalgono nel ricostituito equilibrio del sistema politico italiano le tendenze più moderate, quella scelta di campo comporta una serie di prezzi via via più alti: prima la scissione di Palazzo Barberini, a cui concorrono peraltro componenti molto diverse, comprese alcune (come Iniziativa socialista) nelle quali il richiamo alla tradizione rivoluzionaria del socialismo italiano rimane ben vivo; poi, con la decisione tatticamente improvvida di presentarsi al voto del 18 aprile 1948 in una lista unica con i comunisti, una sconfitta bruciante, a cui segue un periodo di disorientamento e di divisioni profonde. Nel giro di tre anni, dalla primavera del 1946 alla primavera del 1949, il Psi vede addirittura dimezzato il numero dei suoi iscritti. Fallito il tentativo di Lelio Basso, nel breve periodo della sua segreteria, di ristrutturare su basi nuove il partito dandogli «una unitaria coscienza di classe, una compatta omogeneità ideologica, un’organizzazione capillare e al tempo stesso articolata», naufragata l’esperienza della direzione centrista di Jacometti e Lombardi, il Psi si presenta al XXVIII Congresso (Firenze, maggio 1949) «in una situazione che si era concordi nel definire una situazione caotica, di inefficienza organizzativa, di sbandamento dei quadri e dei militanti e di sfiducia nelle possibilità di ripresa del partito».
Da quella fase il Partito socialista esce attraverso una sorta di vera e propria rifondazione, che ripropone come segretario del partito Nenni, con il suo patrimonio di radicalismo classista plasmato dall’esperienza dei fronti popolari degli anni ’30, ma che ha il suo principale artefice in Rodolfo Morandi. Già leader del Centro interno socialista, l’unica rete clandestina socialista capace di un’elaborazione programmatica originale e di una certa consistenza organizzativa durante gli anni del regime, Morandi è stato sei anni in carcere e si è poi distinto come organizzatore e ideologo della Resistenza, arrivando a rivestire la carica di presidente del Clnai. Dopo essere stato ministro dell’Industria nei governi De Gasperi, si vota completamente alla riorganizzazione del partito. Fin dal 1944, egli avverte l’esigenza di dotare il socialismo italiano di un partito di tipo nuovo: e ne delinea allora le caratteristiche esplicitando la necessità che si differenzi non meno dal modello comunista – da cui devono distinguerlo la democrazia interna e l’indipendenza dalla politica sovietica – che dalla concezione socialdemocratica del partito, imperniata su un’organizzazione di tipo territoriale funzionale ai collegi elettorali, poco assoggettata ai vincoli di un’autorità centrale e troppo fluida sul piano ideologico. Ma nel momento in cui Morandi è investito della responsabilità della riorganizzazione del partito la situazione è profondamente cambiata: sul piano internazionale si è entrati nella fase più tesa della guerra fredda, mentre in politica interna lo scontro sociale raggiunge punte di asprezza senza precedenti e gli stessi spazi garantiti dalla Costituzione a...