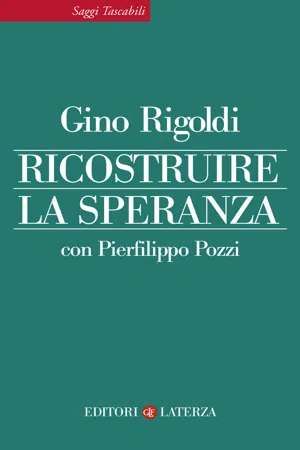1. Il seme del cambiamento
La prima tesi paragona la speranza cristiana con le speranze del mondo. Perché la speranza è un fenomeno universale, che si trova ovunque c’è umanità, un fenomeno costituito da tre elementi: la tensione piena di attesa verso il futuro; la fiducia che tale futuro si realizzerà; la pazienza e la perseveranza nell’attenderlo.
La vita umana è inconcepibile senza una tensione verso il futuro, senza progetti, programmi, attese, senza pazienza e perseveranza. Ma è pure intessuta di delusioni e quindi è permeata dalla speranza e anche dalla disperazione.
Carlo Maria Martini
Molti anni fa un ragazzino – corpulento e aggressivo – attraversò il portone del carcere minorile portandosi dietro una condanna per omicidio. Non solo aveva ucciso un uomo, ma, a dimostrazione di uno spiccato cinismo, aveva anche tentato di rivendere la macchina del morto. Come se la sua situazione non fosse già abbastanza grave, in carcere cominciò ad abusare dei nuovi arrivati, quelli con lo sguardo perso che non hanno ancora capito dove si trovano. Me ne accorsi – quando era presente lui l’aria era tesa, gli sguardi rabbiosi e impauriti – ed ebbi l’occasione di accendere un conflitto molto duro, rinfacciandogli le prepotenze e le cattiverie, rispondendo a tono alle sue violente rimostranze. Venne trasferito in un istituto con meno possibilità di movimento, visto che al Beccaria di Milano le celle sono aperte quasi tutto il giorno. Quando fu scarcerato, chiese di venire a casa mia e io lo accolsi, perché si deve ricominciare sempre, anche quando sembra che ci sia solo una tenue scintilla sotto la cenere. Incominciò a lavorare, ma dopo qualche mese ricevetti dalla Digos la notizia che aveva fatto una serie di rapine armato con un fucile a pompa, anche se scarico. Altro carcere, altro conflitto con me, altre promesse, e di nuovo a casa con me, per ricominciare. Intanto la sua fidanzata era incinta e stava per partorire due gemelli. Trovammo casa e vi si sistemò con la compagna e i figli. Andò di nuovo male anche in quella situazione. Seppi che aveva avuto ancora guai con la giustizia e non lo sentii più. Fino a due anni fa, quando mi ha chiamato, mi ha detto che voleva farmi sapere che ora stava molto bene, che lavorava e stava cominciando a ricostruire la sua famiglia, e che mi voleva bene.
Un po’ per fede un po’ per esperienza, ho buone ragioni di credere che la speranza debba essere l’ultima a morire, anzi non debba morire mai. È evidente che quando parliamo di speranza non parliamo di buone intenzioni, di desideri e di sogni, e nemmeno di illusione – che poi è la versione cinica di chi non è in grado di immaginare il mondo della possibilità. La speranza non è l’attesa di un miracolo, e nemmeno l’attesa di una vincita al gratta e vinci, come se potessimo affidare il cambiamento della nostra vita ad un biglietto comperato a buon mercato dal tabaccaio.
La speranza che io vivo tutti i giorni posso esprimerla con una domanda che mi faccio ogni volta di fronte a un problema, a una crisi, a un fallimento: «Come se ne esce?». La mia speranza è un atteggiamento che vuole produrre soluzioni creative, idee nuove, strade alternative per superare un ostacolo. Ed è sempre accompagnata dallo studio, dalla riflessione sull’accaduto, dalla ricerca dei punti dai quali ripartire, dal confronto con i compagni di strada.
La speranza ci spinge ad immaginare e progettare il futuro: per questo oggi, in tempi di crisi generalizzata – una crisi sociale ed economica che si somma alle difficoltà personali –, è necessario cercare di vivere testardamente nella dimensione della speranza. È una dimensione che per i cristiani poggia saldamente sulla fede nel Dio rivelato da Gesù, l’alleato con il quale mai niente e nessuno è perduto, ma che per tutti noi, credenti e non credenti, poggia sulla fiducia nell’uomo e nella sua capacità di poter essere amichevole e cooperativo.
La speranza nasce e cresce in compagnia, così come non si cambia e non si cresce da soli.
A partire dalle più intime convinzioni personali, la vita di ciascuno ha bisogno della comunanza con altri esseri umani. La nostra stessa nascita avviene attraverso e dentro la relazione con altri: in primo luogo con la madre, dalla quale riceviamo il primo sguardo, il nutrimento, l’amore. Ci troviamo a vivere in una società che propone pensieri e atteggiamenti collettivi – anche nella Chiesa succede un po’ così – e poiché in questo grande sistema sociale rischiamo di ripetere le idee e le scelte di altri, è necessario cercare una nostra comunità di riferimento, un luogo in cui le direzioni della vita vengono discusse, in cui la relazione con gli altri ci permette di costruire la nostra immagine, di rinforzare le scelte di vita, e dove gli affetti contribuiscono in maniera essenziale all’equilibrio della persona. Oggi più che mai la ricerca e la costruzione di una comunità di riferimento sono necessarie per avere cura della propria vita. La qualità della propria esistenza sta nella qualità dei rapporti e degli amori che scegliamo e costruiamo.
Ogni tentativo consapevole, voluto, desiderato, di cambiamento poggia sulla fiducia che sia possibile. Non è un tentativo a caso, ma una direzione scelta, un processo attivato. E il sottofondo di ogni nostro percorso di cambiamento è la speranza.
All’opposto della speranza c’è un pensiero, oggi piuttosto diffuso, che esprime sconforto, delusione, perfino disperazione. Sono proprio quei pensieri che impediscono di immaginare un’altra possibilità, una soluzione ai problemi e alle sfide che abbiamo di fronte. Uno dei deficit del mondo adulto è questa sfiducia, questa povertà di speranza, che io credo siano legate alle proprie povertà e ai propri insuccessi personali. Ma i giovani sono «nuovi», il mondo è grande, e possiamo sempre cercare risorse e intelligenze da riattivare. Molti adulti cosa stanno invece trasmettendo alle nuove generazioni? A me sembra che stanno dicendo loro che non hanno nulla in cui nutrire speranze. Il lavoro sarà sempre meno, il benessere della società occidentale non potrà che diminuire a favore di altri popoli emergenti, i quali però si troveranno a far fronte ai disastri ecologici provocati dall’eccessivo sfruttamento della terra. Li mettiamo persino in situazioni paradossali: diciamo loro che l’istruzione è fondamentale per il futuro ma, nello stesso tempo, sottraiamo sempre maggiori risorse alla scuola. Non vado oltre e lascio a voi l’eventuale proseguimento di questa lunga litania del pessimismo. Mi sembra evidente, però, che stiamo trasmettendo ai nostri figli e alle nostre figlie una profonda sfiducia in sé stessi; e anche in noi adulti, capaci solo di mostrare, impauriti, il baratro verso cui rischiamo di precipitare.
Se io fossi un ragazzo, non avrei tanta voglia di parlare con adulti piagnucolosi e impauriti, oppure rabbiosi e incattiviti con il mondo. Proprio per questo invito tutti noi a ricominciare a dimostrare amore per le nuove generazioni, fiducia nelle loro capacità e possibilità. Il rapporto tra generazioni di solito passa anche attraverso un confronto spesso aspro, critico, ma si tratta pur sempre di un dialogo. In questo periodo mi sembra che manchi, mi sembra che tra la vecchia e la nuova generazione ci sia assenza di dialogo.
È vero, a parziale giustificazione di tutto ciò c’è la storia recente, che ci parla di tempi di grandi speranze disattese: per i cattolici, esse erano riposte nell’annuncio e negli esiti del Concilio Vaticano II; per tantissimi giovani e lavoratori erano riposte nelle lotte per il rinnovamento sociale sfociate nella stagione del ’68. Poi è arrivato il tempo della delusione, e allora invece che interrogarci su come cambiare noi stessi e il mondo, ci siamo limitati a chiederci come continuare a vivere in una realtà che è sembrata più resistente al cambiamento di quanto avessimo creduto. Proprio per questo, con ostinazione, oggi dobbiamo ricominciare: se non recuperiamo la virtù della speranza rischiamo di trasformare il nostro cammino in una transumanza di uomini impauriti in attesa della tempesta.
D’altra parte molti amici e amiche vivono concretamente un ideale di società più giusta che li spinge ad una continua ricerca del bene comune. Persone normali che vivono la propria vita, ma capaci di testimoniare nei fatti una onestà incrollabile, la ricerca della giustizia, una grande generosità verso gli altri, soprattutto quando si tratti di persone povere o senza difese. Credo si possa dire che sono mossi dalla speranza, così come lo sono stati tutti i grandi eroi dell’umanità. Eroi per il loro impegno concreto e per il loro esempio, non perché figure mitiche e irraggiungibili. Penso a Nelson Mandela, che ha sopportato quasi trent’anni di durissima prigionia nel carcere di Robben Island, ma non ha covato vendetta, piuttosto la speranza di riuscire a riconciliare bianchi e neri del Sudafrica per ricominciare a vivere insieme. E, alleandosi con il vescovo Desmond Tutu, è riuscito a rivoluzionare pacificamente il suo paese, a vincere l’apartheid interrompendo la catena di violenza e a pacificarlo attraverso il Tribunale di verità e riconciliazione: chi, bianco o nero, confessava i propri crimini veniva perdonato, chi li negava subiva la condanna. Tutti i grandi eroi hanno lottato per la libertà e per la giustizia, e guarda caso sono proprio queste le figure che ancora oggi riescono a muovere positivamente l’immaginario delle nuove generazioni. Io ci metto anche Gesù, il cui fascino sta proprio nel suo umano impegno per la giustizia e per l’accoglienza fraterna.
Quando mancano questi riferimenti ci si ferma alla critica e alla lamentela, senza sapere quale direzione prendere. Mi sembra, in parte, la situazione dei giovani che da alcuni anni organizzano in tutto il mondo le proteste indicate di solito dalla parola «occupy» seguita dai luoghi simbolo dell’attuale establishment economico: sono arrabbiati, giustamente, però la loro protesta non mi sembra abbia ancora trovato la dimensione della speranza. Ma almeno è il segnale che le nuove generazioni non vogliono stare ad osservare passivamente il piano inclinato delle nostre società.
Solo nell’ultimo anno ho partecipato a decine di assemblee nelle scuole. I temi erano la giustizia, l’emarginazione, la dimensione spirituale e religiosa, la vita affettiva e l’amicizia. Centinaia di ragazze e di ragazzi attenti, pronti ad ascoltare, a fare domande conseguenti, perché quando capiscono di avere di fronte un adulto che parla onestamente proprio a loro e dice cose in cui crede veramente, loro ci sono e tirano fuori tutto l’entusiasmo di cui sono capaci.
I passi della speranza non sono poi così difficili da intraprendere. Occorre cominciare a cercare il bene che c’è in ogni persona, a guardare alle qualità invece che ai difetti, a incoraggiare piuttosto che a mortificare. Dobbiamo superare il morboso chiacchiericcio intorno alle debolezze altrui e considerare quanto di buono c’è nell’altro. A partire, naturalmente, dai nostri amici, dalle mogli e dai mariti, dai figli, dai compagni di scuola, dai nostri studenti. E da noi stessi, ovviamente. Se la speranza nasce in compagnia, allora dobbiamo avere cura della relazione con gli altri: la relazione nasce proprio quando si dà valore all’altra persona, è la convinzione, la certezza o la fede che una persona ha certamente una parte buona con la quale è possibile allearsi, intendersi. Dare valore all’altro e costruire relazioni non è un gesto isolato, è un processo continuo che si deve percorrere con determinazione e volontà. La relazione incomincia così. Richiede visione, ascolto, pazienza, sforzo per capire, capacità di accettare le persone così come sono per camminare insieme. Niente di nuovo: usiamo queste regole con tutte le persone che amiamo veramente. Si tratta solo di affinare una virtù che ha anche un altro nome: «amore». E non chiamatelo «buonismo», perché il buonismo non ha bisogno della sincerità, della giustizia, del riconoscimento e della condanna di comportamenti violenti, egoisti, discriminatori. Mentre l’amore sì. Ce lo ha mostrato proprio Gesù, capace di un amore che non rinuncia al conflitto.
La speranza, infine, non è vincolata ai risultati ed è più testarda degli insuccessi. È grazie alla speranza che molte persone hanno potuto cambiare vita, anche attraverso percorsi tortuosi. Il mio lavoro è costruire speranza, che nella pratica quotidiana traduco con «costruire progetti».